
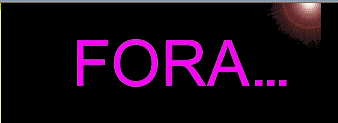
(scarica l'articolo in formato RTF o in formato PDF)
I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse
Lavoro sommerso: il frutto del divieto italiano a produrre
Si chiama così il mio paese, e non si sa bene se perché c’è nelle vicinanze una miniera di ferro (non più sfruttata, perché impoverita da estrazioni millenarie), o perché i suoi primi abitatori si fecero guidare sul posto da una stella (sider, in entrambi i casi).
Siderno è un posto di antica e recente civiltà, ultimamente portata alla barbarie dallo Stato italiano. La polis magnogreca di Locri Epìzefizi dista meno di sei chilometri, la città medievale di Gerace quindici di strada, ma solo quattro in linea d’aria.
Attualmente si compone di una città antica, risalente al Medioevo, alta sul mare tra i 200 e 300 metri, e di una Marina (le marine joniche, tra Reggio e Taranto, rappresentano una tipologia d’insediamento alquanto recente. Le più datate risalgono all’Età Borbonica, le nuove sono posteriori alle devastanti alluvioni del 1951 e 1953.
In Età Borbonica Siderno Marina veniva indicata commercialmente con il toponimo Retromarina (retro, rispetto a Gioia Tauro, sul Mar Tirreno, che era il più importante porto d’imbarco dell’olio esportato dal Regno. Dopo che è stata realizzata una galleria appenninica, due cittadine sono distanti appena 30 minuti di macchina,).
Ma anche Siderno fu un importante caricatoio dell’olio borbonico che partiva per mare. La Marina di Siderno sorse intorno a questo commercio e i suoi primi abitanti furono degli esportatori venuti dalla Sicilia, da Sorrento, dall’Amalfitano, nonché i contadini-pescatori che l’abitavano da secoli .e che il nuovo sviluppo trasformò in operai e marittimi.
Questa base economica fece di Siderno il più antico dei paesi socialisti della Calabria. Giacomo Matteotti volle paragonarla alla sua città e la definì "la Molinella del Jonio".
***
Da qualche anno si pubblica in paese un settimanale locale "Riviera" per il quale ho scritto qualche articolo, che la vanità mi porta a considerare d’interesse più ampio.
Con l’aiuto del caro Mino Errico li metto in Internet e li sottopongo al giudizio dei lettori.
Al tempo in cui ero un ragazzino, i sentimenti erano più semplici, quasi elementari, però molto più forti. Per esempio, la gelosia poteva arrivare all’assassinio, l’inimicizia, se non si finiva a coltellate, si perpetuava da padre in figlio, la famiglia era fortemente legata; i fratelli proteggevano le sorelle e a volte restavano scapoli per fare loro la dote; le sorelle ne cercavano la protezione e li accudivano; se uno dei genitori era prematuramente morto, i più grandi (o le più grandi) sacrificavano il proprio avvenire e rinunziavano al matrimonio per allevare i piccoli. Anche l’amore assumeva tonalità forti. Qualche volta prendeva la forma di un sogno, sublimato al punto da trascendere la stessa sessualità.
C’era meno danaro, e anche minor bisogno d’averlo. E non è difficile spiegarlo. Vigevano ancora gli scambi in natura. Il contadino pagava in grano o in olio l’affitto al padrone; il povero portava una gallina al medico che curava i suoi familiari; l’avvocato riceveva uova in cambio di pareri e consulenze; il calzolaio fabbricava scarpe in cambio di ceci e fagioli, i salari dei braccianti spesso venivano pagati in natura. E via dicendo.
Oggi tutto è danaro, o meglio scambio monetario. Non in tutti i casi i sentimenti possono essere sostituiti dal danaro contante e i vecchi sentiamo nostalgia del bel tempo che fu.
A Napoli e un po’ dovunque in Italia, i sentimenti diventano canzoni, cosicché l’anno scorso la simpatica Natascia ha allietato le nostre digestioni serali dinanzi al televisore facendoci ascoltare le note agrodolci di "Sesso senza amore".
E’ la canzone di un mondo che si spegne lasciando dietro di sé una scia di faville, come la stella cometa che passa ogni tanti anni sulle nostre teste. "Senza amore" non è solo il sesso, ma la gran parte delle nostre azioni. "Senza amore" è la morale dei nostri tempi e di quelli che si annunziano.
Vedo la televisione quasi tutte le sere, e le persone che vi appaiono più frequentemente è come se fossero miei conoscenti; gente con la quale vado a spasso, per svagarmi un po’. Amici d’infanzia. Compagni di scuola. Ma è uno svago "senza amore". Se si tratta di Michele Santoro o di Bruno Vespa, mi pare di stare assieme a due marpioni che vogliono prendermi per i fondelli. L’unica persona viva e vera che incontro, è Bossi. Infatti, ogni volta che lo vedo, mi girano tanto che una volta o l’altra sfascio il televisore.
Il Ciampi televisivo vorrebbe sventolare bandiere tricolori e cantare l’Inno di Mameli, ma ammoscia. Si vede lontano un miglio che è solo una parata. Berlusconi mi pare un professore che, dovendo finire il programma, sta spiegando una cosa che non sa. Se ha qualche amore, sicuramente non siamo noi di qua del video. Al contrario D’Alema pare uno addentro ad arcani saperi, che non può spiegare alla gente semplice come noi telespettatori. Persino il Papa, che pure dice cose umane (giuste, secondo le mie idee socialiste), pare stia parlando per un dovere d’ufficio.
Ricordo due podestà del mio piccolo mondo antico, che dovettero amare moltissimo il paese: l’avvocato Caridi, che si ridusse economicamente male, per voler dare troppo, e l’ingegnere Corrado che morì giovane, per svolgere una funzione che le condizioni precarie del suo cuore certamente non gli permettevano.
Se dovessi vivere il doppio del tempo che mi spetta di vivere, non credo che avrei la stessa malinconia e lo steso rimpianto per l’attuale sindaco di Siderno e per la nuova amministrazione. Per la prima volta nella lunga storia delle cose viste, ho l’impressione che al Comune abbiano preso dimora uomini freddi. Senza amore. Persino senza quell’eccitazione che pur deve presiedere al sesso "senza amore".
Spero fervidamente di sbagliarmi e d’essere costretto a rimangiarmi questo amaro giudizio.
Secondo la demografia, le generazioni si succedono una ogni 25 anni. Sulla base di tale metro, dal 1860 - quando fu unificata l’Italia - ad oggi, si sono succedute sei generazioni. Sicuramente la prova più dolorosa imposta ai meridionali dall’Italia unita, che aveva il suo confine più importante sulle Alpi, fu la Grande Guerra, allorché alle stragi fatte delle mitragliatrici, delle bombe a mano e dei mortai, si aggiunse quella della febbre spagnola che nel mondo provocò più di 20 milioni di morti. Le due generazioni di italiani che parteciparono a quella guerra erano state coinvolte nella miseria post-unitaria, cosicché una larga parte di loro aveva fatto già anni e anni d’emigrazione (18 milioni circa di italiani, di cui 8 milioni di meridionali, precisa il libro del giovane ricercatore Vittorio Daniele, Una modernizzazione difficile – L’economia della Calabria oggi, pubblicato proprio in questi giorni da Rubbettino; libro del quale mi occuperò più estesamente sul prossimo numero di Riviera).
Dopo la Seconda Guerra Mondiale gli italiani del centronord, che si papparano tutti gli aiuti del Piano Marshall. Si ritrovarono così a un livello di sviluppo in cui la necessità di emigrare si ridusse moltissimo; in sostanza ai soli veneti. Nel dopoguerra, il triste privilegio dell’emigrazione fu cosa nostra, di noi meridionali. Nonostante il prezzo pagato all’ "azienda-Italia", debbo dire che la mia generazione è stata fortunata: ha visto la "grande trasformazione", il passaggio del mondo occidentale dalla povertà al benessere. Anche se qui in paese il lavoro era poco, non fu poi tanto difficile e doloroso trovarlo altrove: al Nord, in Svizzera, in Germania.
Ancora meglio è andata alla generazione successiva, quella nata dopo la guerra. In Europa, nell’America anglosassone, in Giappone, detta generazione ha avuto ed ha più di quanto nessun uomo delle precedenti generazioni abbia mai sognato. Il fondamento dell’attuale ricchezza è la macchina, la quale moltiplica ed eleva all’infinita potenza il lavoro umano. La forza dei dieci milioni di abitanti di Bombay non basterebbe a spostare una petroliera da mezzo milione di tonnellate, eppure il motore che ne muove le eliche e la fa viaggiare a 45 nodi all’ora, non è più grande di due appartamenti di cinque stanze messi uno sull’altro.
In misura uguale e contraria, fuori dall’Occidente industrializzato, i nostri contemporanei con la pelle di un altro colore hanno patito e stanno patendo qualcosa di simile a ciò che è toccato agli ebrei nei campi di concentramento. Duemila anni dopo la profetica visione di San Giovanni, i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse si sono scatenati e cavalcano sui continenti extraoccidentali portando la malattia, la fame, la distruzione e la morte. In un mondo, come l’attuale, fatto di produttori di merci vendibili, questa gente non ha niente da vendere. Chi non vende non può comprare, cosicché, se non muore di Aids o di vaiolo, muore di fame.
Anche noi meridionali abbiamo pagato con la desertificazione produttiva l’iper-sviluppo dell’Italia centrosettentrionale e dell’Europa. Le nostre vecchie, piccole fabbriche sono crollate come case di fango, la nostra agricoltura è scomparsa, quasi come se nessuno avesse mai lavorato a piantare gli alberi. Oggi, abbiamo poco o niente da vendere, tranne le nostre braccia e la nostra materia grigia, che già si ritrovano ad essere poco richieste. Il settore commerciale va concentrandosi, meccanizzandosi e occupa sempre meno gente. Lo Stato è incline a privatizzare i servizi. Persino i commerci illeciti vanno localizzandosi altrove. Il corridoio che porta i meridionali al Nord si è fatto parecchio stretto. Se alla generazione che oggi ha 50/60 anni è andata bene, a quella che ne ha 30/35 va male già da parecchio. Peggio ancora sta andando ai giovani venticinquenni, se è vero, come è vero, che attualmente è considerata una fortuna trovare un lavoro a mezza paga, benché, pur di venire incontro ai giovani meridionali, lo Stato la integri per l’altra metà.
La Russia, l’Ucraina, la Cecenia, la Romania non sono tanto lontane. Nonostante si tratti di paesi ricchi per natura, sono precipitati dalle stelle alle stalle in pochi anni. E la cosa gravissima è che nessuno sa come intervenire. Negli anni sessanta e settanta la ricetta per guarire il Sud c’era. Il problema allora si concretizzò nel fatto che lo Stato fu costretto a scegliere se finanziare i capitalisti padani, affamati di liquidità, o industrializzare il Sud. Al contrario, oggi lo Stato non ha più soldi da spendere. Li hanno invece i capitalisti, ma loro, in quanto creatori di ricchezza (almeno così dicono i loro giornali), non hanno obblighi verso nessuno. Specialmente verso gli esseri umani.
Chi, nella sua vita, ha visto sgonfiarsi e poi svanire impegni e promesse a favore del Mezzogiorno, ha provato persino pena per lui, allorché l'onorevole Berlusconi, in televisione, ha recitato la sceneggiata del ponte sullo Stretto e delle ferrovie e autostrade meridionali. Lassù - a Milano - qualcuno - ingenuamente o furbescamente - ci ama? Forse sì, forse no, sta di fatto che non basta l'euro e la partecipazione all'Unione Europea, perché l'Italia stia nell'U. E. allo stesso livello della Francia e della Germania. Perché una cosa del genere si configuri, essa dovrebbe essere un paese compatto e ugualmente capitalistico in ogni sua parte, mentre, come tutti sappiamo, il capitalismo meridionale sta a un livello più basso di quello greco e di quello portoghese.
Il Meridione capitalistico può essere spinto più in alto? E se si, di quanto? E che tipo di iniezione bisognerebbe praticargli? Fingiamo che io non sia uno di coloro che vedono l'handicap allo sviluppo produttivo e occupazionale nel fatto che il Meridione sta sotto lo Stato italiano - dovendo la sua popolazione ubbidire a uno Stato che è il vero e potente suo nemico - e ragioniamo per un momento come se il Sud fosse effettivamente Italia.
Tra il 1961 e il 1967, La Malfa e i socialisti, arrivati al governo, intendevano passare dalla Cassa per il Mezzogiorno alla cosiddetta Politica di Programmazione Nazionale - secondo loro, un salto in avanti rispetto alla Cassa. L'on. Fanfani, che al tempo era un uomo politicamente già battuto e che tuttavia ancora veniva citato dai giornali, definì quel progetto un libro dei sogni. Si arrivò, comunque, a una concreta attività amministrativa, la quale prese il nome di Programmazione territoriale. Economisti, urbanisti, ingegneri, geologi e quanto di più vorace c'era nelle parrocchie politiche romane e milanesi, presero a studiare le realtà regionali. Dopo le prime analisi territoriali, il governo adottò una ferma presa di posizione: la devastante esperienza delle cattedrali nel deserto (in verità pagate non tanto dallo Stato munifico quanto dai privati più ardimentosi, o ingenui) non doveva essere in alcun modo ripetuta. L'ipotesi di un'industria per campanile venne severamente condannata. L'intervento sarebbe andato avanti per aree di sviluppo.
Ovviamente alla Confindustria (all'industria padana) non piaceva che lo sviluppo industriale del Sud facesse un solo passo avanti, cosicché i programmatori, per restare fedeli alle promesse verbali e ottemperare contemporaneamente agli ordini confindustriali, generarono dei corpi senza vita (concetto che può essere espresso anche con il termine aborti). Di questi aborti alcuni sopravvivono, per ri-abortire a ogni stagione governativa. Per esempio le aree di Gela-Siracusa e di Taranto, ma forse anche altre che, coperte dall'oblio, non ricordo più.
L'aborto aveva la sua pre-interruzione nel fatto che l'area di sviluppo veniva sviluppata con un'industria di base funzionale o servile rispetto al sistema industriale padano, che in tal modo poteva alleggerire i costi d'esercizio. I laminati per la FIAT, i derivati del petrolio per la Montecatini, e via dicendo.
Fra queste creature innaturali di un passato non ancora remoto, oggi sta in gambe soltanto l'area di Latina e la sua propaggine verso Roma (al tempo dei Borbone la zona del Liri, con le sue propaggini verso Napoli, una fra le più avanzate d'Italia). Ha retto per il semplice fatto che è stata eletta non dalla grande industria IRI, ma da medie e piccole industrie a capitale estero o nazionale: a volte con sede in loco, a volte quali succursali di industrie forestiere. Ma anche qui si respira l'aria delle cattedrali nel deserto. L'industria non tocca la collettività nel suo assieme, ma soltanto i lavoratori dipendenti. Insomma la stessa cosa che a Melfi, dove non c'è nient'altro che una colonia di Gianni Agnelli.
Il fatto è che la produzione industriale non viene dalla testa di Giove, come immaginano gli strateghi dello sviluppo e i giornalisti economici italiani, ma dagli uomini - i padroni e i dipendenti - i quali conoscono e sentono il proprio ambiente, e risentono dei suoi condizionamenti. Se in California si può sentire il cubetto di silicio, non è detto che la stessa cosa debba sentirsi a Napoli o a Trapani. Se a Napoli il sentire dei produttori, oggi porterebbe - poniamo - alla produzione di scarpe o alla torrefazione del caffè, e se a Trapani porterebbe alla conservazione del pesce, la stranezza è pretendere che a Napoli si producano telefonini e a Trapani refrigeratori.
Il Sud presenta un’elevata domanda di consumo. In una situazione del genere, un paese libero risponde immediatamente creando i suoi produttori (esempio, l'Irlanda). Al Sud ciò è impossibile perché sul mercato italiano, per ogni settore della produzione, ci sono già una o più aziende dominanti, e queste sanno come fare per mozzare la testa alle potenziali imprese concorrenti (le mozzarelle di bufale napoletane con marchio Galbani). I miei conterranei più vecchi ricordano come la Feltrinelli (compensati) fece strame della Primerano (compensati), attraverso un ben dosato intervento delle banche. A quanto sopra si può aggiungere che senza banca non c'è Industria. Ma la banca italiana è strutturata in modo che al Sud è presente solo per raccogliere i narco-euro, per effettuare il prestito di consumo e quello commerciale, mentre gli investimenti che comportino rischio li effettua al Nord, dove il rischio è sicuramente più grosso ma è tuttavia nazionale, patriottico (tipo Fiat).
Fallita trentacinque anni fa l'idea delle aree di sviluppo, il passato governo, ispirandosi al concetto veneto-emiliano di promuovere il piccolo, in cui l'inventiva e la versatilità sopperiscono a volte alla pochezza dei capitali, ha immaginato di poter fare, al Sud, grandi cose con pochi danari. Ha fatto, pertanto, intravedere la benevolenza dello Stato agli imprenditori veneti ed emiliani, onde spingerli al Sud.
Il progetto (o progettino) è chiaramente fallito. Romania batte Meridione per 100 a zero. Dopo il crollo del comunismo, gli investimenti fluiscono con una certa disinvoltura dove la curva dei salari parte letteralmente dalla fame (nera, anche se bianca di pelle).
A Tremonti, pianificatore del nuovo governo, non restava che il sommerso, e vi si è buttato. Ora c'è da chiedersi: oltre alla paura delle manette, c'è una qualche convenienza del capitalista in nero a emergere? Accetterà, questi, di pagare salari dignitosi e anche le tasse?
Intanto il capitalismo in nero opera in rami della produzione spontaneamente scelti (sentiti) dai produttori (padroni e subalterni), e non calati dall'alto. In secondo luogo, si tratta, più che d’industria, di artigianato meccanizzato, la cui forza sul mercato risiede nei bassi salari e nell'evasione fiscale e contributiva.
Non accetterà di diventare bianco e neppure grigio, ne sono certo. Quando le marche sul tesserino del lavoratore erano un vantaggio per lui, ma un piccolo costo per le aziende – caricata com’era l’assistenza sulla fiscalità generale - la buona nostra patria al Sud non si faceva vedere. Si presenta adesso che c’è da riscuotere. Guardando alle cose dalla parte dei lavoratori, c’è da dire che intanto è finito un clima. Gli Anni Settanta sono morti e sepolti con Luciano Lama. Non esiste, più, una forza politica e/o sindacale capace di spingere i salari in alto. Questi tendono a tornare al loro prezzo naturale, sempre più definito dalla fame.
Se non esistono le condizioni (specialmente una banca interessata a rischiare) perché l'impresa meridionale cambi se stessa in milanese; se la previdenza è saltata, e di essa restano soltanto i tributi; se è meglio un qualunque salario che la disoccupazione a vita, l’Italia deve fare il piacere di lasciar stare le aziende meridionali: quelle nere, quelle bianche e quelle verdognole. Non rifacciamo ciò che fece la legge Rognoni-Latorre con la mafia, sequestrando vigne e alberghi in Sicilia e spingendo i mafiosi a portare i loro soldi in borsa a Milano (dove né Rognoni né Latorre avevano la forza d’infilare non dico un piede, ma neppure un ditino).
Certo il potere politico può operare una rottura federalista non solo nel caso della scuola e della sanità. Sarebbe, sì, vero federalismo fiscale se al Sud gli oneri sociali e ogni imposta che percuota l'impresa fossero cancellati. Cosa che non significa che il Sud pagherebbe in proporzione meno tasse degli altri, ma solo che la fiscalità che colpisce la produzione dovrebbe andare a colpire i redditi al consumo.
Ripeto: volendo restituire una qualche libertà all'impresa meridionale c'è una cosa che potrebbe essere veramente utile e veramente federalista-fiscale: trasferire il peso fiscale che ricade sulle aziende sui consumatori.
Nicola Zitara
Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.