
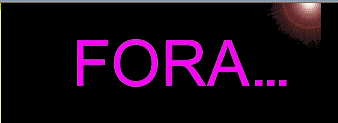
(scarica l'articolo in formato RTF o in formato PDF)
Al punto a cui si è giunti, bisogna riconoscere che l’unità d’Italia sarebbe stato meglio non farla. Quando sento la parola Governatore, mi viene in mente la Tosca e Scarpia, il governatore di Roma, che progetta di sedurla con il ricatto, e poi Mario Cavaradossi che canta: “Lucean le stelle/ stridea l’uscio dell’orto…” E in sequenza, Castel Sant’Angelo, i tamburi, le campane e il plotone d’esecuzione. Mazzini, Garibaldi, Cavour, il saggio Ferdinado II, l’orgoglioso Francischiello, l’intrepida Sufia, le camicie rosse, i bersaglieri, i briganti. Lutti, sciagure, saccheggi, stupri, morte.
L’unità? Un paese devastato, spogliato, umiliato, incarognito. Teorie interminabili, fiumi di espatrianti inerpicati sulle scale di un bastimento che porta all’America. E le canzoni accorate che si levano dal cuore di Napoli per accompagnare la fine di un popolo “sincero e felice”; per salutare il sole che tramonta nel mare oceano, dentro la spuma che disegna la scia della nave.
In questi anni l’Italia, che pareva risorta, muore nuovamente. Non tutta. Solo questa parte della Penisola aggregata al destino dell’altra, sottomessa al comando di capi emersi lì, per la gloria lumbard. In questo passaggio epocale, in cui uno Stato muore e ne sorge uno diverso, nel quale il Sud è collocato come alieno, per ottenere il risarcimento dei danni, servirebbero dei guerrieri, Manfredi, Melo di Bari, Ettore Fieremosca, Fabrizio Ruffo, gente di coraggio e di branca, e invece Roma ci manda dei preti che ci somministrano l’estrema unzione e ci cantano il misere nobis.
Vorrei ricredermi, ma quando vedo in televisione la faccia di Agazio Loiero, e sento la sua vocetta petulante, da cilonaro scacciato dal fondo, mi assale un dolore antico, in senso d’impotenza. Mi sembra di stare sulla scena di un teatro a raccontare barzellette che non fanno ridere nessuno, oppure inginocchiato sul Golgota, al cospetto di Cristo crocefisso, e invece di piangere per il suo martirio infinito, di stare lì a ridere per le contorsioni del Cattivo ladrone.
La primavera scorsa ho letto un libro del futuro Governatore. Niente da ridire, un libro come un altro. Ma è certo che con quelle idee astiose, micragnose, da piccolo litigio costituzional-cagone il Sud non si salva, né si salva nessuno di noi. Tempi antichi, lontani. I principi di Bisignano, usurai genovesi e creditori del re di Spagna, ebbero la Calabria in feudo. Qui giunti, imposero un’accisa di venti carlini su ogni rotolo di seta lavorata. L’artigianato serico calabrese, secolare opera dei monaci basiliani, il migliore del mondo, vera e consistente ricchezza della nostra terra, andò sperso dovunque, da Roma a Como, da Lione a Parigi, da Londra a Stoccolma. Tommaso Campanella, il suo coraggioso inno alla libertà degli umili, i suoi quarant’anni di cella. Nessuno ci salva. Non certo l’erede di Chiaravalloti.
E ancor peggio sarebbe un nostrano Masaniello.
Sabato scorso sono andato all’assemblea dei Democratici di sinistra. Credevo di trovarvi gli umori e le impazienze delle vecchie assemblee di partito, quelle che un tempo erano i luoghi e i momenti in cui l’asino proletario, che in altri momenti i dirigenti tiravano per la cavezza, si lasciava andare alle sue insofferenze, ai suoi odi, al suo gusto di essere, di comunicare, di inveire, di progettare. Invece vi ho trovato un sopore prodiano, amatino, fassiniano, bersanino. Un odore di risciacquatura dei piatti, dopo un abbondante piatto di tagliatelle alla bolognese. Una periferia dell’insulsa Bocconi. Il popolo esiste?, non esiste? Forse sono soltanto i principi di Bisignano a fare l’opposizione ad Arlechino Ridens e al suo tramontato Tremonti.
Il popolo? Ognuno di noi è un mondo, ha una sola vita, che non si ripete né in terra né in cielo. Nasce per essere un uomo, una donna; per dare e avere rispetto, per dare e avere felicità, per faticare per sé, per i figli e i nipoti; per dare e ricevere amore, conforto nella dolorosa lotta con la nostra stessa natura, pietà per l’inesorabile trascorrere dalla vita alla marte. La società, la nazione, l’ordinamento giuridico, le chiese non dovrebbero avere altre funzioni che queste.
Non si può e non si deve perdonare l’oltraggio all’uomo; non ci si può rassegnare. Non è vero che il mondo è fatto così e non si può cambiare. Il mondo è quello che noi proiettiamo in cielo. I sogni inconfessati. Le speranze irreali. La fede, si dice. Il credo. Il nostro anelito a essere umani, immagine carnale e morale di Dio.
La Calabria non è una scheggia impazzita del mondo. Pazzi sono coloro che pensano così. E’ la nostra casa, il nostro tetto, il tessuto umano in cui siamo nati e cresciuti, il luogo dei nostri simili, l’officina in cui versiamo la nostra fatica, la forgia in cui battiamo il nostro pezzo d’opera, la nicchia in cui ricoveriamo la famiglia, i figli, i padri, le madri. Allora bisogna proteggerla dalle insidie che vengono da ogni parte. Anche dalla nostra stessa bonomia o indifferenza. Le nostre armi debbono essere la ragione ragionante e l’azione conseguente.
Come insegnava ben 400 anni fa il nostro corregionale Antonio Serra, un precursore del pensiero economico moderno, la nostra terra deve produrre, onde vendere e comprare. Dare a Cesare quel che è di Cesare per dare a Dio quel che è di Dio. Per poterlo fare deve liberarsi (o essere liberata) dall’ossessione che ci sono interessi forestieri da rispettare.
Troppo abbiamo pagato. Semmai è l’ora dell’altrui gratitudine. Il primo atto del socialismo che rinasce è la liberazione dei nostri lavoratori dalla servitù forestiera, l’indipendenza politica. Non ci serve chi ci lega allo Stato italiano, qualsiasi il Palazzo romano in cui è collocato il simulacro e quali che siano i colori che sventola; ci serve, invece, chi ci divide dallo Stato italiano e dalle sue merci invasive, pagate due volte, che massacrano le nostre possibilità di lavoro e di scambio, le nostre famiglie, i nostri figli, le generazioni che verranno. Ingenuamente, per mal riposta fiducia negli altri, abbiamo pagato a Caporetto e altrove con un fiume di sangue.
Adesso basta con il farsi pigliare prima per fessi, poi per inetti e alla fine farci ridere in faccia dal primo Bonolis a cui capitiamo davanti. Rimettere i paletti sulle frontiere millenarie e custodirle. Rifondare e difendere la nostra agricoltura, la nostra manifattura, la terra, il sole, il mare che Dio o il caso ci hanno assegnato. Ritrovare la nostra solida cultura, l’eredità ancestrale che l’Europa barbarica, nel suo ingordo dilagare, ha travolto. Non ci serve il prescelto di concistori partitocratici, ci serve un eletto del Signore, un predestinato, si chiami esso David o Mosè o Aristide o Sartorio o Spartaco, o solo Carmine Crocco, ha poca importanza.
La storia della Regione Calabria va divisa almeno in due ere: una dal 1970, anno di fondazione, fino al 1988/90 circa, in cui la funzione dell’ente fu quella di ingaggiare un vaniloquente esercito dedito a nulla fare, tranne che ripartire fra amici, parenti e affiliati al partito assessorale i pochi soldi che Roma inoltrava.
E’ celebre un aneddoto che risale a quegli anni. Giacomo Mancini e altri notabili calabresi si presentarono in deputazione al presidente del consiglio, che al tempo era Giulio Andreotti, a reclamare aiuti a favore delle infelici popolazioni calabresi. Per prima cosa richiesero aiuto per l’agricoltura. Andreotti ascoltò con la serietà del caso e alla fine, aperto uno scartafaccio che teneva sul tavolo e toltisi gli occhiali da miope, prese a recitare: “C’è la legge XY che eroga fondi di sostegno agli agricoltori, ma la Calabria non ha chiesto niente.
I rappresentanti calabresi, profondamente umiliati, girarono il discorso sul tema industria. Andreotti ascoltò, poi aperto il solito scartafaccio e toltosi, come prima gli occhiali, cominciò a leggere. C’è la legge MN. Molte regioni hanno presentato dei progetti, ma dalla Calabria non è arrivato niente. C’è poi la legge SS, ma dalla Calabria non è arrivato alcunché. C’è infine la legge sulle aree urbane, ma in Calabria non si è deciso niente. Solo alberghi, costosi alberghi sul mare. Un albergo calabrese costa cinque volte che sulla Costa Azzurra. Speriamo, almeno, che arrivino i turisti.
La seconda era è quella del ricatto del governo centrale e della Unione Europea. Se volete soldi, mandateci un valido progetto di spesa. La Regione comprò le macchine da scrivere, le calcolatrici, i computer, pagò degli esperti affinché funzionari imparassero a farli funzionare, e quando tutto fu pronto, gli assessori dissero ai trecento direttori generali: “Scrivete”. Uno scrisse sugli amori di Garibaldi, un altro trattò della politica estera di Cavour, un terzo, esperto di letteratura, commentò gli scritti patriottici di Vincenzo Padula, un quarto dedicò la sua bella prosa alle imprese internazionali di Gigi Riva.
Dall’Europa risposero che quelle cose già le sapevano, che mandassero almeno un progetto su come lavare le olive appena raccolte. Un vero panico percorse le viscere di Palazzo Europa. Qualcuno sostenne che le olive bisognava lavarle con l’acqua di Colonia, un altro, figlio di un farmacista, portò la formula del perborato di potassio, la signora Vinciguerra, direttrice generale del dipartimento agricoltura e deforestazione, disse che occorreva la varechina. Con tanta sapienza in giro non si riusciva a venire a capo di niente. Finalmente don Ciccio Battifiacca, ex guardia cimiteriale di Belvedere Celeste e ora ragioniere capo dell’assessorato alla cultura della cipolla, portò in Giunta un vecchio libro del 1755, in cui un certo Domenico Grimaldi della Piana sosteneva che le ulive appena raccolte si lavano con l’acqua. La cosa apparve dubbia, in quanto risalente all’età dell’odiato borbone.
Alla fine si decise d’interpellare il prof. Mario Monti rettore dell’università Bocconi. Questi prese del tempo, studiò a fondo la cosa, mandò garbatamente prima la parcella e poi sentenziò che l’acqua andava bene. Ma doveva essere acqua pura, sgorgata dalle sorgenti alpine.
Appresa la cosa, fu avviato un progetto europeo per l’acquisto di tre milioni di ettolitri di acqua Padangreppia, a lire 300.000 al bidone. L’Europa, munifica, finanziò.
Il successo indusse gli assessori a cooptare degli illustri calabresi residenti tra Roma e Milano. Ne arrivarono tanti, tutti bravi. Più bravo si rivelò essere il presidente dell’Associazione Romana Senza Di Noi Non Si Muove Foglia. Questi mise in movimento tutto, specialmente le cartacce che danzano per Catanzaro, la sera, quando dalla Sila scende un venticello spazzino. Fece, disfece non stancandosi mai.
Tutto ciò che stava sotto il cielo calabrese, tutto quello che stava sopra il cielo calabrese e tutto quello che percorreva il ventre della terra calabra, fu mosso e rimosso con tale frenesia che, alla fine, si ebbe l’impressione che non si fosse mosso niente. Tutti l’amarono, ed anche lui si amò. Innamoratosi di sé stesso, come Narciso, e morì affogato in una vasca vuota, creta appositamente per non portare l’acqua alle sudicie popolazioni luogo.
Le due ere, di cui sopra, sono finite. Adesso ha inizio la Quarta Guerra Cartaginese. Brenno Calderolo, figlio Miglio Coniglio e fratello di Umbriaco Bosso, sta scendendo con le sue legioni insubriche dalle Alpi verso il Mediterraneo. A difesa del Sud, il Senato Romano ha deciso di mandare, in alternativa, o un Re Travicello Azzurro o un Re Travicello Rosso Bianco e Verde. E non v’è dubbio di sorta che i calabresi tributeranno loro gli onori del trionfo sia all’entrata sia all’uscita della Via costruita da Publio Popilio Lepore nel 131 ante Christum natum.
I Brutti, detti anche Bretti o Bruzzi, decideranno per chi dei due votare
Ai sensi della legge n.62
del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e
del web@master.