
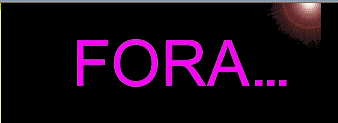
(scarica l'articolo in formato RTF o in formato PDF)
Avevo sospeso per lavorare a un tema che ritengo cruciale per capire attraverso quali passaggi è avvenuta la colonizzazione padana del Sud. Alcuni sono clamorosi, e se non noti a tutti, sicuramente intuibili da tutti. Altri restano ignorati, e non perché ignoti, ma in quanto volutamente taciuti o travisati per salvare la faccia a quei furfanti che dettero vita ai primi governi dell’Italia unita. Fra questi passaggi è d’importanza cruciale la conversione delle monete d’oro e d’argento degli Stati preunitari in lire cartacee di una banca privata ligure, che nel giro di soli cinque anni si ritrovò ricca e potente senza avere investito una lira di suo. Risultato: un favoloso quanto ingiustificato arricchimento di Genova, Torino e Milano ai danni degli imprenditori e delle popolazioni meridionali, che non ebbero altra scelta se non quella di emigrare a decine di milioni. I lettori troveranno qui di seguito il riassunto del libro, che steso per la rivista Indipendenza (Roma – Laurentino c/p 15321).
Ma veniamo a quel che è accaduto in quest’anno di silenzio. Lo scivolone del Sud verso l’annientamento della sua penultima identità, quella assistenziale, avviato a partire dal 1991/92 - da quando cioè il capitalismo padano ha deciso di prepararsi a entrare nel sistema monetario europeo, caricandone, logicamente, i costi sulle classi povere - è continuato a velocità raddoppiata nell’ultimo anno. E’ una legge di fisica che la massa d’urto di un corpo che precipita si carichi di potenza deflagrante per effetto del peso e della velocità. Il cozzo finale sarà come una bomba. Il crollo del Sud trascinerà con sé l’intera Italia.
La consorteria bancaria e industriale padana, che fa capo a Carlo De Benedetti, Gianni Agnelli, Eugenio Scalfari, andata al governo dieci anni fa con i proconsoli Amato, Prodi, Ciampi, D’Alema e Visco in appendice (o forse è meglio dire in appendicite cieca), pur di entrare in quest’Europa industriale alla quale il Sud non ha altro da vendere che i capperi e il mare inquinato, ha portato il tasso di disoccupazione dei meridionali dal 25 al 40 percento. Bloccando i salari, gli stipendi e le pensioni - con l’assenso di quel Cofferati che oggi agita la piazza per una cosa certamente giusta, ma che non ci riguarda - sottraggono il pane a famiglie in cui già manca il lavoro. Contemporaneamente, nelle città industriali è stata lasciata briglia sciolta ai padroni di casa, con il risultato che l’emigrazione dei meridionali a Melano – che bene o male era uno sfogo alla disoccupazione - è stata stroncata. Adesso il Berlusca ridacchia, impettito e compiaciuto. Rutelli finge d’essere aggrondato, ma non capisce niente di niente. Nelle famiglie meridionali si piange. Mentre il super-stipendiato Ciampi canta l’Inno di Mameli e sventola il tricolore con dei calciatori da 50 miliardi il pezzo, i padri e le madri di famiglia sbattono la testa contro il muro. L’ENEL, l’Ital-gas, Telecom, la RC-auto, l’ENI, le banche padane si stanno mangiando tutto. Inoltre il federalismo fiscale ha messo con il culo per terra i comuni meridionali. La classe politica locale, per tentare di sopravvivere, in quanto classe ben pagata, carica il proprio sostentamento sulle bollette dell’acqua e della spazzatura. Ci sono paesini di Calabria in cui i tributi comunali sono più pesanti che a Roma e Milano..Dal canto loro le Regioni, che non intendono perdere il sostegno elettorale del personale delle ASL - un’autentica armata di galoppini, per giunta inefficienti come sanitari e insopportabilmente arroganti come pubblici impiegati – stanno ballando sulla pancia dei contribuenti.
Il Sud è al disastro. Industrie non ci sono più sin da quando i Borbone furono cacciati via, l’agricoltura se l’è liquidata la Comunità Europea, nell’impiego pubblico posti non ce ne sono più, chi ha avuto ha avuto. Ci si sbraccia a parlare di turismo, ma la verità è che il mare fa schifo. Per sventolare la bandiera azzurra della "goletta verde", i sindaci meglio ammanicati la piantano sulla merda. I posti più belli, quei costoni di collina resi aridi dal dilavamento pluviale, in cui cresceva la ginestra assieme a bassi cespugli profumati di selvatico, sono diventati il cassonetto della spazzatura delle industrie dal Nord. Che sia poi la mafia a portarli, è un alibi alquanto facile. E se è vero, come è vero, non è poi questa la cosa peggiore. Sozzi per sozzi che ci tocca essere, almeno qualche soldo rimane qui.
Gli stipendi e le pensioni danno quel poco di ristoro con cui le famiglie meridionali partecipano più o meno al benessere nazionale. Seppur ridotti dal blocco decennale di cui sopra e ultimamente dall’inflazione euro-galoppante (l’Istat è come quelli della parabola, ha occhi per non vedere), sono ancora l’asse intorno al quale ruota la vita del Sud. I nonni mantengono ancora i figli e i nipoti. Però la generazione fortunata subisce anch’essa la legge di natura e pian piano si assottiglia.
Quanto durerà ancora? In teoria fino all’esaurimento delle persone entrate a lavorare prima della riforma pensionistica. In pratica le cose stanno in modo alquanto diverso. La massa dei pensionati meridionali viene dalla scuola. E la scuola, da più di vent’anni, assume pochissimo personale. Man mano che muoiono gli insegnati in pensione, l’ammontare complessivo delle pensioni al Sud non viene integrato dall’inserimento di un nuovo arrivato.
Diminuzione del potere d’acquisto di una pensione, più diminuzione del numero delle pensioni, uguale restringimento del circuito virtuoso pensionistco.
E’ non sarà questa l’unica fonte di crisi. Già le Regioni meridionali non hanno i soldi per pagare i medici e tutti i nullafacenti regionali. Appena i soldi finiranno del tutto, Mameli andrà di botto col culo per terra. Sarà il "si salvi chi può"; "l’affondamento del Tinanic," come ha detto l’illustre mio corregionale, onorevole Marco Minniti, uno fra i televisivi protagonisti delle citate scelte eurolandiche.
Mentre il Sud si ritrova, ogni giorno che passa, più impotente del giorno prima, le grandi aziende, che dominano il mercato, rincarano i prezzi. Quando entro nel supermarket a fare la spesa, e osservo i nuovi prezzi, mi torna in mente la nostra infelice storia, quando i re angioini e aragonesi, non riuscendo a pagare i debiti contratti con gli usurai fiorentini e genovesi, gli cedevano il potere di riscuotere le tasse del tempo. Non ricordo bene quale fu il re che cedette agli Spinelli la tassa sulla produzione della seta e sui tessuti di seta. Ma ricordo bene d’aver letto che questi illustri signori venuti da Genova, con le loro esosità, trasformarono la Calabria, che a quel tempo riforniva l’intera Europa di drappi, in una terra desolata. I manifattori calabresi dovettero fuggire e cercare rifugio altrove, a Milano, a Como, a Venezia, a Lione, a Londra, a Stoccolma.
Ma non solo i nuovi prezzi. Un nuovo feudalesimo lo vanno introducendo la Findomestic, la Ducato e altre cento finanziarie toscane e lombarde che si stanno allargando qui. Se spendi cento euro per un videoregistatore, quindici di soprattassa spettano a loro. Se le rate sono 24, di euro gliene spettano trenta, e se sono 36, gli euro che incassano diventano 45. Sempre su cento che hai speso.
Di questo passo, pagheremo tutto al doppio, come facciamo già da tempo immemorabile con il nostro garbato Gianni nazionale, senatore a vita per la sua dedizione a spogliare la gente. Se le banche milanesi ci fanno credito con i nostri soldi, pappandosi consistenti interessi, almeno qualche spesa la fanno qui. Palazzi propri o presi in fitto, impiegati del luogo, addetti alla pulizia del luogo. Invece le finanziarie, che al terzo giro lavorano gìà con i nostri soldi, hanno usanze spartane. Ingaggiano un agente, e le spese finiscono lì. Il profitto va tutto a Firenze, a Lucca, a Siena.
Non so se esista la versione bancaria dell’Inno di Mameli, ma il nostro presidente può star certo che è inutile pagare orchestre e fanfare: l’unificazione d’Italia l’hanno già fatta le banche centoquarant’anni fa. Adesso la ribadiscono le finanziarie. L’unica cosa ancora incerta è cosa vorranno alla fine, quando non avremo più modo di pagare. Il culo glielo abbiamo già dato. Cosa mai gradiranno in futuro?
Quando si dice le due Italie! Mentre noi siamo al punto che, se una finanziaria non ci finanzia l’acquisto, noi andiamo in giro senza calze e senza mutande, i frequentatori del salotto buono del capitalismo italiano si sono pappate, praticamente gratis, le aziende pubbliche pagate da quattro generazioni di italiani (residenti ed emigrati), i quali, appunto per pagarle, hanno stretto la cinghia fino a rompersi la spina dorsale. I telefoni, le banche IRI, inclusa Mediobanca, tutta l’industria siderurgica e tutta l’industria meccanica, le maggiori industrie alimentari, larga parte del patrimonio edilizio sono già volati via. Lo Stato ha incassato meno di un decimo del loro valore, dicono 200 mila miliardi da una massa di beni in cui la sola Banca Commerciale valeva un milione di miliardi. Ma non è finita. Da qui a non molto saremo chiamati a pagare, per la quarta volta nella storia d’Italia, la ri-ri-ri-ri-strutturazione della Fiat. Da New York, dove si è recato fingendo di star male, Agnelli piagnucola che l’abbiamo rovinato. Così, dopo aver venduto la FIAT alla General Motors, incassandone il valore, per consolarlo della perdita, il giorno della Befana, gli regaleremo l’ENEL, poi il giorno dei morti, quando in Sicilia si fanno i regali ai bambini, gli daremo anche le Ferrovie e i porti. Preliminarmente chiudendo quello di Gioia Tauro, che tanto fastidio dà all’intero firmamento dei big padani. In compenso questi signori ci daranno l’acqua, ma sicuramente al prezzo del vino, in più metteranno un ticket sui WC, cosicché torneremo a farla in spiaggia, come accadeva prima del miracolo economico e del suo assistenzialistico prolungamento terrone.
L’avvento del Berlusca e degli incomprensibili suoi soci, il Fino e il Bottiglione, ha riscatenato il peggiore clientelismo, l’arrembaggio alla cosa pubblica con il coltello fra i denti e la bandiera nera dei Fratelli della Costa in cima all’albero di mezzana. Al Sud, il magna-magna ha raggiunto livelli di eccellenza. Emilio Colombo, non ancora defunto, Riccardo Misasi, buonanima, Giacomo Mancini, buonanima, e tutti gli altri illustri deceduti o sopravvissuti ai tempi loro, che il vortice della storia e le alterne vicende delle umane sorti ci avevano fatto dimenticare, sono ampiamente superati.
In un barbaro borgo del Sud, un signore ha aperto, in luogo periferico, una scuola privata intitolata a G. Leopardi. Interpellato da un cafone del luogo circa il significato della lettera puntata, il nostro impresario dell’educazione ha dato la seguente estensione: Giuseppe. Questo patrocinatore di Giuseppe Leopardi non solo arricchisce distribuendo ignoranza, ma è anche Consigliere Provinciale, uscente ed entrante. Mercé il suo intervento fattivo lo spiazzo antistante a un edificio scolastico intitolato a Pitagora (per fortuna l’illustre filosofo e matematico non aveva un cognome), dove anche i più scaltriti fra i miei compaesani supponevano che prima o poi sarebbe sorto un giardino (o forse un campo di lattughe), è stato asfaltato onde consentire ai professori, al preside, ai bidelli e agli alunni, di scendere a salire in macchina senza sporcarsi le scarpe. E poi si sostiene che siamo ancora molto indietro quanto a civiltà!
Meno male che è stato rieletto. Qui il vero pericolo non solo i già arricchiti, ma quelli che ancora debbono servirsi.
Gli intrallazzi sono garantiti dalla nostra Costituzione materiale, come dimostra il problema dell’acqua in Sicilia. Le dighe sono state costruite da decenni, ma non per dare acqua agli assettati. La loro funzione sociale era quella di ri-fottere allo Stato i soldi che lo Stato ci fotteva. Ovviamente non c’è identità tra fottuti e fottitori. Lo Stato fotte chi lavora, mentre il diritto di rifottere lo Stato, lo stesso Stato lo ha conferito a chi rappresenta il popolo sovrano.
Il prossimo fottisterio ha un nome da tempo: si chiama Ponte (maiuscolo) sullo Stretto (di messina, minuscolo va bene, mica è in serie A!). Una cosa che non serve ai siciliani, che non serve ai calabresi, che non serve agli inglesi, francesi e tedeschi che si recano in Sicilia per fare il bagno tra una discarica abusiva e l’altra, magari con effluvi di uranio provenienti dai fondali. Si farà, ma è prevedibile che come l’autostrada Reggio-Salerno resterà chiuso per 350 giorni l’anno. Infatti non è destinato alla viabilità, serve (è già servito) solo a spendere decine di milioni di euro, parte in cemento, parte in mazzette.
***
Il problema non si esaurisce nel tema classico: timeo Danaos et dona ferentes, motto che si traduce: temo i Greci (in effetti i magnogreci) quando portano doni. Da più di duemila anni, supponendo di essere gli unici furbi della terra, immaginiamo di rifottere ai padroni quel che loro ci hanno fottuto. Ma i conti sono sbagliati. Nonostante i Danaos temuti, i Romani tolsero anche il respiro ai greci d’Italia. Il tema va dunque capovolto: noi meridionali, quanto più aiuti e assistenza riceviamo, tanto più diventiamo bisognosi d’aiuto e d’assistenza. La dipendenza dall’esterno cresce. E non si tratta di un problema di moralità sociale, o popolare che dir si voglia.
Chi lotta per il Meridione chiedendo allo Stato, lotta contro il Meridione e i meridionali. La lotta per noi, per il nostro popolo consistente nel batterci per non chiedere e per non avere. Se ci liberemo delle loro cose, delle loro merci, dei loro soldi, saremo liberi. Al contrario, se continueremo sulla strada dell’intervento pubblico, della Cassa per il Mezzogiorno, del presidente della Regione che va a Roma per incontrare i ministri della Repubblica, ci ritroveremo in tre: noi, l’Inno di Mameli e la fame che ci stringe allo stomaco.
Bisogna essere umili, avere l’umiltà d’imparare dagli altri. Cerchiamo di studiare quello che hanno fatto i veneti in questi ultimo quarant’anni. Sono partiti da una situazione dura quanto la nostra, ma hanno superato tutte le altre popolazioni italiane senz’altro aiuto che quello dei loro parroci.
La lira degli intrallazzi
1 - Nei mesi che ne hanno preceduto il decesso, le celebrazioni della lira si sono sprecate. Tanti rimpianti sono un atto dovuto a uno strumento abilmente affinato dal sistema di potere toscopadano per colonizzare le regioni meridionali. Un potere diverso da quello dello Stato, invasivo della società economica e più in generale della società civile. La violenza legalizzata dello Stato sabaudo, i bersaglieri, i carabinieri, i cavalleggeri - la faccia visibile e immonda della conquista militare – non furono il peggio. Il peggio fu la lira, strumento mistificatorio con cui il sistema padano realizzò il drenaggio delle risorse disponibili nel Meridione conquistato, determinando il completo annichilimento delle sue capacità produttive, l’impaludamento di contrasti sociali vecchi ormai di un secolo e squinternamento della morale pubblica, che già faceva acqua da più parti. Che, poi, gli inni patriottici siano cantati in coro anche dai giornalisti e dagli storici meridionali, nessuna sorpresa. I cosiddetti intellettuali meridionali furono giudicati da Gramsci i portatori di una cultura cosmopolita. Ma Gramsci viveva a Torino e li conosceva poco o niente. Li conosceva certamente meglio Gaetano Salvemini, che nel Sud non c’era solo nato. L’epiteto di ascari, da lui coniato per i politici meridionali, va esteso agli intellettuali. L’idea di un loro cosmopolitismo, che aleggia nella letteratura storico-politica per demerito di Vincenzo Cuoco e di Benedetto Croce, è un’autentica fandonia. L’intellettuale meridionale è profondamente immorale. Vuole vivere more nobilium, e pur di poterlo fare è disposto a vendere il padre e la madre. Il suo cosmopolitismo è fatto di ciance; ben lo capì Marx, che ne colse l’animo meglio di chiunque, e forse dovette capirlo anche Bakunin, che dietro all’illusione di una rivoluzione napoletana spese anni di passione politica. Un tempo io pensavo che qui ci fosse, non dico una visione nazionale e mondiale dei problemi – sarebbe stato troppo - ma almeno una sensibilità verso le cose che erano più vaste del nostro piccolo. Naturalmente m’ingannavo. Il mondo, la nazione, le idee politiche, da noi, sono mere etichette che servono a coprire meschine lotte per il comando locale, spesso litigi fra famiglie agiate, ancor più spesso uno sfacciato cursus disonorum al servizio di un sistema, che chi governa l’Italia ha istituzionalizzato per tenersi sotto il Sud. I migliori se ne vanno. Per loro non c’è spazio. Restano gli inetti, i vanesi, i pressappochisti, gli sfaticati. Fra noi, i migliori, i più capaci, sono proprio gli imbroglioni e i leccapiedi. L’Italia, nata dalle armi sabaude, ha capito perfettamente con che genere di uomo aveva da fare, perciò lo ha pagato e lo paga quanto basta perché continui a fare l’ascaro.
Nell’Italia del 1860 circolavano sette monete ufficiali, più i loro sottomultipli e i loro multipli. I sottomultipli erano più importanti dei multipli, perché a quel tempo la moneta ufficiale aveva dovunque un preciso contenuto d’oro o d’argento. Per esempio, un ducato (moneta ufficiale) si divideva in venti carlini, a sua volta il carlino si divideva in cavalli, e i cavalli in tornesi. Immaginate un euro coniato in oro invece che in metallo vile. Il suo valore di scambio starebbe sulle centomila ex lire. Di conseguenza dovrebbe essere frazionato una prima volta per ottenere il valore monetario corrispondente al valore di un chilogrammo di pane, e frazionare ancora per permettere l’acquisto di un quarto di pane.
Nel 1860, esisteva già la moneta cartacea. Ma nel Regno di Sardegna era una moneta privata e circolava sulla base della fiducia di cui godeva la banca emittente. Nel Lombardo-Veneto era una moneta di Stato, in Toscana era emessa con garanzia granducale, nel Regno delle Due Sicilie circolavano dei vaglia cambiari, di cui in seguito cercherò di spiegare la singolare tipologia. Solo in Inghilterra si era già pervenuti a una banca centrale, che era in pratica l’unica a emettere banconote (al massimo 14 milioni di sterline). Qualcosa di simile stava maturando in Francia. In altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, le banche che emettevano banconote al portatore erano decine di migliaia. La logica conseguenza di così grande libertà d’emissione fu una serie di fallimenti; tanti da superare la cifra di 35 mila intorno al 1860 . Anche in Scozia le banche d’emissione erano decine, però, per loro costume e per legge, disponevano di riserve adeguate a far fronte a qualunque run dei portatori biglietti (e creditori). Ma anche prima del 1844, data in cui la Banca d’Inghilterra venne praticamente elevata a banca centrale, l’emissione non era consentita alle società anonime. Chi emetteva biglietti al portatore doveva rischiare di persona.
Nel 1850, l’Italia era indietro di un secolo in materia di cultura capitalistica. Negli ex Stati italiani, i biglietti bancari non godevano la fiducia delle popolazioni. Li accettavano soltanto i mercanti che avevano bisogno di credito. D’altra parte, il taglio dei biglietti corrispondeva a milioni di ex lire, anno 2000. Nel Regno di Sardegna i tagli permessi erano di 1000, di 500 e di 250 lire, come dire otto milioni, quattro milioni, due milioni circa. Alla sfiducia generalizzata delle popolazioni facevano eccezione le regioni meridionali e la Sicilia, dove le fedi di credito emesse dal Banco delle Due Sicilie erano circondate da un rispetto religioso. Di regola l’emissione di una fede di credito corrispondeva al versamento d’altrettanto argento alla cassa del Banco. Tuttavia esso praticava sconti ai mercanti per circa la metà dei depositi. Sulla fede di credito, anche su quella emessa allo scoperto, c’era la parola del re Borbone, e mai si ebbe il caso che il Banco si trovasse in difficoltà a convertire in numerario i suoi titoli.
La fede di credito non era un biglietto a taglio fisso e pagabile al portatore, ma un titolo all’ordine; circolava cioè mediante girata a favore di una persona determinata, come un assegno dei tempi nostri, eccezionalmente con girata in bianco. Anche la fede era una moneta cartacea impiegata dai ricchi, ma era, per così dire, più democratica delle lire. Infatti il taglio minimo era di venti ducati, circa 160 mila lire attuali, ma aveva un sottomultiplo, detto polizzino, che scendeva fino a 5 ducati; una cifra considerevole comunque, perché poteva comprare più di due quintali di grano, in un mondo in cui, chi produceva tanto da avere il pane ogni giorno, era considerato una persona fortunata.
L’emissione di biglietti di taglio fisso si ebbe per la prima volta a Genova. Benché soffrisse fortemente la dominazione sabauda, Genova era ancora una città di commerci marittimi, che la rendevano molto più vivace di Torino e quasi fastidiosa al provincialismo piemontese. A promuovere la nascita di una banca d’emissione fu il naturalizzato parigino, Giuseppe De Ferrari, sedicente duca di Galliera. Cominciò ad operare nell’anno 1848. Sentendosi scavalcato Cavour, non ancora ministro, ma ricchissimo uomo d’affari, brillante giornalista e propugnatore dell’espansionismo sabauda all’insegna delle idee liberal-conservatrici, decise di copiarla. Associò a sé altri finanzieri e banchieri torinesi, invidiosi dell’iniziativa genovese. Ma meno scaltriti di De Ferrari, i torinesi s’impappinarono con le carte. Non sapendo come uscirne, imposero ai malcapitati genovesi una fusione, da cui nacque la Banca Nazionale del Regno di Sardegna, con sede effettiva a Genova e una succursale a Torino.
Al tempo della circolazione metallica, il meccanismo della banca d’emissione si fondava sulla fiducia che il banchiere riscuoteva fra il pubblico e sull’entità dei prestiti che poteva fare ai mercanti. La consuetudine francese voleva che la banca potesse emettere carta nella misura di tre volte l’oro e l’argento tenuti come riserva. Il concetto ispiratore di tale attività era che i portatori dei biglietti – di regola dei grossi mercanti – si sarebbero fatta passare la banconota di mano in mano, prima di presentarsi in banca per averne il cambio in moneta metallica. In tal modo la banca, su un capitale proprio per esempio di quattro milioni, poteva arrischiare operazioni di credito fino a 12 milioni. In astratto (cioè, se storicamente non ci avesse messo sopra le mani la speculazione sul danaro) il biglietto è un medium più pratico per effettuare gli scambi e misurarne il valore. Se io produco un quintale d’olio, per un valore di lire 600 mila, e voglio acquistare quattro gomme per la mia auto, valore lire 400 mila, è stupido che prima spenda le mie 600 mila lire presso un minatore sudafricano, per avere oro, con cui poi comprare le gomme. A livello nazionale, poi, anche se io non ci rimetto alcunché di mio, tuttavia il mio paese immobilizza 600 mila lire.
Oggi uno che ha dei risparmi li porta in banca, e questa li rimette in circolazione. Un tempo, invece, il danaro coniato rappresentava una vera e propria sterilizzazione di un valore pagato fuori del paese. Per poter effettuare scambi monetari al suo interno e all’esterno, la collettività doveva dotarsi d’oro e/o argento. L’immobilizzo era consistente e permanente, e doveva essere aumentato periodicamente perché la moneta metallica va soggetta all’usura dell’uso. La sostituzione dell’oro e dell’argento con la carta non toglie né aggiunge alcunché alla capacità di spesa, né modifica i rapporti di scambio di un bene con l’altro. Rende disponibile invece i metalli preziosi per un diverso impiego, che poi in passato era principalmente quello di saldare un eventuale deficit con l’estero. Ma – l’abbiamo detto – la speculazione bancaria c’infilò il dito e anche la mano, stravolgendo nella pratica economica il modello astratto. Dal tempo degli splendori di Venezia, Genova e Firenze, i banchieri effettuavano pagamenti e anticipazioni su altre piazze mediante lettere di cambio domiciliate presso un loro corrispondente, il quale sborsava la somma. Ovviamente il destinatario faceva l’identica cosa e le partite del dare e dell’avere venivano compensate solo dopo qualche tempo. Ciò facendo, i banchieri si resero conto che anche il tempo è danaro. I cento fiorini che messer Boccaccio aveva versato al banchiere fiorentino per avere una lettera di cambio su Napoli, restavano in mano al banchiere per giorni, settimane, se non anche mesi. Consapevole di ciò, il banchiere, volendo trarre lucro dalla somma che teneva in mano, la prestava a messer Petrarca, che aveva bisogno di soldi.
Moltiplicando i cento fiorini per cento clienti, si ottiene la somma di diecimila fiorini. Quanto basta per fare una banca. In un assetto monetario di tipo metallico, l’ingresso sulla piazza di una banca d’emissione fa la stessa cosa: sfrutta il tempo tra l’emissione del suo biglietto e la riscossione della somma in esso iscritta. In pratica, a chi ottiene in banca un prestito di lire 1000, la banca consegna una specie di cambiale al portatore, la quale può essere subito convertita in numerario, ma anche portata poniamo da Genova a Torino, e poi da Torino ad Alessandria, e solo qui, una quindicina di giorni dopo, presentata al cassiere della banca emittente per avere metallo coniato.
In buona sostanza, finché non paga in numerario, il banchiere commercia il suo buon nome e come ogni creditore rischia il suo. Se tutto va per il meglio, lucra un interesse per il solo fatto d’avere fatto stampare una cifra su un mezzo foglio di carta.
Si badi, non siamo alla circolazione cartacea, né cronologicamente né strutturalmente, ma solo alla circolazione di carta cambiaria convertibile a vista.
Nel Regno di Sardegna, durante il decennio cavourriano, circolano circa 180 milioni di lire in numerario e mediamente 35 milioni di biglietti della Banca Nazionale del Regno di Sardegna, unica abilitata per legge all’emissione di biglietti convertibili al portatore. Cavour conta su detta istituzione per rastrellare l’oro e l’argento che molto servirebbe al suo Stato per pareggiare una bilancia commerciale e dei pagamenti fortemente deficitaria. Ma i sudditi del re Savoia – piemontesi, liguri, valdostani e sardi – recalcitrano energicamente. I biglietti della Nazionale non sono graditi. Inoltre Bombrini, il direttore genovese della Banca, è fortemente antipatico ai piemontesi.
Ma Cavour non solo appoggia la Nazionale violando la legge, la quale vorrebbe la Banca estranea a ogni operazione attinente all’erario statale (la tesoreria). Egli è prima di tutto un moderno uomo d’affari. Affinché il prestigio della Nazionale non sia coinvolto negli intrallazzi finanziari e industriali, stimola la creazione di quattro banche d’affari, due a Genova e due a Torino, a cui la Nazionale risconta (naturalmente in biglietti) gli effetti cambiari dei rispettivi clienti e fa loro dei prestiti allo scoperto. Siamo di fronte a un sistema non difforme da quello esistente in altri paesi, per giunta ben organizzato e utilizzato con prudenza. Difatti, quando le banche controllate dalla Nazionale s’ingolfano in grossi pasticci, abilmente Bombrini le porta fuori dalle secche, senza danno per il pubblico. In pratica trova nuovi azionisti, fra cui Rothschild, e spinge avanti i nodi arrivati al pettine, nella speranza che con il tempo le cose cambino.
Solo in prossimità della seconda guerra cosiddetta d’indipendenza, la Nazionale verrà a trovarsi nei guai. Qui è inutile cercare la verità. La tomba è saldata sulle soperchierie cavouriane. Sicuramente la Banca dette oro e argento allo Stato, mettendosi nella condizione di non poter cambiare i biglietti. Le sue riserve, che di regola stavano tra i trenta e i quaranta milioni, si restrinsero a cinque soltanto. Onde non fallisse, Cavour decretò il corso forzoso, cioè l’inconvertibilità dei biglietti. Il Piemonte, con la guerra all’Austria, si giocava tutto. Stessa cosa dicasi per la Nazionale. Ma appena le navi francesi, con a bordo l’esercito di Napoleone III, apparvero nella rada di Genova, fu chiaro che entrambe le partite erano vinte. Bombrini prese carte e timbri e si stabilì a Torino. Lì giunto, predispose il da fare per beccarsi i talleri dei lombardi e dei veneti. Con l’oro dei nuovi piemontesi, detti italiani, avrebbe abbondantemente ricostituito la sua riserva. E forse qualcosa in più.
2 - La storiografia italiana è ampiamente inquinata dal viscerale bisogno di denigrare il Sud. Un bisogno spesso inconsapevole, anche se le sue scaturigini politiche e culturali sono perfettamente evidenti persino in quegli storiografi inglesi che nell’ultimo mezzo secolo si sono occupati dell’Italia unita. A ben guardare, la propaganda antimeridionale precede di un decennio la conquista del Sud e assume evidenza e chiarezza sin da quando il settore conservatore del parlamento sabaudo contrappone alla spregiudicata politica cavouriana la quieta, ma concreta e fattiva amministrazione napoletana. E’ del 1855, cioè anteriore di ben quattro anni alla seconda guerra cosiddetta d’indipendenza, il famoso libro di Antonio Scialoja, fuoriuscito napoletano e professore a Torino, in cui i due indirizzi vengono messi a confronto, peraltro senza che l’autore avesse capito molto dell’uno né dell’altro. L’antimeridionalismo dell’età cavouriana serve anche a coprire la dura aggressione di parte moderata contro i mazziniani e i democratici in genere, nelle cui file i meridionali sono i più tardi a voltare gabbana a favore dei Savoia. L’operazione si concretizza con azioni e soprattutto con la propalazione di bugie e con l’aperta e insultante denigrazione dell’avversario.
L’antimeridionalismo storiografico ha anche un’ulteriore motivazione. Rovesciando le responsabilità del sottosviluppo meridionale sui Borbone si son potute assolvere sia l’usura degli speculatori, direttamente applicata sulla quotidiana razione di pane delle popolazioni italiane, sia l’origine corrotta della classe dirigente nazionale. Più in generale, la povertà dei meridionali viene spiegata con un gioco di prestigio, e precisamente incriminando la concezione del vivere tipica degli italiani del Sud, da ultimo affettuosamente definita con l’espressione "familismo amorale"; in effetti una trappola messa in opera dai colti, per fornire un alibi ai coinvolgimenti mafiosi dello Stato italiano (e non solo italiano) e giustificare l’iniqua distribuzione delle risorse pubbliche a favore dei settori privilegiati del capitalismo nazionale.
La controffensiva meridionalista, che pure non mancò e che si spinse fino a criticare l’industria parassitaria, non osò aggredire il modello capitalistico, il quale, anzi, fu visto come un traguardo da raggiungere. Soltanto Gramsci superò l’ideale steccato, ma il filone critico da lui inaugurato si spense con lui. Non ha infatti alcuna sostanza gramsciana la storiografia postbellica che ipocritamente si richiama al grande sardo. Non diversamente dalla storiografia sabauda e crociana, essa persevera nell’idoleggiare qualità padane, che sono inventate di sana pianta. Fuori dell’asinino coro si pose (o meglio rimase) soltanto Emilio Sereni, a cui spetta l’indiscusso merito d’avere indagato senza reverenze patriottiche sulla classe dei capitalisti. Seguendo la pista da lui tracciata si può andare parecchio oltre, credo fino a individuare nel drenaggio del capitale storico e dei surplus meridionali da astinenza l’humus necessario perché potesse fiorire, tra Genova, Torino, Firenze e Milano, attraverso la patriottica usura sui titoli del tesoro in cui brillò il padronato padano; una classe avida e tracotante, ma anche stupida e inefficiente. Difatti non fu la sua sbandierata capacità dirigente, ma furono le rimesse in valuta pregiata dei lavoratori emigranti che, risollevando il valore internazionale della lira, misero in piedi la passabile Italietta (padana) di Giolitti e Mussolini.
La storiografia risorgimentale – che meglio chiameremmo apologia del Piemonte sabaudo – fra i suoi molteplici filoni contempla un’agiografia della Banca Nazionale del Regno di Sardegna, sventolata a volte come l’unica, altre volte come la più importante banca d’emissione degli ex Stati italiani. Vedremo in appresso la falsità dell’enunciato. Chiariamo, invece, subito cosa fosse una banca d’emissione nell’Italia dell’ultimo decennio preunitario. In tutti gli ex Stati la circolazione monetaria si basava sull’oro o sull’argento, o su entrambi i metalli. Di regola, i coni in mesi in circolazione avevano un valore intrinseco pieno. Facevano eccezione soltanto le monete erose dall’uso, che venivano periodicamente ritirate per essere fuse e riconiate. Capitava però che rimanessero in circolazione anche a lungo. In tal caso il pubblico le accettava per un valore inferiore a quello segnato e secondo le quotazioni correnti fra i cambiavalute.
Come accennato, esisteva anche una circolazione di carta bancaria in grossi tagli, convertibile a vista in numerario ufficiale. Nel Lombardo-Veneto, soggetto all’Impero Austriaco, la cartamoneta era avallata dallo Stato. Egualmente in Toscana, dove peraltro la carta era stata introdotta solo nel 1858. Non così nel Regno di Sardegna, in cui la carta veniva emessa soltanto dalla Banca Nazionale, in base a un monopolio legale. La banconota sarda era un’obbligazione privata di tipo cambiario e tale rimase nell’Italia unita, nonostante le devastanti conseguenze per tutta la gente e nonostante il discredito che colpiva il nuovo Stato presso i sudditi e all’estero, specialmente in Francia; una stravaganza giuridica e costituzionale, una vera buffonata, dapprima destinata a realizzare il progetto cavouriano che lo Stato s’impadronisse delle sostanze private dei sudditi; in appresso non giustificata da nessun’altra ragione che la subalternità del governo e del parlamento ai faccendieri padani.
Secondo la legge istitutiva, la Banca Nazionale sarda poteva immettere nella circolazione carta nel rapporto tre lire per una di metallo tenuta come riserva. In Inghilterra e Francia, il principio ispiratore della banca d’emissione era l’idea secondo cui il vivace commercio del mondo contemporaneo trovava un intralcio nell’inadeguatezza del capitale bancario, a sua vota raffrenato dalla scarsità dei depositi in metalli, mentre l’eventuale aumento della circolazione, mediante l’acquisto di metalli preziosi, comportava da parte dello Stato e dei privati un esborso spesso impossibile, sempre infruttifero. Invece l’allargamento dell’attività creditizia a costo zero, mediante carta monetaria, rappresentava (e tuttora rappresenta) una facilitazione e anche uno stimolo per gli affari. L’emissione sabauda – rivolta a succhiare l’oro dei cittadini per dorarne il sovrano - ebbe invece quel carattere settecentesco che le precedenti esperienze francesi e inglesi condannavano energicamente. Purtroppo il governo piemontese e i suoi eredi italiani tennero in nessun conto l’insegnamento dalla storia. D’altra parte il loro compito politico consisteva nel trasferire alla borghesia speculatrice padana il capitale storico del Sud, condensato nel metallo monetato.
Lo stato della circolazione cartacea in italia,
prima dell’unificazione sabauda, è descritto nella tabella seguente.
|
Stato |
Banca |
Tipologia |
Riserva % |
Importo (lire sabaude) |
%. |
|
Due Sicilie |
Banco delle Due Sicilie – Napoli |
Vaglia di Stato di taglio variabile |
½ |
145.000.000 |
54,3
|
|
idem |
Banco delle Due Sicilie – Palermo |
idem |
½ |
33.400.000 |
|
|
Regno di Sardegna |
Banca Nazionale |
Biglietti di banca a taglio fisso |
1/3 |
57.000.000 |
17,3 |
|
Ducato di Parma |
Banca degli Stati Parmensi |
idem |
1/3 |
100.000 |
0,3 |
|
Stato Pontificio |
Banca per le Quattro Legazioni – Bologna |
idem |
1/3 |
3.000.000 |
1,0 |
|
idem |
Banca degli Stati Pontifici |
idem |
1/3 |
44.400.000 |
13,6 |
|
Granducato di Toscana |
Banca Nazionale Toscana |
idem |
1/3 |
19.200.000 |
5,8 |
|
Provincie lombarde (Impero Austriaco |
Banca Nazionale Austriaca |
idem |
non prescritta |
9.000.000 |
2,4 |
|
idem |
Tesoro Austriaco |
Biglietti di Stato a corso legale |
idem |
||
|
Provincie venete (Impero Austriaco |
Banca nazionale e Tesoro austriaci |
idem |
idem |
14.000.000 |
5,3 |
|
idem |
Stabilimento Mercantile di Venezia |
Vaglia bancari |
100% |
3.500.000 |
|
|
Totale ex Stati |
328.600.000 |
100 |
Le fandonie storiografiche circa il primato, o del tutto l’unicità, della Banca Nazionale sarda crollano a una semplice scorsa della tabella. In un’Italia attardata sui residui della mercatura medievale, lo Stato borbonico aveva una circolazione cartolare più consistente degli altri ex Stati, anzi maggiore della somma fra tutti gli altri, benché le esigenze del suo commercio fossero decisamente minori. Conseguentemente ciò significa che nel Regno le attività bancarie avevano raggiunto un grado di sviluppo meno infelice che altrove; quantomeno esse mostrano di calzare meglio che altrove alla realtà commerciale sottostante. Fatto sta che il commercio napoletano aveva raggiunto soltanto l’indipendenza. Dopo cinque secoli di dominazione straniera, l’evento era decisivo,tuttavia restava ancora parecchia strada da fare. Sotto la gestione borbonica si era emancipato dalla sudditanza al capitale genovese e in buona misura anche dalla dipendenza dalla marineria genovese e livornese. Il progresso non si estendeva però verso il basso, a favore del commercio locale, che non trovando il credito che gli occorreva, restò rachitico, subalterno ai mercanti della capitale. Per tal motivo, come annota Nitti, nella società meridionale del tempo, l’argento - che svolgeva dovunque la doppia funzione di medio circolante e di bene destinato a conservare il risparmio nel tempo (il tesoro familiare) – veniva destinato a quest’ultimo uso con un’incidenza maggiore che altrove.
Il fatto, poi, che la carta napoletana fosse diversa da quella a noi nota può significare un’infinità di cose, ma nessun artificio dialettico può negare il dato relativo della maggiore circolazione cartacea napoletana rispetto ad altri ex Stati. Alcuni di essi registravano uno sviluppo maggiore negli scambi, ma non certamente un sistema di finanziamento più evoluto.
L’appiglio degli storici arretratisti risiede in un "appiglio". La carta napoletana era moneta ufficiale, con effetto liberatorio nei pagamenti. Perché, allora, Napoli, pur tanto evoluta in materia monetaria, non adottò le banconote a taglio standard? Non lo fece proprio perché l’amministrazione era saggia, esente dal sentimento d’inferiorità verso l’Inghilterra che tanto condizionava i sabaudi, cosicché lo strumento si confaceva a una realtà poco felice. La specificità della fede stava nel fatto che il ladro non l’avrebbe potuta utilizzare. Era tagliata sui bisogni di un paese la cui capitale accentrava larga parte delle attività commerciali, finanziarie e creditizie, mentre sui tratturi della provincia, infestati di briganti, il trasporto di danaro contante avveniva con parecchia insicurezza. La quale non diminuiva nel trasporto via mare, che per il commercio napoletano costituiva una scelta praticamente obbligata e comunque il costo minore. Il rischio di perdere la fede di credito in un disastro navale era nella previsioni. A ogni fede emessa corrispondeva una matrice che permetteva quel che oggi diremmo l’ammortamento del titolo a favore del primo prenditore. Inoltre il titolo godeva della garanzia statale. Emessa solo a Napoli e a Palermo, le tesorerie provinciali e circondariali delle imposte – superfluo aggiungere - ben diffuse sul territorio, avevano l’obbligo di cambiarla in numerario. D’altra parte i mercanti che accedono allo sconto e quelli che operavano con propri capitali, di solito, non chiedevano una fede di credito soltanto, ma che l’ammontare fosse frazionato in più fedi di valore tondo: venti, cinquanta, cento ducati. Quanto alle transazioni minori, è giusto far rilevare che lo Stato borbonico, tutt’altro che ricco, disponeva tuttavia di monete coniate e di spezzato metallico in bronzo e rame in sovrabbondanza. In buona sostanza, se non era, né poteva essere, lo Stato di tutti, era quantomeno un padrone che cercava di non trattare male i sudditi, come si faceva invece in Piemonte.
La circolazione metallica esistente in Italia prima dell’unificazione sabauda, secondo la stima di Giuseppe Sacchetti, ritenuta la più autorevole, è riassunta nella tabella seguente.
|
Ex Stati |
Milioni di lire |
% |
Popolazione al 1860 |
Lire pro-capite |
|
Regno delle Due Sicilie |
457,5 |
40,5 |
9.371 |
48,8 |
|
Granducato di Toscana |
85,3 |
7,5 |
1.815 |
47,0 |
|
Regno di Sardegna |
208,8 |
18,5 |
4.995 |
41,8 |
|
Lombardia |
112,3 |
9,9 |
2.903 |
38,7 |
|
Veneto |
99,9 |
8,8 |
2.496 |
40,0 |
|
Parma, Modena (somma) |
37,9 |
3,4 |
1.109 |
34,2 |
|
Stato Pontificio |
128,5 |
11,4 |
3.181 |
40,4 |
|
Totale |
1.130,2 |
100,0 |
25.870 |
43,7 |
N.B. Sulla base del dato relativo al ritiro del vecchio numerario, portato a termine nel 1894, è stato aumentato il valore relativo al Granducato di Toscana. E’ da segnalare inoltre che, nella tabella, sia la popolazione sia la circolazione monetaria sabaude includono la Savoja e la provincia di Nizza.
L’autore del presente articolo dichiara la propria diffidenza riguardo alle statistiche post-unitarie, che suppone a volte alterate deliberatamente dagli assertori del primato sabaudo. In particolare non ritiene credibili le stime relative alla Lombardia e al Veneto, sebbene gli sia noto che nell’Impero Austriaco la circolazione cartacea era notevole. Neppure gli appare credibile il dato concernente Modena e specialmente Parma, che economicamente erano a livello lombardo.
La Banca di Sconto, Depositi e Conti Correnti di Genova, poi Banca Nazionale del Regno di Sardegna, che gli storici ci presentano come l’ottava meraviglia del mondo, non ebbe niente di prodigioso. Era una minuscola banca d’emissione realizzata su modello marsigliese. Se confrontata con altre istituzioni creditizie del tempo, quali il Banco delle Due Sicilie e la Cassa di Risparmio di Milano, appare alquanto modesta. Partì nel 1844 con un capitale di quattro milioni di lire e andò avanti con alquanta prudenza. Sebbene l’atto costitutivo approvato dal governo sabaudo le permettesse di emettere biglietti nel rapporto di tre a uno (di riserva metallica), quindi fino a 12 milioni, i biglietti fiduciari effettivamente messi in circolazione ammontarono solo a 1,5 milioni nel 1845, a 4, 2 milioni nel 1846 e a 8,65 milioni nel 1847. Cavour, modernizzatore convinto, ma non ancora ministro, criticò tale prudenza sul suo giornale. In sostanza, la Banca di Genova si pigliò tre anni di rodaggio per cominciare a utilizzare la facoltà di emettere moneta fiduciaria, e lo fece in modo contenuto, fino a 8 milioni, nel rapporto di 2 a 1. In effetti l’economia era stagnante, al paese sarebbero servite industrie moderne, e non certamente una maggiore liquidità a favore dei mediatori degli scambi. Invece l’agricoltura disponeva già di circolante a sufficienza per i bisogni della commercializzazione dei suoi prodotti, e solo al momento della campagna dei bozzoli si avvertiva qualche scarsità di numerario.
La circolazione fiduciaria della banca genovese s’impennò, fino a raggiungere il rapporto di 5 a 1 (di riserva) nel 1848, quando il governo piemontese cominciò a preparare la guerra con l’Austria. In cambio di un prestito allo Stato di 20 milioni, la Banca di Genova venne autorizzata a non convertire le banconote che avrebbe messo in circolazione. Siamo al cosiddetto corso forzoso. L’espressione non significa soltanto che la Banca non era tenuta alla conversione, ma anche che chi aveva contratto un debito poteva pagarlo con cartamoneta, ed esserne liberato. Quanto allo Stato, esso avrebbe avuto l’oro, mentre i sudditi avrebbero pagato un’imposta senza accorgersene. La Banca, poi, avrebbe fatto un triplo profitto. Per prima cosa avrebbe ricevuto un interesse a compenso del rischio teorico di dover essa sborsare l’oro, se non l’avessero dato i sudditi. In secondo luogo i venti milioni del prestito sarebbero entrati in circolazione in base a mandati di pagamento dello Stato, che, per effetto del corso forzoso, sarebbero stati onorati con carta (salvo il caso di pagamenti all’estero), mentre lo Stato prima o poi avrebbe rimborsato il debito in oro; cosa che in effetti avvenne nel 1851 e 1852, cioè due o tre anni dopo. In terzo luogo, la banca avrebbe incassato venti milioni oro per aver dato venti milioni direttamente o indirettamente in carta bancaria.
La breve sperimentazione del corso forzoso dimostrò che la formula piemontese di moneta cartacea, ben diversamente dalla formula napoletana, non funzionava. Nel Regno sardo c’era sufficiente liquidità e, poi, la gente non dava fiducia a quella banca e a un’anonima cambiale. La moneta bancaria rimase ai margini della circolazione, mentre l’oro e l’argento guadagnarono persino un aggio sulle banconote; tutt’al contrario che nelle Due Sicilie, dove la fede di credito faceva aggio sul contante metallico.
3 - Non è possibile la comprensione della truffa unitaria senza cogliere il senso dell’indirizzo impresso da Cavour alla politica piemontese. In ogni studio che si rispetti, questi viene presentato come un appassionato e ardito sostenitore del libero commercio. La sua fede liberista si era formata nell’ammirazione del padronato inglese, che offriva, non senza un secondo fine, tale specchietto per le allodole all’imitazione degli attardati padroni del resto d’Europa, divenuti, dopo i moti parigini del 1830, paurosi di perdere la mangiatoia. Nell’empireo della civiltà britannica, il liberismo commerciale è glorificato dall’idea di una classe padronale dedita a riorganizzare, su basi più attraenti, il suo dominio sulle popolazioni nazionali e su quelle mondiali. La sublime e sublimante idea aveva come fondamento pratico un impero governato con rara ferocia e una tale ingordigia da far impallidire il ricordo classico del propretore Verre. Ora, Cavour aveva capito tutto del liberismo, tanto la faccia visibile quanto quella effettiva. Il nostro Benzo, asceso a Benso e anche a Conte, nonché a primo ministro, sbandierando l’albionica bandiera, riuscì a incantare i proprietari toscopadani e ne ottenne il consenso. Sapeva bene, tuttavia, che se il libero commercio giovava all’esportazione della seta e delle altre derrate agricole italiane (l’aveva anche scritto in uno dei suoi saggi preministeriali), non poteva automaticamente stimolare la nascita dell’industria moderna. Per realizzare questa speranza – che era poi al centro del pensiero dei patrioti italiani – si pretendeva ben altro: probabilmente l’opposto del libero commercio internazionale, come insegnavano gli economisti tedeschi e come il giovane Quintino Sella gli ricordò in parlamento, nel maggio 1861, in occasione della discussione sull’ormai vaniloquente protesta degli industriali napoletani contro le sopraffazioni liguri-piemontesi.
Solo la Gran Bretagna, arrivando per prima all’industria ha potuto percorrere la strada dell’industrializzazione senza sottoporsi a un periodo di avviamento e senza sottoporre il popolo nazionale agli annessi costi di rodaggio. In appresso, tutti i paesi che, a imitazione dell’Inghilterra, hanno percorso la strada dell’industrializzazione (non ultima l’Italietta di Giolitti) hanno dovuto sottostare al pedaggio. Il quale, di regola, viene pagato con l’adozione di tariffe protettive, che colpiscono all’entrata le merci delle industrie straniere (e fanno pagare più care ai consumatori nazionali le merci nazionali). Il tema era noto all’intellighenzia ligure-piemontese sin dal tempo di Carlo Alberto. Già prima della guerra all’Austria, una vigorosa protezione era stata chiesta al governo dall’industriale Taylor, che stava avviando a Genova, peraltro con i soldi dello Stato sabaudo, la prima industria meccanica di tipo moderno, quella che poi prenderà la ragione sociale di Ansaldo: "Noi siamo lontani dal sollecitare il Regio Governo ad accordarci permanentemente una siffatta protezione. La domandiamo solo per i primi anni dello Stabilimento, perché siamo persuasi che senza di essa non sarà possibile che si sviluppi in questi Regi Stati il ramo dell’industria che proponiamo di introdurre considerandolo ormai indispensabile".
Tutto si può dire di Cavour, meno che mancasse di concretezza. Offerto come una specie di moderna cornucopia alle speranze degli italiani non sabaudi, il principio liberale doveva, però, restare una mera proclamazione verbale, elusa dai fatti. Industrie, come l’Ansaldo, che avrebbero potuto cambiare veramente il volto del Regno andavano sotterraneamente protette. Agente del sotterfugio sarà la banca d’emissione, la quale si assume il compito di coprire i costi sociali del rodaggio industriale. L’Ansaldo non sarà l’unico figlio settimino finito nell’incubatrice. Sotto Cavour, il governo sabaudo si presentava come un potere "assai prodigo, assai costoso. La prodigalità sembrò la via migliore per contribuire al progresso industriale e commerciale del paese, per dare impulso allo spirito di associazione ed accrescere la produzione della ricchezza e il generale benessere" (Giuseppe Prato).
Per quanto un liberismo protezionista possa apparire una contraddizione in termini, una cosa teoricamente ridicola, i successori di Cavour riusciranno a realizzarlo come codicillo all’espansionismo sabaudo, buttando i danari degli italiani nelle fameliche fauci della Banca Nazionale dell’ex Regno di Sardegna, che riuscirà a imporre l’ibrida politica come reale discriminazione ligure-piemontista all’interno dell’Italia unita.
Sotto il governo della Banca Nazionale, l’assistenzialismo dissimulato diventò il credo di quella borghesia padana degli intrallazzi che governerà l’Italia in prima persona o la farà governare dai suoi servili mandatari. In buona sostanza, si trattava e si tratta di un cobdenismo per i fessi napoletani e di un colbertismo a tutto tondo per gli accorti capitalisti delle città padane e per i loro dipendenti.
Niente da obiettare. Vee victis. Siffatta politica è nella natura del capitalismo. Qualunque capitalismo nazionale non può non farla. Certo i patrii testi di storia non perdono tempo a giustificarla. Anche senza impararlo a scuola, tutti sappiamo che c’è; che l’industria padana è sfacciatamente assistita e finanziata sottobanco, mentre qualsiasi iniziativa meridionale è regolarmente mandata allo sbando. E infatti il problema da affrontare e risolvere non è come riequilibrare la Nazione, ma come romperla nuovamente.
Il protezionismo dall’interno non rappresenta un’incoerenza filosofica di Cavour, ma una toppa mal messa sull’errore strategico di adottare il libero scambio in un Piemonte e successivamente a un’Italia ancora da fare industrialmente. Però il problema non è lui o la sua politica. Il sistema piemontese aveva tutto il diritto di favorire, mediante l’adozione di tariffe liberiste, le esportazioni agricole e contemporaneamente di sovvenzionare sottobanco il costo dello sviluppo industriale. Aveva anche il diritto d’indebitarsi con l’indistinta collettività e d’indebitare tutt’Italia, visto che il padronato italiano aveva deciso di rimanere subalterno alla classe dei finanzieri padani. Il problema sono gli storiografi, i quali hanno il dovere di non raccontare corbellerie. La verità che va raccontata è che il liberismo cavouriano bloccò per quarant’anni qualsiasi strada all’industrializzazione italiana. Contemporaneamente la speculazione non dette luogo a una classe di produttori moderni ma alimentò una classe di imbroglioni e tangentisti legati alla banca, di cui il paese farà fatica a liberasi. Cavour e i suoi successori dilapidarono consistenti risorse per creare un clima favorevole al capitalismo industriale, che alla prova dei fatti fallì completamente. Le vicende del passato parlano chiaro. Prima della disastrosa unità, solo Napoli aveva un’industria metalmeccanica ben fatta, anche se statale, che usufruiva di una domanda estera di navi e locomotive ferroviarie. E tra i suoi clienti c’era anche lo Stato sabaudo, che comprò le sue prime locomotive proprio dall’Officina di Pietrarsa. Trascorso un secolo, solo l’IRI, un’holding a capitale pubblico può disegnare e guidare la prima, vera industrializzazione nazionale.
L’errore di Cavour portò il Regno subalpino a chiudere sull’orlo del fallimento la sua esistenza di Stato regionale. Gli errori del "grande ministro" coinvolsero i suoi eredi, i quali li riversarono sui sudditi, punto e basta. Creata la Banca d’Italia nel 1894, la smania di dilapidare il danaro dei cittadini, quelli rimasti in patria e quelli emigrati, con iniziative private fasulle portò al completo fallimento le stesse industrie, le banche ordinarie e mettendo in gravissima crisi la stessa Banca d’Italia. Certamente, senza l’errore cavouriano sarebbe stato più difficile ai seguaci di Cavour, pervenuti al governo dell’Italia-una, d’infierire per ben ottant’anni sulle popolazioni contadine e urbane di un paese in cui non tutti riuscivano a guadagnare un tozzo di pane al giorno. Tuttavia tra Cavour e quelli che gli succedettero non c’è soltanto una differenza di statura politica, c’è anche e prima di tutto un abisso morale. Cavour era piemontese, e ogni suo gesto, giusto o sbagliato che fosse, era motivato dal sentimento di un grande Piemonte, gli altri, che si dicevano italiani, sbagliarono ben sapendo di sbagliare. I settentrionali, come polli affamati, si mangiarono anche le uova, i meridionali, come sempre servili con il conquistatore, si comportarono da ruffiani. E non solo portarono a perdizione la loro gente, ma anche sé stessi. Ma, poi, in questa questione, il vero buco nero sta nella deliberata scelta degli storici a propalare scempiaggini e a insistere con le bugie.
A partire dalla sua ascesa a ministro, Cavour usò la Banca Nazionale per inaugurare un clima speculativo e inflazionistico. Essa venne messa al servizio del tesoro e delle citate casse di sconto torinesi e genovesi, tenute in piedi mediante il risconto della Nazionale. Scrive Pautassi a proposito delle banche sovvenzionate: "Si trattava di anonime, dotate di capitali inizialmente limitati; le quali, talvolta per espresse disposizioni statutarie, intendevano dilatare le proprie operazioni riscontando il portafoglio", ovviamente presso la Nazionale. "Programmi così fatti rientravano in pieno nel piano delineato da Cavour […] Di talune di esse è scomparsa ogni traccia e quindi nulla si sa. Di altre è rimasto soltanto un ricordo vago". La punta di diamante del nuovo corso fu la Cassa del Commercio e dell’industria, nata tra il 1852 e il 1853. A fondarla furono quattro gruppi societari, due torinesi - la ditta bancaria Mastregat & C. e la ditta bancaria Fratelli Bolmida & C. - e due genovesi - la ditta di commercio Giovanni Rocca & Cugini fu Pietro Antonio e il banchiere Luigi Ricci - i quali sottoscrissero l’intero capitale di 8 milioni, suddiviso in 16 mila azioni da lire 500 cadauna. "Del valore di siffatte azioni doveva essere versata soltanto una metà e siffatta metà era per di più ripartita in rate". In sostanza, di proprio ci misero poco più della Marcia Reale. Molto di meno lor signori saranno tenuti a rischiare quando diventeranno i padroni incontrollati di una popolazione di 25 milioni di povera gente.
Da principio la Cassa fece buoni affari. Con un capitale versato, che nella migliore delle ipotesi arrivava a quattro milioni, nell’anno 1854 effettuò sconti e anticipazioni per un totale di 87 milioni. "In portafoglio, tuttavia, essa aveva effetti per sole lire 6.237.503" e centesimi 79. Tra capitale versato e cambiali, si trattava in tutto di dieci milioni, di cui ben sei di crediti, come dire di denari futuri e incerti. Miracoli di Cavour! "Una ventata di sconti e anticipazioni così fatta poteva tuttavia essere imprudente […] talune posizioni speculative non potevano essere mantenute. [Sicuramente la banca] doveva trovarsi a lottare con un certo immobilizzo, tanto più che diversi effetti scontati erano sicuramente di comodo" . Un’impresa di questo tipo avrebbe dovuto portare i libri sociali in tribunale: i creditori avrebbero diviso quel poco che c’era, e gli amministratori avrebbero varcato i cancelli di un carcere. Ma questi signori erano dei patrioti, dei precursori dell’Italia una e indivisibile. D’altra parte il creditore era uno solo, Bombrini, direttore della Banca Nazionale, il quale giocava per conto del grande ministro la partita di fabbricare i fabbricanti. Cosicché, invece di finire in galera, gli amministratori decisero un aumento di capitale, e non lo fecero versando i decimi ancora dovuti, ma incettando nuovi soci per altri otto milioni. "Forse la piega che le cose stavano prendendo non era sufficientemente tranquillante per i vecchi soci..." . A loro volta, i nuovi soci erano chiamati a versare solo la metà delle lire cinquecento che costituivano il valore di ciascuna delle sedicimila nuove azioni. Il governo non vide irregolarità in tale scorretta procedura e ratificò la delibera.
Solo una parte di queste scoperture bancarie (cioè di carta che era messa in circolazione per risucchiare l’oro dei cittadini) andava alle attività veramente produttive. La parte più consistente serviva ad alimentare la speculazione sui titoli di Stato. Siamo di fronte a una celebre autolesionistica esibizione di Cavour, la quale, per la verità, avrà la più efficace e vasta applicazione una volta che l’Italia sarà politicamente unificata sotto quel galantuomo di Vittorio Emanuele. Volendo usare la lingua che l’invenzione cavouriana merita, l’espressione giusta sarebbe fottere il prossimo. Siccome, però, i lettori vanno rispettati, costumatamente dirò che la funzione assegnata in generale da ogni Stato ai buoni del tesoro era, un tempo, quella di drenare metalli preziosi dai sudditi agli scrigni del re. L’aggiunta cavouriana al regio fottisterio consistette nello svendere le cartelle del debito pubblico e di indebitare paurosamente lo Stato, pur di rastrellare oro; una filosofia che, morto lui, i suoi discepoli porteranno avanti con allegra rapacità.
Il debito pubblico non è fatto di cambiali a vista. Al contrario. Mentre l’introito del tesoro è immediato, la restituzione – se mai ci sarà - è rimandata al futuro. Corrente è invece il peso degli interessi sul bilancio dello Stato e il conseguente aumento delle imposte, come ben sanno anche gli italiani di oggi. Anche il debito cosiddetto flottante è di regola rinnovato, spinto in avanti; più spesso consolidato, che pagato. Per quanto riguarda la storia dell’Italia una e indivisibile va detto, inoltre, che la svendita delle cartelle del debito pubblico si trasformò non solo in un vergognoso meccanismo di arricchimento per gli speculatori, ma anche in uno spostamento al Nord dei valori metallici circolanti al Sud. Tale operazione si colloca alle origini del capitalismo nazionale, il quale, nato da una classe improduttiva, resterà per sempre marchiato dal suo originario parassitismo.
Il meccanismo con cui la speculazione procedette può essere così riassunto. Sia nel Regno di Sardegna sia successivamente in Italia, il prestito veniva contratto mettendo in circolazione cartelle del valore nominale di lire 100, contenenti, cioè, la promessa dello Stato a pagare lire 100 alla scadenza. Il tasso annuo d’interesse dichiarato si fermò al 5 per cento. Siccome la fiducia di cui godevano, in successione, prima lo Stato piemontese e poi quello italiano, era scarsa, le cartelle dovevano essere collocate a un prezzo inferiore. Al tempo del Regno di Sardegna, tra le 80 e le 70 lire, con il Regno d’Italia si arrivò a 50 lire, e anche a meno.
Per chi paga 50 lire una cartella che dà una rendita di cinque lire l’anno, l’interesse che viene a lucrare non è più il 5 per cento, ma il 10 per cento l’anno. A questo tasso risultava conveniente dare la propria cartella come pegno in banca, per ottenere in prestito 100 lire, con le quali si potevano acquistare altre due cartelle, che assieme avrebbero reso il venti per cento annuo. Pagato l’interesse del 5 per cento sull’anticipazione, il guadagno finale sarebbe stato un interesse annuo del 15 per cento. Ovviamente l’operazione di anticipazione su titoli poteva essere moltiplicata all’infinito e assicurare profitti favolosi a partire da un solo investimento iniziale. Le banche del sistema cavouriano, che diverranno le più importanti a Italia unita, favorirono deliberatamente questo tipo di operazioni, perché consentiva loro di rifilare carta allo Stato e diventare suoi creditori per capitale e interessi, senza investire e senza rischiare un bel niente.
Nella trasformazione del Piemonte in Italia, le banche cavouriane si fecero nuove nuove.
Borsa Genova – Valore di alcuni titoli azionari - Minimo e massimo nell’anno
|
1 Banca Nazionale |
2 Cassa Torino |
3 Credito Mobil. Balduino |
4 Cassa Generale |
5 Cassa Genova |
|
|
Valore della azione |
1000 |
500 |
500 |
250 |
250 |
|
1856 |
1.154 1.510 |
531 925 |
275 303 |
||
|
1857 |
1.122 1.388 |
207 330 |
260 295 |
248 266 |
|
|
1858 |
1.248 1.388 |
152 283 |
225 285 |
210 250 |
|
|
1859 |
1.040 1.470 |
45 165 |
150 227 |
160 220 |
|
|
1860 |
1.184 1.319 |
63 360 |
170 201 |
- |
|
|
1861 |
1.206 1.320 |
282 510 |
190 190 |
- |
|
|
1862 |
1.215 1.585 |
512 678 |
220 240 |
- |
|
|
1863 |
1.540 1.918 |
516 684 |
248 293 |
220 268 |
|
|
1864 |
1.324 1.600 |
405 565 |
220 250 |
210 228 |
|
|
1865 |
1.428 1.770 |
390 482 |
200 225 |
230 264 |
|
|
1866 |
1.160 1.605 |
235 395 |
205 215 |
240 250 |
|
|
1867 |
1.380 1.612 |
270 335 |
- |
||
|
1868 |
1.515 1.775 |
255 388 |
195 203 |
223 275 |
|
|
1869 |
1.700 2.060 |
354 483 |
195 240 |
350 640 |
|
|
1870 |
1.910 2.434 |
300 539 |
190 243 |
500 883 |
|
|
1871 |
2.334 3.915 |
425 930 |
220 485 |
665 1.425 |
|
|
1872 |
3.700 4.545 |
865 1.320 |
390 485 |
1.050 1.395 |
|
|
1873 |
2.010 2.705 |
765 1.271 |
295 448 |
725 1.300 |
|
|
1874 |
1.670 2.168 |
635 925 |
150 313 |
575 860 |
Prima del 1859, la Banca contava due sedi, Genova e Torino, e cinque succursali, Alessandria, Cagliari, Cuneo, Nizza e Vercelli. Non appena la guerra apparve certa, Cavour avverte Bombrini affinché si preparasse allo scatto. Prima ancora che gli austriaci fossero battuti, la Banca Nazionale aumentò il proprio capitale in modo da concedere un quinto al padronato lombardo. I 30 e più mila soldati caduti a Solferino e San Martino non erano ancora sepolti che già la Nazionale istituiva la sede di Milano. Il pericolo di un dissesto, di un run da parte dei portatori di banconote (propriamente creditori), si dissolse fra i vapori agostani della Bassa Padana.
4 - Non so se Wagner si sia mai interessato di banche, certo è che il dilagare della Nazionale sulle cento città d’Italia ricorda l’impeto incalzante de La cavalcata delle Valchirie. Bombrini corre più veloce dei bersaglieri. Tra il giugno del 1859 e il settembre 1860, viene praticamente realizzata l’occupazione del Centrosettentrione. Crollate subito dopo le Due Sicilie, vengono immediatamente istituite altre due sedi: Napoli e Palermo.
Nello stesso 1860, Bombrini inaugura succursali ad Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Messina, Modena, Parma, Perugia, Porto Maurizio (l’attuale Imperia) e Ravenna.
Nel 1862 s’insedia a Catania, Cremona, Ferrara, Forlì, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria e Sassari; nel 1863 a Bari e Chieti; nel 1864 all’Aquila, Catanzaro, Foggia, Lecce e Savona.
Nel 1865, i toscani vengono a patti e Bombrini può aprire la sede di Firenze. Quell’anno, apre succursali anche ad Ascoli Piceno, Carrara, Lodi, Macerata, Pesaro, Reggio Emilia, Siracusa e Vigevano.
Nel 1866 s’insedia a Caltanissetta, Cosenza, Girgenti (Agrigento), Novara, Salerno, Teramo e Trapani.
Nel 1867, acquisito il Veneto ai Savoia, compra una banca veneziana e la trasforma nella propria sede di Venezia. Apre inoltre le succursali di Padova, Mantova, Udine e Verona. Al Sud inaugura la succursale di Avellino. La penetrazione locale proseguirà dopo l’annessione di Roma (1870).
Una diffusione così ampia e capillare, da parte di una banca privata che non possiede il metallo necessario per rimborsare le sue stesse cambiali, si spiega soltanto con la fanfara dei bersaglieri. Questa espansione privata, munita tuttavia del sigillo dello Stato, è una cosa da Compagnia delle Indie, indegna di un Regno che si autoproclama fondato sulla volontà della nazione, oltre che sulla grazia di Dio. Evidentemente in quel momento il Sud era coperto di nubi e Dio non lo vedeva! Per giunta, la Compagnia cavour-bombrinesca inchioda al remo gli altri istituti di credito esistenti, alcuni dei quali - sicuramente il Banco delle Due Sicilie e la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde – avrebbero potuto fare di lei un solo boccone.
Il concetto politico che presiede all’operazione non viene mai esplicitato. Non lo fa Cavour, né lo fa Bombrini. Sono le azioni – qualche volta soltanto i tentativi – del governo sabaudo a renderlo evidente. Il fine dissimulato è uno solo: la conversione dei sette o otto segni monetari circolanti nella vecchia Italia in banconote della Banca Nazionale, affinché l’oro e l’argento possano essere appropriati dal nuovo Stato. L’operazione, portata avanti in modo viscido e intrallazzistico, ha un cammino penoso. La slealtà di Bombrini nei confronti del parlamento nazionale, verso i vari presidenti del consiglio e verso i ministri delle finanze, la resistenza delle popolazioni e, in più luoghi, quella delle stessa classe proprietaria, fanno sì che il feto abortivo moneta italiana impieghi trent’anni a uscire dal grembo che l’ha concepito. L’ambiguità di un potere suddiviso tra banca, governo e parlamento, la divergenza, spesso la conflittualità, fra due o più progetti, portano all’orrendo risultato che l’unificazione monetaria resti un fatto metrico, un semplice rapporto fisso, stabilito per legge sabauda, tra le vecchie monete e la lira regia, la cui quantità rimane volutamente sottodimensionata rispetto ai bisogni della circolazione, affinché possa essere portata a compimento una subdola speculazione sul metallo monetato; una sopraffazione delle popolazioni, e non solo di quelle meridionali, che incide pesantemente sui risparmi familiari. Se Cavour ha usato la Nazionale per i fini espansionistici dei Savoia, dopo la sua morte, Bombrini – spesso con l’aperto ricatto - usa i governi della Destra Storica allo stesso modo con cui, oggi, gli spacciatori di droga usano i drogati per commerciare la loro merce mortifera.
Dopo la conquista di Venezia e di Roma, la cavalcata in cerca dell’Eldorado prosegue; anzi, ogni anno che passa diventa più impetuosa. L’oro incamerato, che frutta alla Banca il suo valore. In tale modo essa si arricchisce e accresce la possibilità di far credito tre volte tanto. Senza proporsi altro fine che quello di allargare il giro delle sub-banche genovesi, torinesi e fiorentine inserite nel gioco, la Nazionale sposta il risparmio regionale verso il Triangolo Industriale, come in appresso si chiamerà.
La disastrosa situazione in cui versa la Banca Nazionale alla soglia della guerra con l’Austria emerge dalle cifre rese note dalla sua stessa contabilità, anche se i patri ricercatori insistono a far finta di non vedere: il capitale, ammontante a 60 milioni, ma versato solo in parte, le riserve vicine allo zero. Una domanda viene in mente automaticamente: dove trovò le risorse per mettersi sotto tutta l’Italia, considerato che il giorno prima le mancavano 19 soldi per fare una lira? Il buco conoscitivo cade negli anni che vanno dall’estate del 1859 all’autunno del 1862, scatta, cioè, nel momento in cui l’esercito piemontese prende la rincorsa e si esaurisce quando il parlamento avvia la discussione sull’unificazione monetaria. Che fine hanno fatto le monete sabaude, le imperiali austriache, le ducali emiliane, le granducali toscane, le papaline di Romagna, Umbria e Marche? Gran mistero! Nel 1892 si pubblica il conteggio delle monete degli ex Stati ritirate dal governo italiano, ma non si capisce a partire da quando. Fatto sta che la loro quantità risulta notevolmente inferiore a quella che si era ritenuto esistesse prima dell’unità. Allora? Il mio personale giudizio è che Bombrini, senza discorsi di sorta, senza gridi di dolore, cominciò a fare gli italiani come gli stava più comodo. La confusione monetaria e la penuria di numerario era quanto gli serviva per ricattare e asservire lo Stato e i cittadini, e per ottenere dal governo e dal parlamento una vituperevole egemonia sulle altre banche. Ciò, naturalmente, non per il bene pubblico, come cantano i corifei della mala unità, ma per spremere i cittadini da vero usuraio. L’esistenza di una larga disponibilità di metalli preziosi, con i quali organizzare su basi nazionali la moneta unitaria e il credito a favore di tutti, è ampiamente attestata. Osserviamo la tabella che segue.
Raffronto tra le coniazioni preunitarie, la stima del numerario ancora circolante sotto il governo sabaudo e il numerario ritirato dal Regno d’Italia per la conversione(milioni di lire sabaude)
|
ex Stati |
A Monete coniate prima del 1859 |
B Circolante al 1862 Stima |
B %
|
Monete ritirate tra il 1862 e il 1870 |
Circola zione al 1870 |
C Monete ritirate Totale 1894 |
D Differenza tra B e C. |
|
Due Siclie |
801,1 |
457,5 |
43,3 |
355,3 |
102,2 |
433,7 |
-23,8 |
|
Provincie pontificie |
204,2 |
98,8 |
9,4 |
98,8 |
0 |
90,7 |
-8,1 |
|
Lombardo-Veneto austriaco |
201,5 |
112,3 |
10,6 |
112,3 |
0 |
8,1 |
-104,2 |
|
Veneto ex austriaco |
|
99,9 |
9,5 |
99,9 |
0 |
1,2 |
-98,7 |
|
Regno di Sardegna |
435,5 |
176,5 |
16,7 |
176,5 |
0 |
27,1 |
-149,4 |
|
Ducato di Parma |
11,1 |
19,9 |
1,9 |
18,7 |
1,2 |
1,2 |
-18,7 |
|
Ducato di Modena |
-
|
18,0 |
1,7 |
18,0 |
0,5 |
0,5 |
-17,5 |
|
Granducato di Toscana |
142,3 |
73,0 |
6,9 |
85,3 |
85,3 |
+12,3 |
|
|
Monete italiane d’argento a 835 carati |
|
27,0 |
+27,0 |
||||
|
Altre monete d’argento degli ex Stati |
|
17,3
|
+17,3 |
||||
|
Monete estere |
|
13,9
|
+13,9 |
||||
|
Monete già fuse |
4,6 |
+4,6 |
|||||
|
Totali delle colonne |
1.795,7 |
1,055,9 |
100,0 |
710,6 |
|||
|
Numerario scomparso (base: stima Sacchetti) |
-345,3 |
||||||
|
Idem in rapp. alle precedenti coniazioni |
-1.085,1 |
Giuseppe Sacchetti non era il primo venuto. A lui, il ministro dell’agricoltura, incaricato della conversione monetaria, chiese nel 1862 di preparare un quadro della situazione esistente. La sua stima è riportata nella colonna B. E’ da segnalare che altre stime autorevoli, come quella di Pietro Maestri, di Michele Avitabile, direttore del banco di Napoli, dello stesso Carlo Bombrini, superano quella di Sacchetti. Pertanto è ben difficile dubitare che di ben un miliardo e ottocento milioni di nuove coniazioni, che non erano tutta la circolazione, ma si erano aggiunte a quella già esistente sotto i governi napoleonici e coevi, non fosse rimasto quel miliardo stimato dal Sacchetti.
Ora, pur contribuendo con una massa monetaria percentualmente superiore all’intera area padana, il Sud ebbe un sistema creditizio a capacità limitata. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia poterono allargare le loro operazioni da meno di un decimo della Nazionale, prima del 1870, per arrivare a meno di un ventesimo dopo. In più furono handicappate con legge dello Stato e sottoposte alla curatela di Bombrini. E’ evidente che lo Stato italiano non aveva (e non ha), verso il Sud, altra politica che quella di portarne l’economia al totale fallimento; cosa che non è affatto in contrasto con un certo tipo di interventi speciali tipo Cassa per il Mezzogiorno, la quale servì ad alimentare gli sbocchi dell’industria del ferro e del cemento, nonché ad estrarre i contadini dalle campagne, al fine d’abbassare il livello dei salari operai.
In appoggio al sistema vigente, la storiografia italiana ha sostenuto e sostiene che detto fallimento va invece equamente distribuito tra i Borbone di Napoli e i meridionali. Qui si vuole sostenere non solo il contrario, ma anche che gli storici italiani sono degli autentici buffoni, qualche volta ben pagati.
La cosa risulta evidente attraverso i fatti e gli atti che andrò ricordando.
5 - Fatta l’Italia, in ogni regione l’esistenza della classe padronale si ritrovò a dipendere dal governo sabaudo, dal re e dalle sue truppe in campo. Gli assetti regionali preesistenti dovettero cedere il passo a quelli sabaudi e agli interessi della cosca di speculatori e usurai che, avendo ruotato intorno a Cavour, lui morto, la facevano da padroni. La mitologia piemontista, alimentata ad arte, fece il resto. Chiunque non fosse nato oltre Ticino venne a trovarsi in debito morale con la nuova patria. Con la scusa del pericolo mazziniano e persino del pericolo garibaldino, crebbe un clima d’intolleranza verso chi non consentisse con il gruppo dirigente. Gli atti parlamentari di quegli anni esalano un tanfo di arroganza e contemporaneamente di servilismo, di partigianeria e di faziosità. Il padronato fondiario, nell’affanno di trovare un baluardo contro le classi povere, si adattò a subire un monarca costoso e invadente, assieme al suo esercito di prussiani da operetta. Scrivono Rochat e Massobrio, esperti di cose militari: "Ci sembra significativa la priorità riconosciuta dal governo piemontese, attorno al quale si organizzò la borghesia italiana, alla costituzione di forze armate di sicuro affidamento e di grandi ambizioni, necessarie perché il nuovo stato potesse far fronte al duplice pericolo della pressione dall’esterno e della disgregazione interna". Credo che agli autori sia scivolata la mano allorché parlano di pericoli esterni. In effetti, né l’Austria, né l’Albania, né il Turco, né il Negus si sognarono mai di minacciare una guerra all’Italia. La Francia e l’Inghilterra imposero le loro condizioni, ma, al tempo, la stessa cosa facevano non solo con le popolazioni arretrate e con gli Stati minori della stessa Europa, ma persino con l’Impero russo. Fu semmai l’Italia a esibirsi in guerre che servivano soltanto a consumare uomini e materiali. Più aderente alla vicenda storica è invece il richiamo al pericolo di una disgregazione interna del nuovo Stato. Relativamente alla fase di fondazione dello Stato il riferimento va alla guerra di resistenza detta il Brigantaggio. Gli ambiziosi Savoia, finalmente pervenuti a livello degli Asburgo e dei Borbone dopo secoli di umiliante inferiorità castale, non seppero rinunziare alla corona di Napoli testé conquistata, come suggerivano d’Azeglio e altri. Le spese per l’esercito e la marina militare pesarono in misura disastrosa sul buon andamento dell’azienda Italia; oltre che, ovviamente, sulla condizione delle popolazioni. Queste, che già ereditavano le spese sostenute dagli ex Stati nel corso di un decennio di tensioni guerresche, dovettero accollarsi anche la nuova, ingiustificata e velleitaria follia.
Migliaia di lire sabaude
|
Anno |
Entrate complessive |
Uscite complessive |
Debito pubblico totale |
|
1852 |
418.475 |
446.218 |
1.310.360 |
|
1859 |
571.107 |
514.221 |
1.482.760 |
|
1860 |
469.115 |
571.277 |
2.241.870 |
Il debito pubblico non è fatto di cambiali a vista. Al contrario, mentre l’introito del tesoro è immediato, la restituzione – se mai ci sarà - è rimandata al futuro. Corrente è invece il peso degli interessi, come ben sanno gli italiani di sempre, compresi quelli d’oggi. Anche il cosiddetto debito flottante è di regola rinnovato, spinto in avanti; più spesso consolidato, che pagato. Comunque il nuovo Stato non aveva una scadenza di due miliardi e duecentocinquanta milioni, ma una di 124 milioni l’anno, a titolo di interessi a favore dei portatori di cartelle, con un’incidenza intorno a un quinto delle entrate.
|
Annualità del debito pubblico degli ex Stati, come calcolato retrospettivamente dopo la presa di Roma |
Lire |
|
Napoli |
26.003.633 |
|
Sicilia |
6.800.000 |
|
Lombardia |
5.534.193 |
|
Veneto |
3.890.169 |
|
Modena |
745.727 |
|
Parma |
424.186 |
|
Toscana |
4.020.000 |
|
Stato Pontificio |
22.459.518 |
|
Stato sabaudo |
54.921.696 |
|
Rendita da pagare annualmente dal nuovo Stato |
124.799.122 |
Mentre l’esercito regio sfogava la sua ferocia contro i valorosi contadini delle provincie meridionali (della nuova Italia), il re spendeva e spandeva come se avesse lui l’Impero inglese. Neanche Hitler e Mussolini caricarono sul bilancio pubblico percentuali simili di spese militari, deliberate da governanti in preda a un’evidente forma di follia western per i fucili, i cannoni e le corazzate. Per maggiore sciagura, insistettero sull’imbecillità tipicamente e programma-ticamente cavouriana di acquistare gli armamenti all’estero, anziché creare un’industria metalmeccanica nazionale. Ed è magra consolazione il sapere che non esiste una legge che renda obbligatorio, per gli storici, un minimo d’indipendenza di giudizio.
Entrate erariali ordinarie e spese militari
in cifre assolute e in percentuale dal 1862 al 1870
|
Anni |
Entrate ordinarie (riscosse) Milioni |
Spese per esercito e marina |
% |
Anni |
Entrate ordinarie (riscosse) Milioni |
Spese per esercito e marina |
% |
|
1862 |
771 |
484 |
63 |
1867 |
715 |
400 |
56 |
|
1863 |
511 |
239 |
47 |
1868 |
739 |
214 |
29 |
|
1864 |
565 |
465 |
82 |
1869 |
902 |
26 |
|
|
1865 |
637 |
385 |
60 |
1870 |
801 |
446 |
|
|
1866 |
609 |
715 |
117 |
Totali |
6.250 |
3.348 |
54 |
Le spese in armamenti assorbirono per oltre trent’anni una parte consistente delle entrate statali, causando a loro volta il vertiginoso aumento degli interessi sul debito pubblico e – di rimbalzo – la contrazione degli investimenti nell’industria e in agricoltura, cioè nei settori portanti della produzione e dell’esistenza umana.
Lo Stato italiano aveva un parlamento, eletto su base nazionale fra i possidenti, e un senato di nomina regia, i cui membri erano le persone più ricche del paese. Le eccessive spese dello Stato percuotevano fortemente anche la rendita fondiaria. E’ difficile infatti che - ieri come oggi - il proprietario compia una soddisfacente traslazione dell’imposta su altri soggetti economici, in quanto in agricoltura vige una concorrenza perfetta tra i produttori della medesima area economica. Inoltre, quando la terra è sovraccarica di braccia, il rapporto tra il contadino-produttore e il proprietario percettore della rendita è influenzato più dalla pressione demografica (dalla fame delle famiglie coloniche e bracciantili) che dalla pressione fiscale. Logica avrebbe voluto che i redditieri, che erano una fetta numericamente importante del parlamento italiano, si muovessero contro le smodate spese statali. Storicamente i parlamenti erano nati proprio per questo, eppure non le contrastano più di tanto.
Perché? Prima di tutto perché i quattro quinti di questi signori dovevano mostrare la loro lealtà al quinto piemontese, che faceva da metro morale e patriottico dell’italianità. Poi perché sul quinto piemontese gli speculatori esercitavano una vera egemonia culturale. La gente che ingrassava sulla spesa pubblica, specialmente su quella militare, era legittimata dal credo cavouriano del protezionismo dall’interno.
Parallelismo tra spese militari
e pubblico indebitamento
(milioni di lire correnti)
|
Anni |
Spese militari |
Nuovo debito pubblico |
|
1861 |
500 |
|
|
1862 |
368 |
|
|
1863 |
675 |
|
|
1864 |
995 |
|
|
1865 |
1.245 |
925 |
|
1866 |
1.624 |
1.525 |
|
1867 |
1.844 |
1.775 |
|
1868 |
2.011 |
2.025 |
|
Debito degli ex Stati |
2.242 |
|
Non essendo sufficienti le entrate, i governi nazionali indebitavano i contribuenti con chi all’interno e all’estero poteva prestare dei soldi allo Stato. A pagare avrebbero provveduto le future generazioni. Per la verità questa forma di tortura dei popoli non era stata inventata dal defunto Cavour o dai suoi corifei. Si trattava in effetti di una pratica corrente da secoli in Gran Bretagna e altrove. Applicata all’Italia-una essa ha portato un gran bene al Nord, come tutti possono vedere dai risultati, e ha rovinato il Meridione, come tutti possono vedere dai risultati. La sua consistenza fu ben tratteggiata, nel 1867, da Giovanni Lanza, futuro presidente del consiglio. "Negli anni 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 abbiamo ricorso al credito, onde sovvenire ai bisogni dell’erario, per una somma non minore di 3 miliardi, la quale somma ci è costata 4 miliardi e mezzo (a causa della forte differenza tra il prezzo di emissione dei titoli di Stato e il prezzo a cui si riusciva a collocarli, ndr). Aggiungansi le somme che dovettero spendere le Società anonime per i lavori pubblici (in sostanza lo stesso Stato, ndr), per la costruzione di strade ferrate, ed è probabile che si possa aggiungere un altro miliardo alla somma testé detta. In quegli anni una buona parte della circolazione non appartenne, né rimase nel paese" . Cioè il danaro necessario a produrre le attività dello Stato venne da fuori e tornò da dove veniva. Ma meglio sarebbe dire: cominciò a tornare da dove veniva, perché l’indebitamento estero non potrà essere estinto che 35 anni dopo, con le rimesse degli emigranti.
Il gabinetto Rattazzi, entrato in carica all’inizio del 1862, ebbe fra i suoi componenti Gioacchino Napoleone Pepoli, a cui fu affidato lo storico incarico dell’unificazione monetaria. Il compito non era certamente superiore alle sue forze perché nella penisola circolavano oro e argento a sufficienza per portare rapidamente a termine la ri-coniazione delle vecchie monete. C’era inoltre una decina di zecche, alcune delle quali abbastanza efficienti, fra cui meglio delle altre quella di Napoli. Ma lo scopo non dichiarato dei governi nazionali era tutt’altro che dotare gli italiani di una sola moneta metallica; per essere ben precisi, quello d’inondare un paese nolente con le fasulle cartacce di Bombrini. Le ribellioni dovettero essere molte di più di quelle che conosciamo. A noi è giunta soltanto l’eco di quella toscana e di quella napoletana. La storiografia fa di tutto per sorvolare su queste cose, ma, se il lettore torna indietro di qualche pagina e scorre l’elenco degli insediamenti locali della Banca Nazionale, troverà un bell’esempio. Si accorgerà che la pupilla degli occhi nostri non mise piede in Toscana prima del 1865. Sta di fatto che la classe dirigente toscana, Ricasoli e Peruzzi in testa, non intesero lasciare il campo a Bombrini senza che questi venisse a patti e che desse un compenso. E in effetti il compenso ci fu, e fu il trasferimento della capitale del Regno da Torino a Firenze.
Invece a Napoli l’opposizione fu alquanto timida e, vista a posteriori, fin troppo ingenua. I grossi commercianti, che naturalmente non vedevano di buon occhio l’ingresso della Nazionale, appena fatta l’Italia, tentarono di fondare una loro banca d’emissione, con un capitale doppio rispetto alla Nazionale, ma Cavour si oppose fieramente, in ciò sostenuto dall’imbecillità o dalla malafede di gran parte dei patrioti napoletani. Fallito il tentativo, le classi mercantili cittadine tentarono di rianimare il Banco delle Due Sicilie, che venne diviso e ribattezzato Banco di Napoli sul continente e Banco di Sicilia nell’isola. Da quel momento ha inizio la resistenza secolare dei banchi meridionali per non fare da tappetino alle banche padane; in verità, una resistenza mal gestita (nel senso che non si possono servire due altari) e conclusasi in anni recenti con un vergognoso tracollo. Una resistenza ben più fiera ingaggiano le popolazioni per non farsi fregare dal patrio governo, il quale si logora per tre decenni nel cinico tentativo di fregargli l’oro in cambio di carta. Ma alla fine l’elmo di Scipio la vinse. Nel 1892, d’oro e d’argento circolanti in Italia era rimasto soltanto il ricordo. Bombrini era già morto da una decina d’anni, ma era vissuto a sufficienza per tenere a battesimo l’intraprendente e nobile borghesia del futuro Triangolo Industrial-parassitario, la quale, una volta allenato lo stomaco, digerì anche la Banca Nazionale. Eppure nessuna banca privata al mondo ebbe ai suoi piedi uno Stato più servile. Gli storici non hanno il coraggio di dire che, nelle città e nei paesi del nuovo Regno, mai si presentò un funzionario pubblico a svolgere l’operazione di convertire l’oro o l’argento con l’effigie di un sovrano vinto, con oro e argento recante il laido profilo di Vittorio Emanuele, Padre della Patria, sebbene figlio non si sa di chi. In realtà, le nuove coniazioni di numerario arrivarono in tutto a 416 milioni, a fronte degli ottocento circa ufficialmente ritirati dal tesoro (ma chissà quanti sottobanco da Bombrini!). Il ritiro del circolante metallico fu, politicamente, una subdola espropriazione del povero da parte di una società privata, la quale approfittò impudicamente delle circostanze per aumentare le sue riserve metalliche, onde emettere cartaccia per tre volte tanto; cosa che comportava un doppio guadagno (o furto): il valore dell’oro incamerato e gli interessi sui biglietti prestati ai clienti. Il tutto fondato su nient’altro che la connivenza dello Stato.
Coniazioni italiane dal 1862 al 1867
|
in oro |
192.400.145 |
|
in argento 900 |
5.000.000 |
|
in moneta divisionaria d’argento |
163.000.000 |
|
in bronzo |
56.000.000 |
|
in totale |
416.400.145 |
Ovviamente la ribalderia, come ogni ribalderia politica, aveva una finalità di classe. E qui bisogna essere estremamente chiari. In effetti una classe di capitalisti, nel senso che i trattati d’economia anglosassoni danno al termine, l’Italia l’ha potuta avere solo negli ultimi cinquant’anni. O meglio, in Italia chi guidava veramente delle imprese industriali, piccole, medie o grandi, era all’opposizione verso Cavour e i suoi corifei; cominciò a contare solamente a partire dai tempi di Crispi. Prima degli anni di fine secolo, fu una frazione del capitalismo, quella che praticava la speculazione sul debito pubblico, sull’indebitamento dell’erario - in sostanza le banche del futuro Triangolo Industriale - ad esercitare il potere di controllo sugli affari dello Stato. Il tema della formazione del padronato nazionale italiano, affrontato con vigore da Emilio Sereni nell’immediato dopoguerra, è stato però ignorato dagli storici sedicenti gramsciani, probabilmente in omaggio a togliattiane doppiezze. Scrive Sereni (Capitalismo e mercato nazionale in Italia): "Per un Bastogi o per un Cambray-Digny, per un Balduino o per un Ricasoli, per un Bombrini o per un Peruzzi, che - insediati in una poltrona ministeriale o dagli uffici delle [Ferrovie] Meridionali, dal loro scanno in parlamento o dagli sportelli della banca nazionale o del Credito mobiliare – già controllano le leve economiche e politiche decisive del paese, una politica di ‘intervento’ dello Stato è in realtà […] il loro pane quotidiano: essi la realizzano stipulando, da ministri o da amministratori delegati, convenzioni ferroviarie come quelle per le Meridionali; con operazioni come quelle per la Regía cointeressata, ovvero con l’imposizione del corso forzoso".
Il tema del capitale fittizio impostato da Marx e approfondito poi, al tempo della Seconda Internazionale Socialista, sembrerà un ectoplasma ai servili storici della mala unità. Diversamente dal capitale reale, esso non produce alcunché. Nella sua versione italiana corrisponde alla vergognosa speculazione sui titoli pubblici, mediante la quale il capitalista nasce dal nulla. Infatti, il possessore di danaro, vicino alle banche, arriva ad arricchirsi mettendo ben poco oro e ancor meno rischio. Da carta, per avere carta, di cui lo Stato raddoppia la cifra a ogni giro di carta. Venne fuori un fiume di carta, che divenne un reale potere di comandare lavoro man mano che tutta Italia divenne un mare di sola carta. Volendola dire in modo diverso, si può tranquillamente affermare che il comando della borghesia padana sull’Italia non nacque dalla sua capacità di produrre e guadagnare, ma da un mare di carta che – quando alla fine l’oro vero scomparve completamente dalla circolazione - lo Stato trasformò, con la sua bacchetta magica e con i moschetti dei reali carabinieri, in capitale vero, in un potere di comandare lavoro mai posseduto, mai prodotto e forse mai sognato.
Non si tratta delle esagitazioni verbali di un antitaliano viscerale, come il sottoscritto. Prosegue, infatti, Sereni: "Il danaro che lo Stato ha preso in prestito, in effetti, è stato già da tempo speso per le sue necessità, ed è stato, comunque, generalmente usato come mezzo di pagamento di precedenti debiti, per la guerra, la pubblica sicurezza ecc., e non come capitale capace di produrre un profitto ed un interesse; il che resta vero anche nel caso in cui (come avviene, ad esempio, per le spese in opere pubbliche) quel denaro sia stato erogato a fini che possono essere considerati produttivi da un punto di vista sociale. I titoli del debito pubblico, pertanto […] non sono e non possono essere rappresentativi di un capitale realmente esistente. Essi rappresentano esclusivamente un diritto di prelievo – da parte di chi li detiene – sulle future entrate dello Stato (sottolineatura del redattore.).
A passarsela male furono i poveri particolari. Se a qualcuno venisse in mente di fare un’antologia degli interventi parlamentari sulla condizioni create fra la gente dall’ingordigia bombrinesca, dovrebbe prevedere un opera in dieci volumi di duemila pagine ciascuno. In Italia si arrivò al punto che, per cambiare un biglietto da cento lire in venti monete da cinque lire, bisognava pagare un pizzo di venti lire, e che, per bere un caffè, bisognava mettersi in giro a incettare un bigliettino monetario emesso dalla stessa caffetteria o dal macellaio della porta accanto, avendo Bombrini saccheggiato anche lo spezzato di ottone e di rame. Eppure, anche per gli spiccioli l’eredità degli ex Stati era tale che essi avrebbero dovuto del tutto abbondare. La cassaforte di Bombrini, che conteneva, nel 1858, appena 5,7 milioni di riserve metalliche, nel 1866 si trovò ad averne per ben 400 milioni.
6 - Il 1 maggio 1866, la Banca Nazionale ottenne dal napoletanissimo ministro delle finanze, Antonio Scialoja, il corso forzoso dei suoi biglietti. Per gli italiani si trattò di un disastro peggiore di una guerra perduta. A quel punto, il parlamento pretese una commissione d’inchiesta, che fu diretta dal capo della massoneria italiana, Filippo Cordova. Si voleva appurare se il deliberato rastrellamento d’oro e d’argento fosse una reale necessità dello Stato, in vista di quella che sarà chiamata la terza guerra d’indipendenza, o se esso non fosse – come al tempo si disse senza reticenze - un marchingegno escogitato da Bombrini, che si era troppo esposto con i suoi fuochi d’artificio cartacei e non aveva più risorse da mettere in campo per aiutare le banche genovesi e torinesi - a cui si era aggiunta una succursale fiorentina - facenti parte del sistema del protezionismo dall’interno.
|
Distribuzione percentuale delle concessioni di credito da parte della Banca Nazionale nell’anno 1865 a favore di: |
|
|
banchieri e stabilimenti di credito |
84% (98,6 milioni) |
|
industriali |
12% (13,5 milioni) |
|
proprietari |
4% (4,7 milioni) |
Bombrini perse la battaglia con la Commissione, che giudicò il corso forzoso non necessario allo Stato, ma vinse la guerra, in quanto il corso forzoso non fu revocato. Solo nel 1874, dopo otto anni di bengodi, finalmente Sella ebbe l’ardire di togliere alla Nazionale il privilegio delle emissioni. Da quel momento una parte delle banconote fu emessa gratis, su comando governativo e come debito dello Stato, mentre la Nazionale continuava a prestare soldi a interesse stampando la sua carta.
La documentazione raccolta dalla Commissione e le memorie prodotte in quell’occasione dalle banche e da personalità politiche, sono – insieme agli Atti Parlamentari – fra i pochissimi testi non mistificatori sul processo unitario. Nella mole dei documenti tramandatici dalla Commissione d’Inchiesta ce n’è uno esibito da Bombrini, che attesta un’elevata importazione d’oro tra il 1860 e il 1867.
Importazioni di metallo da parte della Banca Nazionale
|
1860 |
49.366.000 |
1864 |
151.579.900 |
|
|
1861 |
111.832.715 |
1865 |
152.497.400 |
|
|
1862 |
118.360.200 |
1866 |
43.094.000 |
|
|
1863 |
171.790.190 |
In totale |
798.520.405 |
Cosa dire? O l’oro tornava veramente in Francia, un po’ apertamente un po’ sottobanco, o si trattò di una delle solite bugie del direttore della Nazionale. Se nella circolazione fosse stato insufflato oro mediamente per circa 130 milioni l’anno, come mai non si arrivò alla conversione delle monete pre-unitarie? Come mai si arrivò al corso forzoso dei biglietti?
Il fatto è che Bombrini voleva tutto. La tabella seguente disegna il drenaggio operato dalla Nazionale, ex Stato per ex Stato. La conquista della Lombardia e delle altre regioni, fino al Lazio, portò alla Nazionale oro quanto bastava a salvarla e quanto mai aveva avuto in cassa. La conquista del Napoletano e della Sicilia, essendo l’argento il medio circolante nelle Due Sicilie, portò essenzialmente argento. E sebbene i duesiciliani recalcitrassero nello sborsarlo, ne portò a sufficienza perché la nave corsara potesse alzare la vela sull’albero di maestra. Da un potere di comandare lavoro, che si aggirava sui 40 milioni nel 1858, il nostro Fratello della Costa, già nel 1865 arrivò a comandare per oltre il miliardo. Raddoppiando poi a ogni giro della rendita, che nel 1881 arrivò alla cifra di nove miliardi, la quale ci riempie d’orgoglio nazionale, dato che siamo i discendenti dei fessi che pagarono.
Metalli preziosi costituenti la riserva della Banca Nazionale
Prima della virgola: milioni di lire italiane dell’epoca
(un milione pari a circa otto miliardi del 2000)
|
Anni |
Oro |
Argento |
Periodi |
|
1858 |
2,791 |
2,918 |
Sotto il Regno sabaudo ► 5,709 |
|
Sotto il Regno d’Italia subito dopo l’espansione in Lombardia, Emilia, Romagna, Umbria, Marche |
||||
|
1859 |
11,183 |
1,194 |
▼
Oro 51,921 |
▼
Argento 8,430 |
|
1860 |
24,245 |
2,421 |
||
|
1861 |
16,493 |
4,815 |
||
|
Subito dopo l’espansione nel Napoletano e in Sicilia |
||||
|
1862 |
11,080 |
14,123 |
▼
32,026 |
▼
44,085 |
|
1863 |
11,762 |
14,554 |
||
|
1864 |
9,184 |
15,408 |
||
|
Dopo la resa dei capitalisti fiorentini e prosecuzione della precedente incetta |
||||
|
1865 |
18,187 |
28,003 |
▼ 33,437 |
▼ 47,931 |
|
1866 |
15,250 |
19,928 |
||
|
Subito dopo l’incorporazione del Veneto e del Mantovano |
||||
|
1867 |
55,226 |
19,895 |
▼ 114,125 |
▼ 59,653 |
|
1868 |
58,899 |
39,758 |
||
|
Drenaggio compiuto nei soli anni indicati |
179,588 |
151,669 |
||
|
Totale |
331,257 |
|||
|
Potere di comandare lavoro |
993,771 |
|||
Elaborazione, su Atti della Commissione Parlamentare d’Inchiesta (1867-68)
6 - Abbiamo visto che l’espansione della Nazionale fu rapida. Usando illecitamente le tesorerie provinciali, come risulta chiaramente dagli Atti citati, essa incamerava metalli e pagava con biglietti, una cosa che sconvolse l’economia delle regioni conquistate. Se riesaminata con occhi limpidi (invece che con gli occhi torbidi dei giustificazionisti sabaudi e costituzional-repubblicani, nonché gramsciani per avere ricevuto l’acqua santa al fonte battesimale) la politica nazionale della Banca Nazionale si rileva provinciale, unilaterale, coscante; non certamente la politica di una banca che si proclamava nazionale nel Regno d’Italia (ricco di glorie guerriere e industriali).
Dagli Atti citati riprendo i dati relativi agli sconti e alle anticipazioni concessi nelle città in cui la Banca Nazionale aveva una sede. Nessun commento politico. Il lettore osserverà da sé la patriottica gestione dell’oro nazionale. E solo se lo farà, potrà cominciare a capire il perché l’unità abbia infognato per sempre il Sud.
Banca Nazionale nel Regno d’Italia – Anno 1865
|
|
Sconti |
% |
Anticipazioni |
% |
|
Firenze |
11.271.931 |
3,2 |
1.739.986 |
1,2 |
|
Genova |
103.244.544 |
29,3 |
11.322.056 |
7,8 |
|
Milano |
92.904.371 |
26,4 |
33.453.642 |
23,1 |
|
Napoli |
23.079.839 |
6,5 |
32.041.142 |
22,1 |
|
Palermo |
21.395.973 |
6,1 |
16.716.642 |
11,5 |
|
Torino |
100.326.070 |
28,5 |
49.702.628 |
34,3 |
|
|
352.222.728 |
100,0 |
144.976.096 |
100,0 |
Solo qualche informazione a margine. Gli sconti attengono alle cambiali sottoscritte da mercanti, di regola con scadenza a tre mesi. Era, però, buon uso rinnovarle ai clienti meritevoli, a volte per anni o del tutto per decenni. Le anticipazioni venivano concesse a parole su valori metallici, su merci e su titoli, ma durante il regno della Nazionale le anticipazioni su titoli occuparono la voce al 99 per cento. La tabella esclude Venezia, la cui conquista era ancora fresca e dove la Nazionale aprirà un’altra sede, e Roma, che in appresso diverrà, ma solo formalmente, la sede centrale; in effetti una specie di sede d’ambasciata presso il governo. Le cifre relative a Firenze sono basse in quanto i Toscani, come già segnalato, contrastarono a lungo l’apertura di una sede della Nazionale a Firenze e di sue succursali nelle città minori, arrendendosi solo quando, in seguito a un accordo con Napoleone III, il parlamento (nel 1865) decise di trasferire la capitale d’Italia da Torino a Firenze. A partire dall’anno successivo, Firenze passa in testa e vi rimane fino a quando la capitale non viene trasferita a Roma. L’ammontare degli sconti su Genova, Torino (capitale) e Milano, fra loro sommati, è vicino al 90 per cento. Napoli e Palermo assieme fanno il 12,6 per cento degli sconti.
Positivo appare il flusso di moneta creditizia in Sicilia; un’autentica stranezza nazionale italiana, che merita d’esse spiegata. Nel clima di fottisterio bancario da lui inaugurato, Bombrini decise di fottersi le consistenti riserve metalliche del Banco di Napoli. Si dette il caso che i banchieri napoletani non fossero tutti scemi. Qualcuno capì la cosa, così si corse a chiudere la riserva dentro mura difensive. Bombrini, però, era genovese, era cioè un non indegno figlio della città che per cinque secoli aveva imposto le sue usure al Regno napoletano. Da abile furfante qual era, si accordò con il Banco di Sicilia che, per contratto, cambiava a vista le fedi di credito del Banco di Napoli. Tutte le fedi, che la Nazionale incontrava nella sua passeggiata militare italiana, finivano il Sicilia, convertite in oro dal Banco di Sicilia, che allegramente sborsava, e che il Banco di Napoli stizzosamente gli rimborsava.
L’aperta contraddizione regionale tra incetta di moneta metallica e funzione bancaria salta immediatamente agli occhi. La Banca Nazionale polarizza la sua funzione creditizia nelle regioni in cui esiste già un giro di clienti a lei noti, allenati alle sue tresche e ben avvertiti circa il fatto che gli italiani. – fatti tali dai loro amici e consorti – sono dei polli da spennare.
Al tempo di Bombrini il Sud era lontano da Torino e da Genova molto più di Parigi e di Londra, e viceversa, Torino era lontana da Napoli molto più di Odessa. Le succursali meridionali della Nazionale non erano che avamposti di tipo coloniale; dei castra che bisognava avere in loco per lucrare splendidamente l’argento coniato dalle zecche borboniche. Certo, in ogni cosa ci vuole un pizzico di stile, e così le succursali meridionali qualche anticipazione la effettuavano pure. In tal modo Bombrini salvava la faccia, e l’Italia si accaparrava altri fans. Ma niente di più.
8 – Anche la tabella che segue si commenta da sé. La sola cosa da ricordare è che, nonostante la Nazionale si comporti come se essa stessa fosse lo Stato in prima persona, si tratta sempre di una banca privata, che fa affari privati, di privati. Gli storici del regime italiano commentano positivamente la sua vicinanza allo Stato. Anche gli usurai fiorentini e genovesi erano vicinissimi ai re e ai viceré spagnoli di Napoli. Ma lo erano per meglio spolparli. I Borbone risuscirono a interrompere la secolare servitù, e basterebbe questo soltanto per renderli meritevoli agli occhi di chi la pensa come me. Fatta l’Italia, l’antico legame feudale fu interamente ripristinato.
Immissione in circolazione di biglietti da parte della Banca di Genova, poi Banca Nazionale del Regno di Sardegna, infine Banca Nazionale nel Regno d’Italia (dante causa della Banca d’Italia).
|
Al |
Ammontare della emissione |
Totale nel periodo |
Totale progressivo |
|
Fino al luglio 1851 |
58.000.000 |
||
|
1 luglio 1855 |
52.000.000 |
||
|
8 gennaio 1857 |
7.000.000 |
||
|
1 maggio 1859 |
2.000.000 |
||
|
21 luglio 1859 |
5.000.000 |
124.000.000 |
124.000.000 |
|
31 gennaio 1860 |
40.000.000 |
||
|
14 agosto 1860 (da venti lire) |
2.000.000 |
||
|
9 gennaio 1861 |
2.000.000 |
||
|
12 agosto 1861 |
40.000.000 |
84.000.000 |
208.000.000 |
|
14 gennaio 1862 |
28.000.000 |
||
|
13 gennaio 1863 |
90.000.000 |
||
|
13 gennaio 1864 |
10.000.000 |
||
|
12 luglio 1864 |
5.000.000 |
||
|
21 febbraio 1865 |
32.200.000 |
165.200.000 |
373.200.000 |
|
23 gennaio 1866 |
7.000.000 |
||
|
16 maggio 1866 |
223.000.000 |
||
|
idem (da dieci lire) |
20.000.000 |
||
|
12 giugno 1866 (da dieci lire) |
20.000.000 |
||
|
25 luglio 1866 |
378.000.000 |
||
|
17 ottobre 1866 |
30.000.000 |
||
|
13 gennaio 1867 |
34.000.000 |
||
|
30 ottobre 1867 |
107.400.000 |
||
|
22 gennaio 1868 |
40.000.000 |
859.400.000 |
1.232.600.000 |
|
Biglietti bruciati |
33.495.410 |
1.199.104.590 |
L’introduzione di fatto del regime cartaceo ridusse sostanzialmente il potere di comandare lavoro in mano ai napoletani. La mala unità distrusse Napoli come capitale politica, artistica, culturale, senza peraltro alimentare la crescita delle città provinciali. L’annientamento di Napoli corrispose a un preciso progetto cavouriano. A differenza dei lombardi, i napoletani avevano già uno Stato indipendente e un mercato nazionale, le loro ferrovie - disponendo di migliaia di chilometri di costa - erano sul mare e il trasporto costava poco. Certo, qualunque re è un despota e qualunque autorità provvede prima a se stessa, ma diversamente da quel che si legge nella cartellonistica pubblicitaria inserita nei libri di storia, il governo borbonico era disamato solo dagli assertori della forma costituzionale di governo, i quali, poi, al Sud erano la classe che intendeva espropriare i contadini dagli antichi diritti promiscui. Inoltre, nella direzione economica del paese i Borboni operarono sicuramente con idee molto più moderne di quelle, servilmente decantate, di Cavour. Del tutto, in materia d’industria precorsero di cinquant’anni le scelte dei governi nazionali italiani, tant’è che, prima dell’avvento di Cavour al governo, il Piemonte comprava le locomotive per le sue prime ferrovie dalla napoletana Officina di Pietrarsa. Il regno napoletano non era certamente splendido e felice, ma almeno era indipendente; veramente nazionale, essendo Carlo III figlio di un’italiana e di cultura italiana. Però il regno si trascinava, senza riuscire a risolverli, anzi senza averli mai affrontati seriamente, due problemi: (uno) l’assetto delle campagne, sia dal lato dei rapporti sociali, sia dal lato del livello tecnico, (due) la posizione subalterna della Sicilia. Insieme con il crollo, per mano di Napoleone III e dei suoi soldati (e non per mano di Vittorio e dei suoi generali imbecilli), dell’esercito austriaco, che garantiva i proprietari italiani, furono i problemi irrisolti a permettere il rapido successo della spedizione garibaldina.
Non minori furono i danni provocati dall’evirazione di Napoli nel settore finanziario. Questo era tutt’uno con quello mercantile. I mercanti napoletani - molti di origine straniera - erano prima di tutto dei finanzieri che speculavano sul prezzo delle derrate. Generalmente molto ricchi di proprio, avevano anche un facile accesso al pubblico risparmio, emettendo una specie di obbligazione su merci, detta ordine su derrate, formalmente consistente nell’obbligazione di consegnare una data merce - di solito grano o olio - a una certa data. In realtà nessuno dei sottoscrittori voleva acquistare veramente olio o grano, ma avere il suo controvalore al prezzo corrente alla scadenza, che ovviamente si sperava aumentato. Insieme alla borsa titoli, la borsa merci, a Napoli, era alquanto popolare e ogni borghese si atteggiava a intenditore, giocando al rialzo o al ribasso.
Finita la finanza, a causa il disorientamento dei più, provocato dalla politica punitiva e straniera dei piemontesi, e per la fuga delle case forestiere (la famiglia di don Carlo Rothschild andò via nel 1863, il tempo di riscuotere i crediti e di fare le valigie), finì anche la polarizzazione del capitale mercantile e del capitale navale. L’uno e l’altro resistettero alquanto bene nelle province, ma una volta dispersi persero la vecchia coesione di classe che si oppone al sistema feudale della rendita. Anzi, nell’ex regno duosiciliano, avvenne la stessa cosa che era avvenuta nel Seicento con il declino della manifattura tosco-padana: i mercanti si trasformarono un po’ tutti in agricoltori; cosa che dette vita a quella rivoluzione agraria meridionale, di cui molto ebbero a giovarsi, tra il 1863 e il 1890 circa, la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti italiane; rivoluzione agricola bruscamente interrotta dalla guerra doganale con la Francia e conseguente fuga dei lavoratori Oltreoceano.
La guerra perduta dal Meridione fu ed è una guerra capitalistica. Il capitale, chiarì una volta per tutte Adam Smith, altro non è che potere di comandare lavoro libero (proletariato) per una mercede giornaliera (salario). Chi non dispone di un capitale, vero o fiduciario, non può assumere salariati. Chi ha un fondo di ricchezza monetata, ma non vede la possibilità di trarne un lucro anticipando dei salari ai proletari, non ha (o non ha più) un capitale, ma soltanto dei soldi, che in genere presta al capitalista disposto a pagargli un interesse.
Napoli è finita allo stesso modo del suo celebre Teatro San Carlo. Nel 1850 era ancora il primo teatro d’Italia e del mondo, oggi neppure i maestri di origine meridionale gli danno un minimo di considerazione. Dico di più: oggi la gente si fa convincere dagli imbonitori della Tv che La Scala di Milano è sempre stata il più prestigioso teatro lirico d’Italia.
prima e dopo l’unità sabauda
|
Due Sicilie (lire sabaude) |
|||||
|
|
Circolazione metallica |
Numerario presumibilmente convertito in biglietti o fedi di credito |
Circolazione di carta fiduciaria |
Potere di comandare lavoro in cifra assoluta |
1865 su 1858 % |
|
1858 |
367.500.000 |
90.000.000 |
89.000.000 |
546.500.000 |
100 |
|
1865/70 |
102.200.000 |
144.000.000 |
246.200.000 |
45 |
|
|
Antiche province dei Savoia (lire sabaude) |
|||||
|
1858 |
208.800.000 |
57.000.000 |
265.800.000 |
100 |
|
|
1865 |
0 |
208.800.000 |
636.000.000 |
844.800.000 |
318 |
Per il Sud italiano la morte della lira celebra di una servitù che dura da 140 anni. Non abbiamo niente da glorificare, se non la nostra schiavitù in Egitto. E siamo ancora ben lontani dalla fine e ben lontani anche dalla speranza che prima o poi la fine arriverà. Non solo Cristo si è fermato a Eboli, ma si è fermata anche la Fortuna, la dea bendata che non ama i pavidi.
Nicola Zitara
Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.