
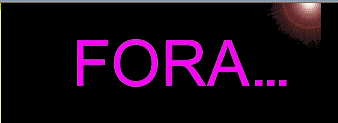
Questo racconto sviluppa una tematica appena accennata in “Memorie di quand’ero italiano”. Ho deciso di pubblicare in formato HTML il testo dato alle stampe in modo che possiate leggerlo ed eventualmente poi decidere di aquistare la versione cartacea. Spero che vi piacerà.
Nicola Zitara – Editore in proprio – Siderno, Piazza Portosalvo 1
La tiratura della presente opera è stata di 1000 copie
PROPRIETÀ RISERVATA
________________________________________________________
Luoghi, personaggi principali e loro genealogie
Paolo (o Paolino) Alfano, che narra la sua storia
Vitulia Surrenti, amata dal predetto
La vicenda si svolge a San Policarpio, un paese della costa jonica reggina, e a Capursi, un paese della Costiera Amalfitana, tra il 1932 circa e il 2001Famiglia AlfanoGeneroso (o Genso), padre di Paolino
Padron Paolo (o Patreppaolo), padre di Genso e nonno di Paolino
Padron Gioacchino (o Patreggiacchino), padre di Padron Paolo, bisnonno di Paolino
Zio Generoso, fratello di Padron Paolo
Ritratto di zio Gioacchino, (o Zio Giacchino), fratello del padre di Paolino
Paul, figlio di Paolino.
Zio Paolino Conforti, il Capitano, nipote di Padron Gioacchino Famiglia SurrentiTotò, padre di Vitulia
Zio Ferdinando, cognato di Padron Paolo, marito di zia Minicuccia e padre di Totò,
Norina, moglie di Totò
Nando (o Nandino), fratello di Vitulia
__________________________________________________________6
Godo di una bella pensione e di consistenti rendite, che non so come spendere. Non mi piace viaggiare, i miei bisogni sono modesti, i miei congiunti sono anche loro benestanti. I soldi in più li devolvo mensilmente al mio amico Willy Hauser che pubblica a Boston una rivista su macchine e macchinette meno inquinanti.
La mia esistenza di vecchio scorre tranquilla. Una parte della mattinata studio, faccio calcoli e disegno. La seconda parte la passo in mare con Oreste, un macchinista del cantiere Diaz, a provare e mettere a punto il prototipo di un motore da 360 cavalli, di cui il mio vecchio principale – nonché mio consuocero - ha comprato il brevetto. Al pomeriggio, Mara, mia nuora, viene a stirare la mia biancheria e a riassettare le tre stanze del vecchio palazzo dove vivo, le quali, per la verità, sono state già rassettate in mattinata dalla signora polacca ingaggiata a ore per lavare le scale. Ma mia nuora è siciliana come lo era mia madre, e in Sicilia vige un duro statuto riguardo alle donne, ai loro vecchi e alla casa dei loro vecchi.
Con Mara, vengono anche Lino e Nina, i miei nipotini, ma la reciproca comunicazione è quasi inesistente. Sono nato in un mondo in cui i ragazzini erano parecchio rispettosi degli adulti, ma anche discoli,
7
maneschi e malvestiti, cosicché questi “omini anticipati” di collodiana memoria mi piacciono poco. Anzi, a dire il vero, mi disturbano. Durante il tempo che Mara e i suoi figlioli armeggiano per casa preferisco starmene sul terrazzino. A quell’ora l’ex senatrice Vitulia Surrenti attraversa il passaggio a livello ferroviario assieme a una badante, e si dirige verso quel che resta del caricatoio, trascinandosi dietro suo marito Karl, semiparalizzato da un ictus ormai da trenta e più anni. Affacciarsi costituisce un dovere di cortesia, perché le due donne, quando attraversano il binario, non dimenticano mai di guardare dalla mia parte e di alzare un braccio in segno di saluto.
San Policarpio è il paese dove sono nato e cresciuto. E’ un abito noto che porto con agio, eppure è come se non lo conoscessi. Ciò dipende dal fatto che ho vissuto altrove la mia vita di lavoratore e i lunghi anni di carcere che l’hanno preceduta. Nel frattempo le vecchie generazioni sono scomparse, il paese si è dilatato e le attività che vi si svolgono sono radicalmente cambiate.
Ma questo è scienza del poi. Prima vivevo a Messina, dove ero di casa e dove avevo amici e parenti. Se fossi rimasto lì, la mia vecchiaia non sarebbe trascorsa né solitaria né triste. Però sentivo il bisogno di rivivere il mio mare, di godermelo da un balcone della casa avita. Perché – mi dicevo – il mare è sempre lo stesso. Quel che cambia sono le coste e la luce. Difatti, il mare che vedevo da Camaro, sulla prima balza dei Peloritani, era sfavillante, splendido, accecante.
Lo Stretto è uno scenario che distrae. L’aria è trasparente, i paesaggi marini sono tali e tanti, che fanno venire il capogiro, mentre io sentivo il bisogno opposto: di salutare quietamente il mondo che si allontanava da me, senza farmi abbagliare dalle cose. In concreto desideravo avere sotto gli occhi il mio mare, che si stende libero e senza
8
altro confine che il cielo.
Tranne i magazzini, che sono dati in affitto, prima del mio ritorno il resto del palazzo era come abbandonato. Cosicché l’ho fatto rimettere in ordine. Il primo piano l’ho donato alla biblioteca comunale, per cui il luogo ha, sì, cambiato funzione, ma è tuttora vitale. La mattina ci viene qualche persona matura: insegnanti, giornalisti, studiosi, lettori generici a prendere in prestito un romanzo; al pomeriggio arrivano i ragazzi a fare le ricerche loro assegnate. Hanno fretta di sbrigarsi. Per far presto, copiano l’uno dall’altro. Vociano e sciamano per le scale, giocano nel cortile intorno ai due vecchi ippocastani, calpestano le aiuole.
La giovinezza è sempre vitale, spensierata, amante dei giochi che impegnano il corpo, ma noto che i ragazzi di oggi tornano a casa presto. Non restano a giocare per strada. O non ci restano a lungo. La casa è il centro della loro vita; la strada una dimensione esterna. Non ci sono più i sodalizi, le combriccole dicevamo, le squadre, le bande che un tempo si formavano in base al legame territoriale. La famiglia e il vicolo: un mondo chiuso e un mondo aperto. Mi viene in mente un’immagine libresca, scolastica: il coro delle rappresentazioni teatrali greche. Gli sfortunati ragazzini di oggi hanno per coro la televisione. La quale a volte è saggia, a volte no. Però è sempre e comunque una scatola. Invece, al tempo in cui ero un ragazzino alla vita ci avviava ‘a ruga, come dire il vicolo, e lo faceva sia con la sua saggezza sia con le sue stupidità. E ogni vicino era un corista.
Mia madre era stata ‘chiusa’ in collegio all’età di nove anni e vi era uscita a quattordici, allorché era morto suo padre; mio padre c’era entrato a undici e ne era uscito il giorno stesso che ne compì diciotto, per indossare la divisa di fante. Entrambi aborrivano persino l’idea di
9
convitto. Preferirono aver fede nel magistero del vicolo e mi lasciarono vivere felicemente la mia vita di ragazzino che ha le ginocchia eternamente sbucciate e spesso – molto spesso - mostra uno sparatrap sulla zucca, a coprire i punti del chirurgo. I nostri poveri giochi – ‘a singa, ‘u piroci, ‘attacci, ‘a guerra francese - finivano invariabilmente a sassate. Per fortuna il progresso faceva il suo irreversibile cammino. Gli aerei di Balbo avevano sorvolato l’Atlantico in formazione e i cantieri genovesi stavano varando il transatlantico più bello e più veloce del mondo. Il gioco non progrediva con lo stesso passo, e tuttavia un bel giorno arrivarono, in qualità di surrogato del virile ma costoso pallone di cuoio, le palle di gomma. Non mi riferisco a quei variopinti e mollicci oggetti già in uso presso gli infanti, ma alle turgide e resistenti palle Pirelli. Costavano quattro lire. Le vendeva il merciaio all’angolo di via Amalfi, il Bel Cecè, il quale faceva credito solo a me, in quanto figlio di papà e personcina incline a essere puntuale nei pagamenti.
Sono passati settant’anni da allora. Quando i ragazzini della vecchia ruga ebbero raggiunta l’età lavorativa, io ero in carcere. Ma non v’è dubbio alcuno che essi seguirono il destino generale. La guerra era finita. Francia, Belgio, Germania, USA, Canada, Australia aprivano le porte alla nostra emigrazione. ‘U ‘Ngiulinu, ‘u ‘Ngegnu, ‘u Enzu, ‘a Mara, ‘a Cuncia sono spariti nelle spire dell’esodo. Non li ho mai più rivisti. O per essere precisi, non ho mai conosciuto il loro aspetto da adulti. Solo ‘u Filippu vive qui, anzi è ancora vivo. Degli altri leggo i manifesti mortuari appesi agli angoli delle vie. Figli e nipoti sconosciuti ne annunciano la dipartita in luoghi lontani e spesso ignoti. Immancabilmente lo stesso manifesto informa che al trigesimo ci sarà una messa in suffragio. E’ raro che a tali celebrazioni siano presenti i componenti della famiglia ristretta, i quali hanno messo radici altro
10
ve. E’ invece la parentela più larga - i pochi rimasti qui - a onorare il defunto. Le volte che vado al rito, per le condoglianze, mi ritrovo sconosciuto fra sconosciuti, salvo poi, una volta declinato il cognome, a ricevere i ringraziamenti e la riconoscenza che gratificano le persone note per la loro ricchezza.
Al tempo della fanciullezza - siamo nel 1931-32 - avevo anche altri cori. Uno era il negozio paterno. Mio padre e i suoi giovani erano troppo occupati per darmi retta. Solo a sera, all’Avemmaria - quando i clienti si erano fatti ormai sporadici e si restava là soltanto affinché egli avesse il tempo di sbrigare la contabilità, per poi aprire solennemente l’avita cassaforte viennese e deporvi l’incasso - un commesso indulgente mi permetteva di edificare castelli con i barattoli di salsa o i pezzi di sapone di Marsiglia, i quali erano sufficientemente induriti per far da mattoni. Mi davano invece sempre retta gli operai della ciurma, perfino quando lavoravano.
Nel basso popolo si andava avanti a nomignoli. Ho trascorso ore e anni con loro, ma adesso che li rivedo con la memoria mi rendo conto che dei loro veri cognomi ho conosciuto qualcuno soltanto. Ho invece ritrovato qualche loro fotografia scattata al tempo della guerra. Quando sarò morto, nessuno saprà dire chi ritragga, tranne la miseria, la vera signora del gruppo.
Volendo fare un esatto uso del vocabolario, la parola ciurma non è appropriata a definire la squadra di facchini che lavorava in negozio. Il termine ciurma era il retaggio del lavoro che quelle stesse persone avevano fatto da giovani. Erano infatti quasi tutti già anziani e non più buoni per la nuova marineria, organizzata da armatori di livello nazionale con sede a Genova. Cosicché erano tornati in paese, a fare i pescatori. Ma il nostro mare non è generoso. La pesca non dava a
11
sufficienza da vivere. Di conseguenza facevano i pescatori dalle tre di notte alle sette del mattino e i facchini dalle sette del mattino alle cinque e mezza di sera.
Non erano dipendenti stabili della ditta. Venivano ingaggiati in gruppo per lavori determinati e pagati a risultato, oppure assunti singolarmente e pagati a orario. Inutile aggiungere che erano più poveri di Lazzaro. Al pomeriggio, prima che il negozio riaprisse, si sedevano ad aspettare su una panchina: all’ombra del palazzo, se era d’estate; sul lato opposto della piazza, dove batteva il sole, se era d’inverno. Chiacchieravano pacatamente dei loro trascorsi per mare.
Ascoltarli, a me piaceva più che giocare con i miei coetanei. Mi sedevo sul bordo rialzato di un aiuola e navigavo con loro per i mari del mondo. Furono il mio Van Loon, il mio Conrand. L’Elvira aveva fatto naufragio nel Golfo del Leone e ‘u Peppi ‘u Piccirillu, aggrappato a un rottame, aveva nuotato due giorni e una notte. A Porto Said, Michiele Michielà era rimasto fermo tre mesi, che aveva trascorso a sbucciare patate. ‘U Chirichella era fuochista. Alimentava la caldaia con metodiche palate di carbone. Ripeteva il gesto decine di migliaia di volte al giorno e stava completamente nudo, solo un perizoma, come quello di Cristo sulla croce. Tanto era il sudore che doveva bere cinquanta litri d’acqua al giorno. A ‘u Testazza piacevano le calleja di Buenos Aires, e ancor di più le donnine che le popolavano. Lì, sono tanto calde che ti bruciano la vita. Non come nell’Africa, che con i bianchi restano come un pezzo di legno. Godono solo con i loro uomini, che hanno sciabole quattro volte le nostre. Ma il viaggio imperiale lo facevo cu Peppi, a Liverpool, regina del mondo. A Liverpool s’incontravano le navi più grandi. Dovevamo aspettare tre giorni in rada per avere il posto al dock, e se dicevamo una sola parola di più, il pilota
12
ci faceva arrestare.
*
Con il nome di caricatoio si designava non soltanto il vecchio molo e la retrostante piazza, ma anche la ruga a cui appartenevo. ‘A ruga du Caricatoio si stendeva dietro il Fondaco Alfano. Era un quartiere dalla forma non inconsueta nei centri di nuova urbanizzazione. Nuove costruzioni borghesi convivevano con le preesistenti casupole proletarie, sulla base di una logica classista. Quelle dei ricchi terrieri erano disposte lungo il Corso, quelle dei professionisti e dei mercanti lungo la via Marina, parallela al primo. Dietro (o dentro) c’erano le case dei poveri. Ne era venuta fuori una specie di scatola, che luccicava di benessere all’esterno, mentre all’interno l’unica cosa che luccicava erano i lumini accesi alla Madonna, affinché desse un soccorso alla fame e alla disoccupazione.
Il negozio paterno si affacciava con sei porte sulla piazza Caricatoio, e con altrettante sia sulla via Marina sia sul vico Speranza, da cui si accedeva al ventre della ruga. Su via Amalfi, la traversa che passava dietro il fondaco collegando il corso con la via Marina, c’era il grande portone carraio, ornato con due alte colonne di pietra. Il cortile, grande come una pubblica piazza, era ombreggiato da due enormi ippocastani. La nostra casa si ergeva, come una specie di torrione, su quattro dei sei magazzini sottostanti. Al piano terra, la casa e i magazzini facevano un blocco. Infatti, nonostante le innumerevoli porte, il magazzino era uno solo. Era il risultato di tre navate affiancate, due delle quali erano sorrette dai muri perimetrali, mentre quella centrale appoggiava su una doppia serie di cinque colonne (o muraglioni), disposte simmetricamente. L’impressione dell’insieme sarebbe stata quella di una chiesa a tre navate, se la prima navata, quella che si apriva sulla piazza, non
13
fosse stata separata da quelle retrostanti da altissime scaffalature di legno.
C’erano anche due navate minori, perpendicolari ai due vani estremi. Insomma il magazzino, complessivamente considerato, era un rettangolo con due corna. La parte più interna (e più fresca) nascondeva trentadue cisterne, ciascuna delle quali aveva una capienza di sei botti d’olio della misura detta napoletana, cioè di circa 3.500 litri ciascuna. Le cisterne erano intonacate con resina di vetro. Quello speciale intonaco, realizzato sul posto da operai venuti da Napoli, era stata una gloria della vecchia ditta. La funzione commerciale assegnata alle cisterne stava nel conservare nel modo migliore l’olio fino che, a metà marzo d’ogni anno, le quattro golette della Ditta in convoglio, ciascuna con un carico di 40 botti - in tutto 100 tonnellate circa - lo avrebbero trasportato a Venezia e a Trieste.
Al momento del racconto le cisterne non erano più usate. Ciascuna botola di accesso era stata coperta da una lamiera di ferro alquanto spessa, molto più larga della botola e fissata con viti al pavimento. Ogni tre o quattro anni, Peppi ‘u Piccirillu, con l’aiuto di qualcuno della ciurma, provvedeva a calarvisi e a ripulirle dalla polvere e dalle fuliggini.
* Sebbene il caricatoio fosse ormai in parte distrutto dai marosi e in parte interrato - in effetti utilizzato soltanto per lo sbarco di tavolame da costruzione proveniente dalla Juogoslavia e dalla Norvegia - la zona era ancora piena di vita e di lavoro. La piazza, che ne era la prosecuzione – appunto Piazza Caricatoio - benché non fosse più il centro cittadino, era ancora la più bella e grande del paese. Aveva il lato a mezzogiorno interamente aperto sul mare. Sul lato opposto, proprio di
14
fronte al mare, c’era la vecchia Chiesa, costruita al tempo di Francesco I con il suffragio dei pescatori e dei mercanti. Al centro della piazza s’innalzava il palco per i concerti bandistici, che nei giorni di festa richiamavano migliaia di persone; un manufatto con volute ad arco e con ringhiera in ferro battuto. Ordinati a raggiera rispetto al palco si dispiegavano, in quattro raggi maggiori e in otto minori, i lampioni: i primi alti, gli altri meno alti – degli splendidi lavori in ferro.
Sul bordo della piazza si erigevano due alti chioschi, anch’essi in ferro battuto e vetri colorati: il primo era destinato alla vendita dei giornali e il secondo di limonate, orzate e altre bibite fresche.
Sul lato sud c’erano il Fondaco Alfano e altri negozi e sul lato nord c’erano il Caffè Posillipo, il Circolo di Società e negozi di vario genere. Al tempo della mia prima giovinezza essi erano la causa principale dell’animazione della piazza – la mattina i negozi, la sera il caffè e il circolo.
Per essere esatti, il Fondaco Alfano non era più un fondaco, ma soltanto l’unica sede della Ditta Alfano, la cui Sede principale, a Napoli, e le tre succursali calabresi erano state chiuse da tempo. Anche la parola fondaco stava sparendo nell’uso locale, per lasciare il posto all’espressione ‘u negoziu d’Arfanu o ‘u palazzu d’Arfanu, a seconda del diverso angolo visuale di chi vi si riferiva. La ditta Alfano era sopravvissuta al caricatoio, ma aveva perduto il vento. Bordeggiava. E tuttavia navigava ancora. Di conseguenza l’antico fondaco presentava una fisionomia ambigua e composita: quella nuova, di ricca residenza padronale, e quella originaria di negozio con annesso “convento”.
Quanto al convento, si trattava di una metafora riguardante la parte riservata ai commessi amalfitani che lavoravano in negozio. Era consuetudine fra gli amalfitani che aprivano un fondaco di portarsi dietro
15
anche i dipendenti. Per più di mille anni la cosa aveva trovato una giustificazione nel fatto che andavano a insediarsi in luoghi ostili e arretrati, comunque mancanti di tradizioni mercantili. Detta esigenza non valeva più ai tempi miei. E tuttavia l’antica usanza continuava ad avere un senso, perché i contadini, che costituivano la massa degli avventori per i negozi di alimentari, erano clienti difficili: sempre perplessi se spendere o no, sempre paurosi d’essere fatti fessi dal negoziante. Ora, sul punto che oggi chiameremmo del marketing, Amalfi era una vera università e gli amalfitani dei veri dottori. Per cui mio padre, come ogni mercante amalfitano, era praticamente costretto ad affrontare il maggior costo di commessi scelti fra i suoi compatrioti.
Al tempo in cui inizia il racconto, i giovani erano tre: Andrea, don Aniello e Costantino. Amalfitano era anche il ragioniere, don Pantaleone Mezzacapo, dalla gente del paese più brevemente appellato don Leone; un accoppiamento che allora mi divertiva enormemente, suonandomi stridente che un uomo portasse il nome d’un animale, fosse pure il re della foresta, e che, per giunta, gli si facessero le querimonie.
Siccome il piano del palazzo ancora riservato ai giovani era stato concepito per una ventina di persone, le quattro che allora l’occupavano potevano stare alquanto comode. Infatti, soltanto Andrea e Costantino dormivano nello stesso stanzone, mentre Aniello, che era un po’ più anziano e parecchio sofistico, godeva di una camera solamente per lui. A don Pantaleone, poi, era riservato un piccolo appartamento.
Alla vita del convento sovrintendeva ‘a Maruzza, una secca vergine in capillis di cinquantacinque o sessant’anni, la quale provvedeva alle pulizie e a preparare i pasti per i frati conversi, come tradizionalmente si autodefinivano. 16
*
Quando ‘a Maruzza aveva finito le sue faccende, il convento diventava un luogo mesto e silenzioso. Ricordo vagamente che qualche volta, alla sera, Andrea, che era un giovane tirocinante, prendeva il mandolino e si metteva a cantare. Allora la mamma lo chiamava su e gli addolciva la solitudine con qualche leccornia e un bicchierino, o una bibita fresca se era d’estate. Gli altri giovani, avendo fatto le loro amicizie in paese - immancabilmente supervisionate dal padrone - dopo cena se ne andavano al cinema o a passeggiare sul Corso.
Restava, al contrario, sempre in casa don Pantaleone. Tecnicamente è anche facile dire il perché. Non lo è invece umanamente. Difatti don Pantaleone aveva perduto la gamba destra in guerra e perciò camminava faticosamente con l’aiuto delle stampelle. La menomazione - il vedere don Pantaleone fermo e vigoroso, ma impedito ad agire corrispondentemente - mi spaventava, e a volte mi faceva piangere così accoratamente che la mamma si amareggiava e si metteva a piangere anche lei. Era allora don Pantaleone a salire faticosamente le scale e a consolarci, dicendo pianamente che la difesa della patria, anche a costo della vita, era il dovere d’ogni italiano. Ancora di più: anche a costo di andare contro la nostra Santa Fede, uccidendo uomini in tutto e per tutto simili a noi.
Finché il regime fascista non assunse un atteggiamento spocchioso, gli anniversari patriottici erano solennizzati con misura e decoro. Tuttavia, anche se contenuta, la retorica disturbava i superstiti e i parenti dei caduti. Lo ricordo bene: dopo la morte di Patreppaolo, mio nonno, allorché la vecchia nonna, rimasta sola, venne a vivere con noi in Calabria, il 4 Novembre di ogni anno, mentre fuori noi balilla sfilavamo dietro la banda che intonava la Canzone del Piave, lei faceva
17
chiudere i portali dei vecchi balconi e si fasciava il capo e le orecchie per non udirne le note. E più che gli altri giorni, in quella ricorrenza gli occhi di zio Gioacchino parevano guardarci con muto rimprovero dalla fotografia appesa dietro lo scrittoio di papà. Il quale, turbato, piantava in asso il lavoro e se n’andava in campagna.
L’anniversario toccava anche mamma, che nel luglio del 1915 aveva perduto il fratello maggiore. Ma la sua velata mestizia era cosa ben diversa dal cupo dolore della nonna. Tra mia madre e zio Tommaso c’erano dieci anni di differenza. Quando lei era ancora una ragazzina il fratello era già all’università. Lontani per dieci mesi all’anno, si può dire che non avessero realizzato una piena comunanza familiare. E, poi, della sua famiglia d’origine non c’era più nessuno in paese. Entrambi i genitori erano morti, il fratello vivente se n’era tornato in Sicilia, da dove la famiglia era venuta al seguito del padre, chirurgo. L’unica sorella, sposata a un magistrato, viveva in Piemonte. Così, nella ricorrenza luttuosa, lei riusciva a mantenere la calma e ad essere pratica. Conoscendo per esperienza i risvolti umani della funebre solennità, evitava di ricevere gente e ordinava alla cameriera di parlare sottovoce e di vigilare dietro l’uscio della nonna, se per caso avesse bisogno di qualcosa.
Papà non parlava mai del fratello. La nonna nominava il figlio solo sottovoce e solo quando pregava. Di zio Tommaso sapevo tutto quel che sapeva la mamma, di zio Gioacchino, poco o niente. La massima informazione mi veniva da zia Anita, l’unica sorella di papà, che viveva a Capursi. In casa, invece solo qualche flash e una decina di fotografie. Un ragazzino in uniforme da collegiale nel cortile della Badia di Cava, dove aveva studiato; i suoi quaderni di calligrafia, armoniosa come un arabesco; quelli con le esercitazioni sulla partita doppia; un
18
favoloso volume di racconti per ragazzi, i più belli che abbia letti nella mia infanzia; un solido Manuale dello Chaffeur, una delle poche cose rispedite in famiglia dal Generale Comandante la Brigata Novara, che la nonna teneva sul suo comodino assieme al libro delle orazioni. Sul ripiano della grande specchiera, nel salotto, c’erano delle altre foto. Un giovanotto che sfoglia un giornale seduto a un tavolo del Gambrinus. Una fototessera incollata su un elegante cartoncino, con il logo dello studio fotografico. Un bagnante dal pudico costume, in piedi su uno scoglio. Un fante ripreso accanto al suo camion, con la mano destra allungata sul volante. Tutto qui, o quasi. Un volto che conosci solo in quanto emozione; il rimpianto per un legame che avrebbe potuto esserci; un vuoto d’amore.
I mesti occhi di zio Gioacchino furono una presenza costante nella mia vita di fanciullo. La sera andavo a letto indossando come camicia da notte una delle sue camicie di lino, e non c’era bisogno di suggerimenti e raccomandazioni perché lo includessi nelle mie preghiere. Debbo anzi dire che, finché indossai una di quelle camicie, ogni sera ebbi paura di morire anch’io in guerra. Sicuramente paura, e compianto per mio padre, per la mamma, per la nonna e Celeste, che avrebbero sofferto della mia anticipata morte. Ma, debbo confessare, una non completa indifferenza verso l’onore che poteva venirmi da una medaglia d’oro alla memoria.
*
La Marina di San Policarpio era sorta un secolo prima che io nascessi, intorno alle attività suscitate dall’esportazione di olio. Come in qualunque altro posto del mondo, anche qui la gente immagina che l’ambiente circostante sia, in tutto e per tutto, un dono di Dio; più particolarmente che i lunghi filari di ulivi, che umanizzano con geo
19
metrie a volte regolari, più spesso irregolari le nostre colline, siano un elemento primigenio della nostra terra, e che l’olio che vi si produce sia un grazioso dono della natura amica.
Ovviamente non è così. Dopo i fasti di un passato lontano duemila e cinquecento anni, l’esportazione d’olio era tornata preminente soltanto verso gli ultimi decenni del secolo XVIII, diciamo al tempo in cui la famosa Maria Antonietta andava sposa a Luigi XVI, re di Francia, e sua sorella Maria Carolina al Re di Napoli, Ferdinando IV di Borbone. A partire da quegli anni il mondo occidentale aveva preso a chiedere sempre maggiori quantità di olio.
Gli Alfano non furono i primi a trarne profitto. Quando la goletta di Padron Gioacchino apparve nella rada di San Policarpio, Maria Antonietta era stata decapitata da quarant’anni, mentre da poco era salito sul trono di Napoli il nipote delle già nominate regine, marito d’una pia fanciulla venuta nella ridente Napoli dall’accidioso Piemonte, a partorire l’indeciso re della nostra ultima indipendenza nazionale. Come dicevo, non furono i primi ad approdarvi, ma quando vi giunsero s’impadronirono della piazza, di modo che la Marina si sviluppò intorno al loro fondaco.
Sbarcando sulla spiaggia di San Policarpio, gli amalfitani si trovarono in un luogo quasi disabitato. Non più di cento famiglie e tre armigeri posti a guardia della torre. Nei millenni precedenti, i saccheggi romani, le razzie saracene, l’esosità e brutalità dei baroni stranieri, l’impaludamento malarico avevano spinto gli abitanti della costa a insediarsi in collina, in città fortificate. Le antiche città greche erano completamente scomparse, sulla costa abitavano soltanto dei pescatori-contadini, probabilmente indifferenti alla suggestione del paesaggio, dominato da uno sperone rupestre con sopra un castello in rovina.
20
Sulla spiaggia, nel punto più incassato della rada, la torre costiera, che non aveva più alcuna funzione militare, ma serviva soltanto per accendervi un fuoco nelle notti di burrasca, con cui indicare ai bastimenti in difficoltà da che parte era la rada.
A San Policarpio, i nuovi venuti s’insediarono alla meno peggio accanto alla torre, che fungeva anche da sede per la dogana marittima, a cui andavano esibiti i permessi per l’esportazione. Qui costruirono i loro depositi e in appresso moderne cisterne per lo stoccaggio dell’olio. Intorno a quei depositi nacque l’attuale Marina.
*
A distanza di oltre mezzo secolo non ho dubbi nel definire mio padre e mia madre delle persone dal tratto signorile, eppure sia l’uno che l’altra si ritenevano soltanto dei lavoratori fortunati. Fortunati, secondo lui, in virtù del caso, e secondo lei per volontà divina. Comunque è certo che a casa mia mancava il culto nobiliare della genealogia. Perciò le notizie che da ragazzino ricevevo sulla famiglia sfocavano nella nebbia. Il punto della prima chiarezza era Patreggiacchino, padre di mio nonno Paolo, nonno di mio padre e mio bisnonno.
Nei ricordi familiari, l’avo si presentava all’origine delle fortune commerciali della Ditta. Del suo primo incontro con la Calabria non è rimasta una data. L’atto notarile, con cui egli acquistò dal barone Rinaldo Englen il terreno su cui, in appresso, costruì “il convento” e il palazzo di fronte, è datato 9 ottobre 1835. Sul capitello di una colonna, all’ingresso del cortile, è scolpita la scritta “G. Ciano 1847”, mentre sui bordi di tutte le cisterne è impresso uno stesso stampiglio:
“Real Vetreria Vincenzo Miraglia”
“Cava dei Tirreni”
21
ma senza data.
Secondo le notizie tramandate oralmente, per alcuni decenni l’attività mercantile degli Alfano si limitò all’esportazione dell’olio. Tale attività veniva finanziata dalle case bancarie napoletane, le quali scontavano le tratte degli importatori francesi, inglesi e triestini. In appresso Patreggiacchino e un suo cognato, Patre Giuseppe Conforti, avviarono un emporio per lo smercio di grano e delle altre merci che la collettività, da loro stessi rifornita di moneta, cominciava a chiedere.
Spendere danaro per l’acquisto di un prodotto locale e vendere contemporaneamente un prodotto forestiero, con il fine, tra l’altro, di farsi rientrare in tasca il danaro messo in circolazione, era un accorgimento degli antichi mercanti, con il quale, oltre ad accedere a un doppio guadagno, si pagavano il viaggio d’andata del bastimento, altrimenti vuoto; un meccanismo che in ogni caso li affrancava dalla necessità di trasportare l’oro e l’argento su percorsi pericolosi e lunghi.
Non so quando Patreggiacchino e suo cognato divennero soci. Sebbene al tempo della mia fanciullezza la società non esistesse più da ben quarant’anni, il binomio Alfano & Conforti era ancora una costante nei ricordi dei paesani avanti negli anni.
Da ragazzino, siccome mi sentivo un amalfitano in servizio attivo e avendo anche una gran passione per le navi di tutti i tempi, ma specialmente per quelle amalfitane, di cui i giovani del negozio mi riempivano la testa con i loro racconti, ero ben convinto (o amavo convincermi) che il mio avo - almeno lui - fosse un marinaio. Così ne andavo chiedendo conferma agli anziani.
In paese più d’uno lo rammentava ancora, ma i ricordi non andavano oltre l’aspetto fisico e la ricchezza di cui disponeva. Più che altro veniva sottolineato che il suo volto era sempre perfettamente rasato,
22
cosa non solita a quell’epoca (l’essere ben rasati fa parte del DNA familiare). Veniva rammentata anche la nera finanziera con cui si abbigliava, ovvero il gibus eternamente piazzato sul capo, se no si prendeva il raffreddore (anche questo fa parte del nostro DNA). L’unico a possedere ricordi meno effimeri era un vecchio commesso. Lasciando la Ditta, don Matteo non era tornato ad Amalfi. Avendo ottenuto le facilitazioni di rito dagli ex padroni, aveva aperto un negozio, che poi in vecchiaia aveva ceduto a suo figlio. Ormai libero da impegni, si era eletto titolare di una sedia dinanzi alla cassa e tutte le mattine veniva in negozio ad ammazzare il tempo, distribuendo consigli e intrattenendosi con i clienti, giovani e vecchi, ma specialmente con le giovani cummarelle, proprio quelle più procaci.
“Quando il padrone parlava, sembrava un professore. Ma parlava poco, gli bastava uno sguardo per comandarci. Non toccava mai i soldi, li faceva contare ai figli e ai nipoti. Però tutto doveva essere registrato fino al tornese. E lui si ricordava di tutto, fino al tornese.
“I proprietari si pisciavano addosso aspettandolo. Arrivava da Napoli il giorno che il prezzo di Marsiglia scendeva. Allora lui faceva scrivere su un cartellone “Acquisto tot botti al prezzo di tot ducati” e il cartellone ce lo faceva appendere alla vetrina dello studio. Il suo sistema era tutto il contrario degli altri, che ancora acquistavano con il sistema antico, con il prezzo di San Nicola, strangolando i proprietari, quelli a cui più gli servivano i soldi. Perciò i proprietari avevano fiducia e correvano qui, e lui si accaparrava tutto.
“Aveva più soldi di Rothschild. Un prezzo diverso secondo la qualità. E lui pagava sull’unghia. Ma quasi tutti s’erano già preso l’anticipo in merci, nel negozio degli alimentari. Ed essendo che allora gli alimentari erano molto remunerativi, lui questi debiti ci ordinava
23
di scontarli al prezzo più alto dell’annata ... Così ci facevamo il buon nome. Cosa credi, che per fare regali?
“Avevamo le cisterne più grosse di tutta la Calabria ... Cisterne qui, e cisterne sotto il palazzo che poi, nella divisione, andò a Patre Giuseppe Conforti, dove lui, suo cognato e i figli abitavano quando stavano a San Policarpio ... Le nostre cisterne venivano da lontano a vederle. Da Gioia, da Reggio, da Amantea. Raccontavano i vecchi che erano costate una montagna di danari.
“Piccoli e grossi erano pari per lui, ma i grandi proprietari, quelli che ti riempivano una/due cisterne d’olio, riscuotevano più fiducia e potevano ottenere grosse anticipazioni. Quando tuo zio Ferdinando si presentò deputato, gli furono prestate ventimila lire, e quando il Cavalier Figliomeni sposò l’unica figlia, la dote uscì da qui. Trenta fogli della Banca, uno sull’altro! Questo te lo devi ricordare: mai una lira d’interesse. Erano altri tempi, e questo era un principio d’onore. Nessun imbroglio, nessun raggiro. Tutto a voce alta. Ed era per questo che tutti approdavano qui, al nostro buon nome. E tutti rispettavano il contratto, portando ’e cafisi d’olio necessari per pagare il conto. E chi non poteva, veniva a dirlo. Trecentomila ducati scritti a libro. Lui contava sempre in ducati, ma erano già soldi di Vittorio. Vuoi sapere quant’era? Più di cinquanta milioni di oggi. Neanche il re! Poteva armare un esercito! Pensa che io pigliavo sessanta lire al mese di paga, il mangiare e l’alloggio.
“Questa scrivania è sempre la stessa, e così pure la cassaforte, ma a quel tempo non era come oggi, che si sta dietro il bancone per mezza lira. Da qui usciva da vivere per venti paesi, signori e pezzenti. Montagne di pezzi d’argento in quella cassaforte. E lui pagava con un semplice telegramma che faceva a Napoli. E i soldi spiccioli li spedi
24
vamo a Napoli nei sacchi, coi bastimenti.
“Li vedi gli ulivi ? ... Un mare!... ‘A ddà sapè che i soldi per piantarli sono usciti tutti da quella cassaforte. Lo vedi quel viottolo? (E indicava un tracciato di terra soda dove l’erba non cresceva più). Su quel viottolo, ogni settimana, passavano mille sacchi di grano (sbarcati da una delle golette). Miniello (il capocommesso), venti giovani e quaranta facchini non ce la facevamo a servire tutti. Patre Giuseppe, i figli e i nipoti, tutti nello studio a scrivere i conti, dalle sei del mattino alle sette di sera. E la domenica ti dovevi alzare alle cinque per sentire la Santa Messa e comunicarti. Questa era la regola: vivere come frati, chiusi nelle stanze di sopra, nel convento, cucinandoci, lavandoci e stirandoci da noi. E pure le pulizie.”
*
A papà non dispiaceva che gli stessi sempre dietro e che dall’esempio imparassi la sua arte. Fra le altre cose, avevo introiettato le proporzioni della ricchezza. Così percepivo chiaramente che una ricchezza locale è una pagliuzza a confronto di una nazionale o mondiale. E tuttavia, nell’ambito locale, l’idea corrente era che quella degli Alfano rappresentasse il massimo. In effetti la Ditta era stata così importante da realizzare un forte legame tra il mio paesino e Napoli, come dire il resto del mondo.
Tutti erano attenti e rispettosi quando si parlava dell’uomo che aveva creato, forse dal nulla, un’azienda oggi diremmo plurimiliardaria. Ma io lo ero doppiamente. E in appresso capii meglio il perché. Nella figura altamente positiva dell’avo Gioacchino trovavo una sorta di compensazione alla non smagliante figura di mio nonno, il quale troppo spesso veniva accusato di non aver saputo cavare ‘no sorece morto ’a dinto ’o pertuso, come dire di non averci saputo fare com
25
mercialmente.
Ma chi era stato, codesto Padron Giacchino? Come era vissuto? Come se la sbrigava con le tempeste? Come impartiva i comandi sulla nave? Era coraggioso? Aveva l’incerata per evitare di bagnarsi quando il mare era in tempesta, come Clark Gable? Qualche volta arrivavo a chiedermi se baciasse i suoi figli. Ma di lui era rimasto molto poco. In famiglia, solo la nonna era padrona di quel monumento familiare. Ma purtroppo, di navi, lei non capiva un bel niente.
“Nonna, com’era il pronnonno ?”, chiedevo.
E la nonna: “Io l’ho conosciuto che era già avanti negli anni. Era sempre a Napoli, ma quando stava a Capursi usciva la mattina all’alba a camminare. E camminava, camminava. Non si stancava mai. Ma poi stava sempre in casa… Leggeva le preghiere, si diceva il rosario. Era vedovo e solo. Solo il padre di Anselmo, il cocchiere… Mia suocera era francese, io non l’ho mai conosciuta. Ricordo soltanto il giorno che ci fu il funerale. Morì che Paolo aveva diciott’anni.”
“Ma aveva fatto il capitano ?”
La nonna - nata proprio nel 1861, l’anno del Re Scomunicato - apparteneva a una diversa classe sociale. Veniva da una famiglia di grandi banchieri napoletani. Gente illustre, ma ormai decaduta. I suoi fratelli non stavano negli affari. Esercitavano una professione.
“Mio suocero venne da Gaeta. Sin da ragazzo navigava per Marsiglia, con l’olio. Fece fortuna presto, e a Marsiglia si sposò con una bella e ricca ragazza, figlia di un mercante. Un po’ di soldi li ebbe in dote, un po’ glieli diede il re, così comprò una goletta e se ne venne a Capursi. Comprava l’olio in Calabria e lo vendeva a Marsiglia, e così fece una grande fortuna.” Con il che – mi resi conto – la rischiosa attività di capitano era finita. Infatti, a Capursi, né Patreggiacchino,
26
né suo cognato Conforti, né i loro rispettivi figli, venivano ricordati come capitani, ma solo come armatori e mercanti. La nonna, che pur raccontava delle paure che i bastimenti potessero far naufragio, parlava chiaramente di paure economiche e non fisiche. Cosa che significa che Patreppaolo, suo marito, era sulla riva ad attendere. Quando lei ricordava l’avversione di questi per il mare - “pe’ mare non ci stanno taverne” - una fosca ombra calava sul mio cuore intrepido. Avrei sicuramente preferito un nonno in lotta con i marosi e con il sartiame, come Il Corsaro Nero.
Avevo amato intensamente mio nonno e amavo ancora il suo fresco ricordo. Fra me e lui c’era una comunicazione, una complicità arcana e indecifrabile, quasi fossimo entrambi bambini o entrambi vecchi. Durante i tre mesi estivi che da bambino trascorrevo a Capursi, con la nonna e con lui, mio padre diveniva una riserva, quasi un intruso.
L’idea che il nonno fosse un inetto mi disturbava parecchio. Lui morto, cercai sempre d’evitare qualsiasi discorso che gli si riferisse. Mi avrebbe fatto troppo male continuare a sentire che era un debole. Era questo anche l’atteggiamento di papà. Entrambi, quasi per una tacita intesa, scartavamo ogni riflessione riguardante il nostro rispettivo padre e nonno. In verità sul vecchio Patreppaolo e su un suo fratello e socio - che si chiamava Generoso - gravava l’infamia di aver dissipato, per bonomia il primo e con le donne il secondo, gran parte del patrimonio familiare.
*
Al tempo delle mie infantili villeggiature a Capursi, il nonno e i suoi cugini Conforti si guardavano in cagnesco. Nonostante i portoni dei rispettivi palazzi fossero a pochi passi l’uno dall’altro, nonostante anche i giardini retrostanti fossero contigui, fingevano una fredda e
27
distaccata conoscenza. L’inimicizia si smorzava un po’ presso la generazione successiva, quella di mio padre, assumendo il carattere di un legame parentale ipocrita. Ricordo tutti e quattro i fratelli Conforti. Due vivevano a San Policarpio e gli altri due a Capursi. Al tempo della guerra d’Africa erano tutti vicini agli ottant’anni. Il maggiore li aveva anche superati.
Era, questi, un tipo fuori del comune. E per moltissime cose, ciascuna delle quali era sufficiente a stralunare le mie categorie infantili. Soprattutto la sua trista fama. Si sapeva, infatti, che il Capitano aveva portato, deliberatamente, una fregata a sbattere contro la banchina del porto di Ancona e l’aveva mezz’affondata.
A casa del Capitano, che abitava però da tutt’altra parte del paese, ci arrivai attraverso la porta di servizio. Conoscevo l’arcaico ed esotico parente soltanto di vista, poiché lo vedevo la sera a passeggio sul corso, con la mesta moglie appesa al braccio. E quando li incontravo, mi irrigidivo per il disagio, così come si irrigidiva il nonno. Mio padre e mia madre invece li salutavano sempre, ma da lontano; tranne la prima volta, al loro arrivo a Capursi. Sarebbe stato, infatti, troppo sgarbato non avvicinarsi. Ma se le inimicizie antiche dividevano le famiglie, le cameriere le univano. Infatti Maddalena, la cameriera della nonna, era sorella di Margherita, la cameriera del Capitano. Le due sorelle, pur non avvertendo alcuno dei sentimenti avversativi dei rispettivi padroni, erano tuttavia costrette a vedersi di soppiatto, o se non proprio di soppiatto, quantomeno senza compromettere l’inimicizia dominicale. Per tal motivo, quando il nonno e la nonna facevano il loro pisolino postprandiale, Maddalena si recava alla villa del Capitano, a chiacchierare con la sorella.
Ma Maddalena aveva anche il dovere di sorvegliarmi, dato che le
28
idee pedagogiche dei nonni erano molto diverse da quelle correnti a San Policarpio. Così, per conciliare l’utile con il dilettevole, mi portava con sé. In verità non ci dirigevamo al casino dello zio, ma verso la parte retrostante, corrispondente a un ampio giardino di limoni, al quale accedevamo attraverso una porticina sgangherata, sicuramente centenaria. Sul bordo della piantagione c’era uno stanzone che fungeva da lavatoio. Maddalena e Margherita si sedevano all’ombra dell’edificio, e per chiacchierare liberamente mi lasciavano ampia libertà di scalare gli alberi; libertà non contrastata da Luigi, il contadino dello zio. In cambio di tale compiacenza, Maddalena mi aveva fatto promettere che non l’avrei tradita riferendo alla nonna dove si andava al pomeriggio. Se qualcuno mi avesse chiesto, avrei dovuto mentire spudoratamente affermando che eravamo andati a pigliare il fresco nel giardino sotto casa.
Tutto andò liscio per qualche tempo. A quell’ora, sopraffatti dal pranzo e dalla calura, il Capitano e sua moglie ronfavano. Ma un destino beffardo volle che le suole delle mie scarpe graffiassero la corteccia dei limoni che andavo scalando. Il guasto non sfuggì al Capitano, che ovviamente lo addebitò a Luigi. Il quale Luigi, per discolparsi, chiarì che i graffi erano stati prodotti “dalle scarpe di vostro nipote”.“Quale nipote?”, tuonò il Capitano.
“Paolino”.
“Ma quale Paolino ti sogni? Paolino è in Germania. Che cacchio racconti?”
“Non Paolino, il figlio dell’ingegnere... Paolino, il figlio di don Genso”.
Fu così che io venni al mondo anche nella mente del Capitano, in verità molto maltrattata dagli anni e dai trambusti della vita. 29
Non ero ancora consapevole di tale nuova mia incarnazione, quando un giorno, all’improvviso, me lo vidi a soli due passi, a fissarmi severissimamente da sotto il limone sul quale ero appollaiato.
“Brutta bertuccia!… I miei limoni... Ti faccio arrestare... Tu sei di Calabria, è vero?... Sei di quella razza di mezzecartucce degli Alfano?... Allora, se sei un vero Alfano, lascia stare i limoni… Vai a fare il bagno in una cisterna d’olio... Ah... ah... lo stocco... Dimenticavo lo stocco!... Dimmi un po’, hai già imparato a far compravendite di stoccafisso?”
Il lettore si aspetterebbe una forte difesa dei miei penati, ma non seppi farla. Semmai avevo previsto un attacco, lo attendevo sul punto: scalata dei limoni; mai e poi mai sul versante dello stoccafisso, ché, se a lui sembrava disprezzabile, tale non doveva essere in effetti - almeno pecuniariamente - se mio padre era sempre a badare che il deposito avesse sufficiente ventilazione, e sempre temeva l’arrivo dello scirocco, parecchio minaccioso per una sua buona conservazione. Con il che, i lettori si sono perfettamente resi conto che già mi intendevo di stoccafisso, proprio come il Capitano affermava. E non poteva essere altrimenti.
Quanto al secondo addebito, mi sembrò cosa di poca importanza che mio padre e il nonno fossero ben lontani dal possedere l’alta statura del Capitano. Il quale per la verità doveva essersi preparata quella sparata, perché, subito dopo averla recitata, si ammansì. Anzi, notando che avevo un certo timore a lasciare il ramo su cui stavo, prese ad allettarmi e promise che mi avrebbe fatto vedere la sua nave. Siccome Maddalena mi fece un cenno affermativo con gli occhi, non mi restò che ubbidire.
“Ti chiami Paolino come me... Sì, lo so, come tuo nonno. Ma Gioacchino avrebbero dovuto battezzarti... Gioacchino, come il pro
30
nonno... Quello sì che era un uomo, non come tuo nonno, un vero cazzone. Nella tua famiglia non ci sarà mai più un altro Gioacchino Alfano... Un uomo... Fu lui a volere che andassi in Inghilterra a studiare ingegneria navale... Aveva capito che tuo nonno era un asino, e perciò scelse me...il primo nipote. Sognava navi ... porti per tutto il napoletano... Era un tempo che pareva che Napoli si sarebbe mangiato il mondo... Un uomo... Mi accompagnò a Londra... 1867... Diciott’anni... Un nipote di don Carlo Rothschild ad aspettarci al treno di Dover... Hai capito? I Rothschild... I veri signori del mondo... Tanto rispetto neanche un re...
“Come hai detto che ti chiami?... Ah, sì, Paolino.”
La casa dello zio appariva stranissima ai miei occhi di provinciale. Era posta su un poggetto, anziché sul comodo piano. In secondo luogo non aveva persiane, per cui lì dentro solo le tende ti difendevano dalla luce estiva. In terzo luogo, i mobili sembravano costruiti da un falegname pazzo. Logicamente in seguito capii che la casa era stata progettata e arredata con gusto tedesco, ma allora ero molto lontano dall’immaginare che un comò tedesco potesse essere diverso da un comò napoletano.
Zia Wìlma, lacrimando senza motivo alcuno, mi accarezzò con dolcezza e cercò di avviare una conversazione. Mi chiese di non dare troppo peso alla parole cattive dello zio. Perché parole restavano, e mai si sarebbero tradotte in fatti. “Sai come dice la canzone: Pizzeche e vase non fanno pertusi”. Volendo ottenere che mi sciogliessi un po’, mi regalò cinque lire perché acquistassi a volontà suricilli e sottencoppa.
“Ecco la mia nave”.
Al centro della parete una cornice dorata inquadrava il bel dipinto di una nave da guerra che solcava il mare. Mussolini ci aveva resi esperti
31
in materia di corazzate e incrociatori, così potei subito capire che la nave del dipinto raffigurava una corazzata di altri tempi.
“La Caio Duilio... Sai chi era Caio Duilio?”
Lo sapevo.
“L’ho progettata e varata io, il più giovane ingegnere d’Italia. A Castellammare quel giorno c’erano il re, la regina, il prinzkaiser e la moglie, tutti i ministri e quasi tutto il parlamento.”
Che nave poteva mai essere quella, se era stata varata a Castellammare! A Castellammare c’ero stato con il nonno e non avevo visto neppure un pennacchio di fumo. Sicuro che doveva arrabbiarsi!... Castellammare di Stabia?... Ridacchiavo dentro di me, ma mi dispiaceva anche. Lo zio era completamente svampito... Un cantiere navale a Castellammare di Stabia...? Ah, ah... Già la parola “stabia” aveva un suono come di pollaio... Tutto quel che si diceva circa la tramontata sanità mentale dello zio era vero, purtroppo. D’altra parte, zia Wìlma non mi aveva detto di non credergli?
“Non ci credi?” - disse rivolto alla moglie, come se non si conoscessero da cinquant’anni e come se lei non sapesse. “Ecco i progetti”, e cominciò a tirar fuori da uno stranissimo mobile rotoli e rotoli di disegni. E poi montagne di enormi quaderni pieni di stranissime operazioni numeriche. E li mostrava alla moglie.
La mia espressione confusa e impaurita lo fece tornare in sé. Mi accarezzò vagamente e credo si rendesse conto che non potevo capire alcunché dei suoi disegni, e meno che mai dei suoi calcoli. Si avvicinò a una delle credenze che contenevano modellini navali e ne prese uno. Giudicai che fosse il più importante, perché era il più in vista.
“Cos’è questa?”, mi chiese.
“La Caio Duilio”.32
“La Regia Nave da Battaglia Caio Duilio, ammiraglia della flotta italiana. Era la corazzata più moderna e potente del mondo. La più celebre. Le grandi potenze ce la invidiavano. L’Imperatore d’Austria aveva l’amaro in bocca.
“Adesso confronta mentalmente la sagoma di questa nave con la sagoma di una corazzata attuale e dimmi che differenza noti?”
Era una domanda di estrema facilità. Infatti le due torri erano sistemate al centro, dietro le ciminiere, di modo che la nave poteva sparare solo mettendosi in linea.
“No, non è questo il problema. Almeno non è il problema principale. Il problema è quest’altro.” E mostrava il foglietto di compensato che avvolgeva i fianchi della nave.
“Mi sai dire perché una nave galleggia?”
“Perché è più leggera dell’acqua”.
“Di qual acqua?”
“Dell’acqua di mare.”
“No, scimunito! Anzi sì. Bisogna stare attenti. Uno scafo immerso sposta una determinata quantità d’acqua. Un ingegnere deve sapere quanto pesa l’acqua che sarà spostata dallo scafo che sta progettando, ma non può pesare né l’acqua né lo scafo. Invece calcola il peso a tavolino, con queste operazioni (e indicava con il dito i quaderni) che sono più precise delle bilance.“La quantità d’acqua spostata dipende contemporaneamente da due cose: il peso dello scafo e il suo volume. Molto peso, ma poca acqua spostata, la nave affonda. Allora, se io metto alla nave questa corazza, la carico di un grande peso, ma sposto poca acqua.”
Forse avevo capito, forse no, comunque lo zio si compiacque. Ma i compiacimenti erano appena finiti che egli s’infiammò di nuovo
33
contro un tal Benedetto, che dai discorsi successivi seppi essere un ammiraglio. La sua arrabbiatura discendeva dal fatto che quell’ammiraglio non l’assecondava.
“A Castellammare...”
Era proprio fissato. Che mai ci faceva a Castellammare un ingegnere che aveva fatto il suo tirocinio in Inghilterra? Ma forse non capivo bene, la Castellammare in questione non era quella che io conoscevo...
“Quale Castellammare, zio?”
“Come quale Castellammare? Castellammare è... era il più grande cantiere della Marina Regia. I migliori carpentieri del mondo. E io l’ho girato il mondo... Dalla Russia al Giappone... In Cina... Cinque volte a New York, tre volte attraverso il Canale di Panama... Sul mare ho visto tutto quel che c’è da vedere.
“A Castellammare provammo su uno scafo di quindici metri. Lo provai. Lo costruimmo in tutta segretezza con i migliori mastri, fuori del cantiere. E lui venne a vedere, ma non capì. Anzi capì, ma fece finta di non capire. Voleva far arricchire i ladri...”
Sebbene in stile divulgativo, le lezioni di ingegneria navale che zio Paolino mi impartiva erano ben difficili. Ero comunque caduto nelle sue maglie. Logicamente in famiglia se ne accorsero. Fu per i soldi che zia Wìlma mi regalava e per l’incredibile quantità di suricilli che portavo a casa e ridistribuivo fra i cuginetti, la sera, quando venivano a salutare la nonna. Notata la cosa, zia Anita mi chiese da dove venissero i fondi per tutte quelle spese folli. Io mentii, affermando che la mamma mi aveva regalato cinquanta lire. La zia capì che era una fanfaluca, ma fece finta di non dare rilievo alla cosa, in attesa di altri segnali. Il mistero fu svelato quando una cuginetta, scoperta con cinque lire in
34
mano, mi additò come suo benefattore.
A quel punto confessai. Zia Anita mi rimproverò, ma non aspramente, anzi mi disse di continuare a far visita allo zio. Solo non dovevo dirlo al nonno e alla nonna. Anche la nonna si accorse che i miei conti alimentari non quadravano, in quanto, per l’alto consumo di suricilli, mi presentavo a tavola senza appetito. E anche lei mi rimproverò, ma poi suggerì di continuare ad andare dallo zio Paolino, ma senza dirlo al nonno e senza spendere in suricilli i soldi che zia Wilma mi regalava.
“E mo’ guagliò, mi spieghi perché la tua camicetta è sporca di cioccolata?”
Dovetti confessare anche al nonno. E neanche lui mi vietò le visite a zio Paolino. “E’ un cane pazzo, ma non morde. Non dirlo, però, alla nonna e a papà”.
Poi, dopo qualche tempo, arrivò a casa, in Calabria, un telegramma con la notizia che zio Paolino era morto. Mio padre partì in tutta fretta, ma non mi portò con sé. Quando tornò, ebbi finalmente il coraggio di chiedere per quale motivo zio Paolino fosse arrabbiato con il nonno.
“Adesso lo chiamano senso di colpa”, fu la risposta.
“Che vuol dire”?
“Vuol dire che zio Paolino era destinato a fare il capo della seconda generazione. Quattordici tra fratelli, sorelle e cugini. La famiglia aveva sopportato notevoli spese per farlo studiare all’estero e per fargli girare il mondo. I vecchi l’avevano prescelto, e anche i giovani si aspettavano parecchio da lui. Ma zio Paolino si fece coinvolgere dal fasto dell’alta società, che poi non era la sua; alla modesta e dura vita degli affari preferì i salotti di Napoli; si innamorò della divisa da ufficiale. L’idea di tornare indietro lo spaventò. D’altra parte, se lui saliva, la ditta scendeva. Come dargli torto. Forse l’avrebbe salvata dal declino, forse no.
35
Nessuno può dirlo.
“I fratelli e i cugini non glielo perdonarono. Gli rinfacciarono le spese sostenute. L’inimicizia nacque da questo. Ma adesso che è morto...”
L’estate successiva, senza più Maddalena come vigilante - ormai ero grande! - il pomeriggio scarpinavo fino al muro posteriore della villa. Ma mi fermavo lì, perché mi rendevo conto che non avrei saputo cosa dire a zia Wìlma, per consolarla. Fu invece lei che mandò Margherita dalla nonna a chiederle che mi permettesse di andare a trovarla.
Ovviamente zia Wìlma non continuò la spiegazione circa il funzionamento delle navi, dei sommergibili, deisiluri, delle vele, dei remi, dei timoni, delle paratie stagne, dei cannoni, dei fucili ad avancarica e a retrocarica; su come si inchioda una lamiera, su come si cala una scialuppa in mare e su come si alza una vela. Mi spiegò soltanto quel che già avevo orecchiato. Quando lei aveva vent’anni, Castellammare era molto importante per la flotta. Nel conflitto tra Castellammare e La Spezia, la loro vita - la sua e quella di zio Paolino, quella dei loro figli e nipoti - era stata, se non proprio rovinata, sicuramente spostata verso un altro destino. Lei qui, vecchia e sola, vedova e straniera, e loro - i figli e i nipoti - in Germania; un paese vinto, dove per molto tempo non c’era stato pane a sufficienza per tutti, per di più con un nome e un cognome italiani, malvisti da tutti.
Lei era l’unica figlia dell’addetto navale dell’ambasciata tedesca e zio Paolino il più brillante dei giovani ingegneri navali italiani. Si erano incontrati nei salotti di Napoli, che a quel tempo erano ricchi e splendidi quanto quelli di Parigi. Anzi di più.
“C’erano più teatri a Napoli che in tutto il resto d’Italia”.
Lei era molto bella e corteggiata. Anche zio Paolino era bello e cor
36
teggiato. Entrambi erano vezzeggiati da tutti. Si sposarono. L’avvenire prometteva rose e fiori. Ma quando il governo decise d’abbandonare Castellammare, i napoletani urlarono di dolore. Zio Paolino urlò con gli altri. Il governo non cedette e zio Paolino fu trasferito per punizione in Africa, a Massaua, con la scusa di allestirne il porto. Dopo qualche anno fu ritrasferito ad Ancona, ma sempre per drenare sabbia dal fondale del porto. A quel nuovo affronto, dimenticato da tutti, zio Paolino s’inviperì e volle vendicarsi. Lo fece riparando così male le eliche di una fregata che, appena in moto, questa andò a sbattere contro la banchina.
Dovettero scappare in Francia, e dalla Francia in Germania. Ma nel 1914, quando la guerra tra Italia e Germania era già prevedibile, zio Paolino, non volendo stare contro l’Italia ed essere chiamato traditore, se ne andò in Russia, a lavorare per lo zar, nei cantieri del Mar Nero. Qui assistette alla rivoluzione. Poi tornò in Germania e, da lì, poté rientrare in Italia mercé la mediazione dell’ambasciatore britannico. Ma non riebbe il grado, né ebbe la pensione. Per fortuna aveva guadagnato parecchio con la progettazione e la costruzione di una petroliera svedese. I figli invece erano rimasti in Germania, dove si erano laureati. Le donne avevano il nome delle navi alle quali zio Paolino aveva lavorato: Duilia e Romana.
Quello stesso inverno zia Wìlma morì mentre si trovava in Germania, in visita ai figli.
*
“Nonno, zio Paolino dice che voi siete un asino e un cacone, uno che se la fa sotto ... ”
Il gioco della memoria è sicuramente cosa da poeti. Una volta che ti
37
ci immergi, il presente scompare, e con esso - felicemente - evaporano le noiose scadenze che aduggiano la vita dell’uomo comune. Il passato torna attuale, ma depurato da incertezze, e le persone morte si ripresentano con un carattere netto; con colpe e meriti scritti in fronte.
Quando mi sono messo a scrivere del passato, credevo che non fosse necessario turbare la pace di una tomba ricavata sul fianco di una rupe, in un fresco cimitero della Costiera; un luogo ormai muto e di-sadorno, dacché anche le gambe del nipote sono invecchiate. Nessuno più che vi porti un fiore, né una mano amorosa che strappi i ciuffi d’erba cresciuti nelle fessure dei marmi ingialliti e sconnessi. Ci sono sacralità - mi dicevo - che dovrebbero travalicare i conclamati doveri del narratore. E poi umanamente mi domandavo qual mai utilità ci sarebbe a infrangere un ricordo gentile, ad allontanare dalla nuca di me bambino la carezza di una mano calda e protettiva. Disturbare i morti, penetrare i segreti che hanno portato con sé, profanare le chiuse tombe, non è forse, per l’uomo civile, il più esecrando dei delitti?
Ma la storia degli Alfano – lo capisco solo oggi che ho la penna in mano e davanti a me i fogli bianchi - non appartiene a me, né a mio padre, né a mio nonno. E’ invece la storia di tutti noi.
Gli Alfano erano fin troppo ben educati per mostrare all’esterno i dubbi che covavano nelle loro coscienze. Quel vegliardo autorevole e rispettato - ma con me tenero e dolcissimo - era veramente uno scemo per bonezza, come diceva affettuosamente e ingenuamente sua moglie? Era vero che fosse un asino e un cacasotto, come sosteneva zio Paolino Conforti? Ed era proprio vero che non sapesse cavare ’no sorece morto ’a dinto ’o pertuso, secondo il giudizio di Miniello? Ma non era stato proprio lui che s’era fatto scippare dai genovesi il commercio dell’olio e la Banca di Sconto? O, riproponendo sinteticamente
38
la stessa domanda, era vero che la Ditta si era afflosciata sotto la sua guida bonacciona e non sufficientemente competitiva?
Queste domande - il dubbio con esse connesso - mi hanno a lungo trattenuto la mano.
Lasciavo la biciclettina in custodia a Peppiniello, alla capanna dove si vendevano le angurie tagliate a fette e tenute al fresco nella neve ghiacciata. Ce ne andavamo, il nonno e io, tenendoci per mano, verso la Torre e il cimitero, mentre il sole si abbassava sul mare abbagliandoci.“Guagliò, io so’ vecchio, ma prima di morire aggia a capì cosa vuoi fare da grande” Ma più che una domanda a me, era una domanda a se stesso.
A me ragazzo era chiaro che, tanto per mio nonno quanto per mio padre, il destino della Ditta era segnato. Già il sistema mussoliniano degli ammassi e delle assegnazioni l’aveva portata a perdere terreno a favore di concorrenti che in precedenza non le facevano ombra. Inoltre l’America aveva bloccato l’emigrazione e di conseguenza la povertà dilagava in Calabria. Questa terra, che gli Alfano avevano molto usato ma poco amato, invece d’addolcirsi, si faceva ogni giorno più inospitale.
Il mio avvenire, già incerto per cause oggettive, era poi reso improbabile dai pericoli insiti nel mio stesso temperamento. Il nonno e papà mi leggevano dentro cose che io non ero capace di vedere, anche se poi ero capace di capire che erano perplessi e, in qualche modo, preoccupati. Mi rendevo conto d’essere insolitamente generoso, ma a insegnarmi la generosità erano stati proprio loro due. Sapevo anche d’essere alquanto spericolato nel buttarmi avanti, ma nei ricordi del parentado materno, il nonno Ninai non veniva ammirato ed elogiato per la stessa
39
cosa? C’erano poi da mettere in conto quelle che la mamma chiamava esaltazioni, e che non saprei meglio definire neppure oggi. Io non so se la mamma mi considerasse un matto o un eroe, sta di fatto che, prefigurandosi il mio futuro, a volte piangeva, a volte s’esaltava e mi chiamava mafiosetto mio.
Tutto era cominciato a scuola. Siccome avevo preso a rifiutare la colazione del mattino, la mamma, che era sempre a badare che mi nutrissi abbastanza, d’accordo con il maestro (che in effetti fu il suggeritore di quella punizione) mi mandò la zuppa a scuola. Il maestro mi convocò sulla cattedra, accanto a sé, e mi regalò un commovente sermone sul privilegio d’avere di che nutrirmi, mentre “decine di compagni, sicuramente affamati, ti stanno invidiando”.
La predica andò oltre le cattedratiche aspettative. Non solo ingoiai la zuppa lacrimando, ma a partire da quel momento ogni mattina mi presentavo alla salumeria Sabbato, con un gruzzolo di monetine, e acquistavo una decina di panini con la mortadella, che poi distribuivo fra i compagni che sembravano più ansiosi di consumarli. Potevo permettermi la connessa spesa in quanto la mamma mi faceva custodire il danaro che ricevevo in dono, affinché imparassi a risparmiare. Dovevo metterlo da parte fino a raggiungere la cifra di mille lire, la quale era quella occorrente per acquistare un Buono Fruttifero Postale.
Ovviamente sapevo in anticipo che don Daniele Sabbato si sarebbe sorpreso di fronte a quel consistente acquisto. Così, per parare il colpo, mi preparai in anticipo una bella bugia. Anzi una piccola sceneggiata. Affermai che i compagni mi avevano affidato i loro soldi, in modo che facendo un acquisto consistente avessimo uno sconto sul prezzo. Dapprima don Daniele abboccò, e mi dette in omaggio un tredicesimo panino, ma dopo alcuni giorni della stessa solfa si rese conto che per
40
le possibilità di San Policarpio era veramente troppo. Fece in modo d’incontrare mio padre e lo informò dettagliatamente.
Non venni punito, ma mi fu spiegato che l’avvenire era insicuro per tutti. E che, come insicuro fra gli altri insicuri, avrei dovuto reprimere simili moti dell’animo fino a quando non avessi raggiunto la capacità lavorativa e l’attitudine a produrre un reddito e a riprodurre le mie sostanze. A partire da quel momento in famiglia si andò rassodando la convinzione che in avvenire avrei, forse, saputo difendere il mio patrimonio dagli attacchi esterni, ma che esso sarebbe stato esposto ai più tremendi pericoli per effetto di attacchi interni, cioè provenienti da me stesso.
“Hanno fame ... ” affermavo, riferendomi ai compagni di scuola, e piangevo. Allora le braccia della mamma si aprivano e io vi cadevo dentro. E continuavo a piangere, e lei a dire: “La povertà è un’ingiusta maledizione di Dio ... E’ più grande del mare e mai nessuno la potrà colmare ... ”
Il peggio venne dopo. Insoddisfatto, il mio solidarismo scolastico si voltò in misticismo. A sera, mi mettevo a spiare da lontano le porte della chiesa e quando vedevo Ernesto, il sacrestano, allontanarsi per un bicchiere di vino alla bettola, vi entravo guardingo e andavo a piegarmi dinanzi alla Madonna, per pregarla di procurare soldi agli indigenti. Non potendo dare alla Madonna altro che la preghiera, mi portavo dei sassolini in saccoccia, onde metterli sotto le ginocchia nude, e rendere, mercé la connessa sofferenza, ben accetta la mia preghiera.
.
Anche mio padre, il quale aveva guardato alla vicenda dei panini dall’alto del suo scetticismo pedagogico, si rese conto di quanto vani fossero gli sforzi che andava compiendo per tracciarmi un percorso
41
chiaro e consueto. Ma più degli altri era in apprensione il nonno. Era convinto che il nipote fosse buono e fiducioso come lui e che, perciò, sarebbe finito stritolato nelle spire di una società marginale e arretrata, quale riteneva fosse la Calabria.
Camminando incontro al sole, verso la Torre, tornava alla rituale domanda su cosa volessi fare da grande. Invariabilmente rispondevo: “Il marinaio, nonno.”
“Pe’ mare non ci stanno taverne. No, non te lo consiglio. Scegli un mestiere più sicuro. Qualunque mestiere, però no in Calabria. E’ terra ’e mala gente ... infida e traditrice ... No, non so’ cristiani.
“Penso al destino dei miei figli ... Prima Giacchino ... adesso Genso ... Lontano da Dio e dagli uomini. Fortuna vuole che ha trovato una brava ragazza ... una signora, che lo vuole bene e lo rispetta ...
“Chiste sorde noste so’ faticate... Chilli poche che so’ rimasti! ... Più di cento viaggi ho fatto in Calabria. Mio figlio Gioacchino ha passato sei anni nella solitudine ... fra i barbari, e mio fratello Generoso - pace all’anima sua - un’intera vita ... Sin da quando aveva ventidue anni ... Questo glielo dobbiamo riconoscere dinnanzi a Dio: io a Napoli, nella civiltà, e lui nell’ Affrica ... La sua condanna ...
“E s’è perduto là, con chella megera. Un patrimonio bruciato appress’a chella femmena... Biglietti e biglietti da mille, Paolì... Centinaia di migliaia di lire ...
“Tutti me lo rimproverano. E io come glielo impedivo? Un uomo grande, un padrone, un vecchio!
“Non sempre, Paolì, le leggi antiche so’ giuste ... Non si doveva sposare ... Una la famiglia, uno il patrimonio: questa era la legge ... Ma poi si finisce accussì, con una donnaccia ...
“La conosci donna Diana Codispoti? ... donna Jana, la Cavaliera,
42
comme la chiammano?”
“No, nonno. Però la mamma la nomina spesso.”
“Meglio accussì ... Sono cinquanta lire al giorno di legato, millecinquecento lire al mese, diciottomilalire all’anno ... Neanche il Procuratore del Re ...
“La Calabria è stata la nostra fortuna, ma è stata pure la nostra tomba ... Non faceva per me e non fa per te. No, tu si’ ’nu bono figlio ... ma non prendi da tuo padre, che pesa gli uomini co’ na sola occhiata ... ‘A Calabria non fà pe’ te...
“Tu vuoi andare per mare, ma adesso che i bastimenti non ci stanno cchiù, dovresti andare sotto padrone ... No, non ce la faresti ...
“Sai che ti dico? Perché non fai il medico come zio Dante, che vive tranquillo e sereno, o come zio Ettorino? Tu nun l’hai conosciuto, il fratello della nonna ... un vero scienziato ... amico di Cardarelli ... noto dovunque per la sua scienza e la sua carità ...O come tuo nonno Ninai, un grande chirurgo… Fai il medico e te ne vieni qui, in Costiera, nella casa di tuo nonno... Tieni ‘nu bello palazzo ... parenti, amici... tutto ... Ti sposi ... .La gente t’invidierebbe.
“L’avvocato no! L’ingegnere ... Ne putimmo parlare male quanto vulimmo per il suo carattere pazzo, ma zì ’ Paolino, anche lui…Era un grosso ingegnere, un professionista di valore, conosciuto in tutto il mondo. Che ha lavorato dovunque...Russia, Germania, Svezia… Di lui parlano i libri ...
“Tu questo devi fare: l’ingegnere. Se il mare t’appassiona tanto, l’ingegnere navale, come zì Paolino. Ma in Calabria no! Della Calabria non ti puoi fidare ... Ha ingannato me, ingannerà pure te ... Non è per noi ...
“L’Onorevole, lo conosci?”
43
“Chi? Zio Ferdinando?”
“No, questa parola, no ... quell’uomo, non la merita. Zio! ... No, mai ... Certamente non so’ cose pe’ criature ... ma questo te lo devi ricordare, anche se sei un ragazzino ... Sempre te lo devi ricordare. E’ soltanto il marito di mia sorella, ma il tuo sangue non viene dal suo ... Noi siamo altra gente, noi non siamo calabresi ...
“L’ho portato in Parlamento ... al Governo ... Gli abbiamo dato soldi, gli abbiamo trovato i voti ... Gli ho persino dato in moglie mia sorella ... E lui, per ringraziamento..!
“Non bastava il danno, anche la vergogna ... La vergogna, figlio mio ! ... La vergogna ! ... Una vergogna senza fine ... Una vergogna per tutta la famiglia ... Un traditore ... Un vile ... ‘Na carogna…
“Devi promettere che mai mischierai il tuo sangue con il suo.”“E come potrei mischiarlo, nonno?”
“Tu si’ ‘na criatura ... Non dovrei ... Ma io morirò prima che tu arrivi all’età per capire ...
“Tu, Paolì, zia Minicuccia la devi onorare e rispettare. E’ la sorella di tuo nonno, la zia di tuo padre ... La più piccola delle mie sorelle ... la più dolce ... Io ero già grande e lei ... E come suonava il pianoforte! ... Pergolesi, Cherubini ... L’ho perduta! ... L’ho rovinata! ... Perché quell’uomo l’ha conosciuto per colpa mia ... Non lo so! ... Non lo so!
“ Miniello dice che non so tirare ’no sorece morto ’a dinto ’o pertoso ... Proprio lui! ... Forse, Paolì, forse so ‘nu scemo veramente... Ma poi certe cose! ... A ogni cosa c’è un limite ... Comunque, stai largo dai Surrenti ... Onora la zia, e basta ... No so’ gente che fa per noi ...
“Papà ti ha mai parlato della nostra banca? Della Banca Agricola di Sconto? Sai perché il governo ce la tolse?
“No? ... Ecco, sentirai cose ingiuste a proposito di tuo nonno ...
44
Forse io sono un imbecille veramente ... ma l’affare della banca non era sbagliato...Al contrario ... Non ho distrutto un patrimonio ... Due milioni ci avimmo miso e ne abbiamo incassato due e mezzo ... Quindi non ci ho rimesso, ma guadagnato ... La verità è che dopo sono scomparsi i guadagni.”
“Dopo che cosa, nonno?”
“No... niente, non puoi capire. Però agli occhi di mio nipote, di chi porta il mio nome! ... Tu si’ ancora ‘na criatura, ma devi aver fede, devi credere a tuo nonno ... La verità vera ancora non si sa. Non si può sapere. Fu tutto politica ... porcheria ... Quel che si dice è falso ...
“E poi devi promettere che ti terrai sempre lontano dai Surrenti, da suo figlio e dai figli di suo figlio ... Questo lo devi promettere: ... non mischiare mai il tuo sangue ... ”
“L’animo mio è pulito. Ho perdonato e posso salire in qualunque momento al cospetto del Signore e Giudice. Però ti dovevo avvertire ... Degli altri il Signore abbia pietà ...
“La Calabria è tutta così ... Non c’è fede ... Non c’è pubblica fede... Vattenne ... non è cosa per te.
“Puoi andare in America, se vuoi. E’ un paese giovane e onesto.
“Appena prendi la licenza liceale, te ne vai a Boston, all’università, a fare gli studi navali. Adesso è famosa come quelle inglesi.
“La Ditta è finita ... Solo il coraggio di tuo padre la tiene in piedi. Tutto il Napoletano è finito ... Napoli è un cimitero ... Il porto ... Torre, no ne parlammo! ... L’America! ... Ci sono stato con mio figlio Giacchino nel 1913 ... Lo dovevo presentare alla borsa merci ... Quanti sogni, figlio mio benedetto! ...
“A Boston ho parecchi amici ... uomini di grande rispetto ... e anche i loro figli ... 45
“Lo vedi quest’anello? Quest’anello è tuo. Non passa per tuo padre. E’ direttamente tuo dal giorno stesso che non ci sarò più ...come il palazzo.
“Tu vai in treno fino a Calais, poi da Dover a Liverpool ... Da lì è cinque giorni di mare ... A Liverpool, tu mostra l’anello, ma senza fà vedé. Alzi solamente la mano. Loro capiranno e ti daranno la migliore cabina. Il capitano ti farà mille gentilezze. A Boston ... a suo tempo, tuo padre ti dirà dove ... ti apriranno tutte le porte. Ti accoglieranno e ti sposerai lì ... E sarà come fondare nuovamente il casato ... fra gente libera e onesta.”
Quando il sole era già calato sul mare, arrivava Anselmo con la car-rozzella di piazza e andava a farle invertire direzione di marcia un po’ più avanti del cancello del cimitero, dove la curva era stata allargata. Se c’era la biciclettina, veniva caricata sulla rastrelliera e noi salivamo. Il cavallo partiva lentamente. Il nonno, aperta la giacca, mi avvolgeva con la falda e mi stringeva a sé.
*
Perché odiasse la Calabria, l’ho capito soltanto parecchio tempo dopo. Allora davo un riferimento completamente diverso alle sue parole. L’arretratezza di San Policarpio era evidente. Capursi era invece profumata, ricca di acque per l’irrigazione, varia, piena di colori. La gente vestiva elegantemente, c’erano gli inglesi (che poi erano per la maggior parte americani), la casa era bella e piena di mobili ben lucidati. Le persiane socchiuse rendevano tenero l’abitarvi. I giardini erano ricchi di frutta e i contadini allegri e affezionati. Al chiosco vendevano i sottencoppa. Papà aveva un chiozzo e quando il vento era propizio, Romualdo alzava la vela, a me facevano mettere il salvagente di sughero e si andava lontano, fino al Fiordo di Calore, a Conca
46
e a Praiano, oppure fino al Capo d’Orso; e alla sera, in macchina, a Ravello, per sentire l’orchestra. E cenavamo in trattoria.
Il nonno non veniva mai con noi, né per mare né a Ravello. Al mattino, letto il giornale, si metteva a scrivere. Dalle dieci a mezzogiorno. La mamma gli chiedeva sorridendo: “Papà, state scrivendo un romanzo?” Usava dei fogli formato protocollo, ma senza righe. Quando gli chiedevo dove comprasse quell’insolita carta, lui sorrideva dolcemente e mi diceva che tutte le risme che non avrebbe consumato sarebbero state mie dopo la sua morte, e pure l’orologio d’oro con la catena per il panciotto, il famoso anello e il palazzo.
“Accussì sei subito il padrone e resti qui a fare compagnia alla non-na.”
Il nonno odiava suo cognato Surrenti, ma non era permesso chiederne il perché. L’informazione l’avrei avuta a tempo debito, da grande. Oltre all’anello, all’orologio e al palazzo, erano destinate a me le carte che stava scrivendo. “Adesso le tiene papà e quando sei grande te le dà.”
Mammà commentava: “Non è la vecchiaia. E’ vero, quando s’invecchia non sempre si connette pienamente, ma papà è sempre stato così ... Come dire ... un po’ poetico. E’ lucido, lucidissimo ... ma è un po’ poeta.” Gli apprezzamenti che si sussurravano su suo padre ferivano papà, e non sempre egli riusciva a trattenersi. - “Ma che ne sapete voi? Era un uomo che voleva essere a posto con la sua coscienza e con Dio. I fatti della vita non sempre è possibile dominarli, ma ha affrontato le difficoltà, le avversità, il dolore con la fronte alta e l’animo sereno. Non è compito mio giudicarlo, ma chiunque altro voglia farlo, prima bisogna che conosca la storia d’Italia.”
Cosa c’entrasse l’Italia non l’afferravo d’altra parte lui, a quella
47
considerazione, s’impuntava e non andava avanti. Eppure la sentivo di un’oscurità minacciosa. Che c’entrava il nonno con Mazzini e Garibaldi, lui che neppure aveva partecipato alle guerre d’indipendenza? - “Al tempo di Garibaldi ero ancora un ragazzo, avevo dieci anni. Quando, poi, ci fu la presa di Roma ero a Marsiglia, a imparare il mestiere nel fondaco di Monsieur Leboyer. La Francia era sconfitta…L’avevano con gli italiani. Mi dovetti nascondere… No, Paolì, lo so che a te ti dispiace, ma non ho partecipato alle lotte per l’indipendenza.”
*
Quando morì, avevo undici anni. Quel giorno fui vestito da ometto, con gli abiti giunti espressamente da Salerno che ancora era notte: i pantaloni lunghi e una giacchetta grigia, un cravattino nero e una larga fascia nera sul braccio sinistro. Mi toccò camminare per mano a mio padre, soli in testa al corteo. Gli altri parenti indietro un metro, con zia Anita al centro, mentre le campane della Cattedrale suonavano accoratamente a morto. Zì’ Prevete e tutto il Capitolo della Cattedrale e la Congrega di San Giacomo camminavano avanti salmodiando.
Miniello pretendeva che in quella circostanza io portassi il magico anello - “un anello da principe, una luce” - che tutti potevano vedere, ma del quale non si poteva assolutamente parlare. Solo che, per quanta ovatta ci mettesse attorno, l’anello mi cadeva lo stesso dal dito. Così, per non provocare rumori inopportuni e indebite distrazioni durante le esequie, oltre che per la paura di perdere l’oggetto prezioso, l’inanellamento fu procrastinato a miglior tempo. In appresso, un miglior uso delle categorie di spazio e di tempo mi ha portato a capire che la morte di Patreppaolo aveva segnato la fine della famiglia sulla Costiera.
Da ragazzo, ancorato com’ero alla viva realtà della mia ruga, non
48
mi rendevo conto di qual era stato il ruolo di Patreppaolo nella società capursina. D’altra parte tutto convergeva a farmelo sottovalutare, in primo luogo lui stesso e la nonna, che erano persone d’indole modestissima, autocollocatesi fuori d’ogni giro sociale.
In effetti la loro generazione era ormai agli sgoccioli, mentre i figli e i nipoti s’erano costruiti interessi autonomi.
Ora l’addio veniva celebrato - e rimarcato - con una solennità a cui non ero preparato e che mi colpì, e colpì anche mia madre. Eravamo arrivati il giorno prima, mentre papà ci aveva preceduti. Quando l’avevo rivisto, l’avevo trovato un uomo diverso, senza mitezze. Distaccato. E adesso che camminava in testa al corteo tenendomi per mano - elegantissimo come solo lui in famiglia sapeva esserlo - capivo che era tutt’altro uomo dell’essere disincantato che conoscevo. Poi i fatti si presero una pesante rivincita, ma allora pareva proclamasse: “Ho sempre un piede qui. Sono e resto un Alfano, uno di qui, uno che conta.”
Non avevo mai visto, né avrei mai più visto tante giacchette nere sui pantaloni grigi rigati quante quel giorno. E altrettante teste canute scappellarsi e inchinarsi profondamente dinanzi a papà e allungare la mano protettiva per carezzarmi il capo. Adesso che il nonno era morto e stava steso in una bara senza vita e pensiero - visibile soltanto con uno sforzo dell’immaginazione - gli Alfano eravamo rimasti in due soltanto. E nella logica dello svolgimento naturale, prima papà, in appresso io, avremmo dovuto fare scudo alla famiglia; proteggerla e guidarla. Mantenerne la ricchezza e il rango. E mai sbagliare.
E sempre avremmo dovuto pagare interamente il debito, se sbagliavamo. Quei signori con la giacca nera, il capo scoperto e il cappello nero in mano, stavano lì a ricordarcelo. Nonostante l’età immatura,
49
avevo già assimilata l’idea che il privilegio d’essere un grosso mercante aveva un suo specifico costo. Quel viaggiare per il mondo senza essere abbrutito dalla miseria e dalla sporcizia - fisicamente sui cuscini di seconda classe, ma solo per modestia, e in prima se c’era anche la mamma - il palazzo, i salotti, il vasellame pregiato, il Terminus e il Massimo d’Azeglio, il facchino per le valigie, le scarpe dietro la porta, la carrozzella, il barbiere con la tovaglia candida, non erano gratis; avevano invece un prezzo: non sbagliare, rispettare le regole.
Il fatto poi che tali regole non fossero codificate, ma di volta in volta dovessero essere indovinate dall’Alfano apprendista, costituiva per me la materia d’esame. E questo mi spaventava.
Certamente, nei ranghi sarei rimasto soltanto se non avessi mai sbagliato: questa era la costituzione materiale della borghesia mercantile. Ma ero nato per sbagliare, e non me ne dolgo.
*
Quando si parlava della Sede, cioè dell’antica centrale napoletana della Ditta, papà - lui sempre così misurato! - adottava una certa enfasi. La mamma sapeva soltanto che c’era stata, mentre la nonna, se e quando ne parlava, faceva pensare a un costo della sua esistenza. Ed è anche facile capire il perché. Infatti suo marito, Padron Paolo, al lunedì mattina prendeva il vaporetto che da Amalfi lo portava a Napoli, dove rimaneva di solito fino al venerdì, allorché una diversa e opposta coincidenza del medesimo vaporetto lo riportava a casa, in Costiera.
Ripensandoci mi rendo conto che la nonna era stata giovane anche lei, e magari gelosa, e forse in ansia per il marito, che rimaneva quasi una settimana da solo in una città immensa e non certo famosa per i suoi morigerati costumi; un marito che lei - non v’era dubbio - avrebbe invece voluto tenersi sotto la gonnella.50
Sicuramente a Napoli era meglio che in Calabria, la terra che entrambi i miei nonni - in misura diversa e per motivi diversi - detestavano. Credo che la nonna, come tutte le mogli del passato, avrebbe preferito un marito agricoltore e redditiere, per tenerselo a casa, a portata delle faccende e dei problemi familiari.
Per questo motivo, pur nella singolare dolcezza del suo temperamento e nella mitezza dei suoi sentimenti, la nonna non amava Napoli. Non aveva amato andarci - lo dichiarava apertis verbis - sebbene la Sede, sotto l’aspetto abitativo, fosse più che decente e confortevole, e sebbene lei stessa in prima persona avesse a Napoli legami familiari illustri, come spesso ci narrava. Insomma, quelle volte che vi era andata, non era giunta in un luogo poco ospitale, né sconosciuta in terra di sconosciuti. E però Napoli, responsabile di sottrarle la compagnia e la tutela del consorte per cinque giorni su sette, era sempre e comunque una nemica.
Ben diversi erano i sentimenti di suo figlio. Papà non indulgeva alla retorica per indole e per educazione, tranne alcune cose. La prima sicuramente era rappresentata dall’epos di Trento e Trieste; la seconda era la mitica piazza di Londra, che imponeva le sue condizioni a tutto il mondo mercantile e non; la terza andava equamente divisa tra la Norma e la Lucia di Lamermour. Subito dopo, o assieme alle prime tre, c’era il suo immenso amore per Napoli e i teatri di Napoli. Cosa che includeva alcuni non ancora santificati poeti e teatranti, a nome Salvatore Di Giacomo, Eduardo Scarpetta, Raffaele Viviani.
Ma anche nei suoi discorsi - le rarissime volte che parlava di sé o della famiglia d’origine - la Sede si presentava come il ricordo di un passato prestigioso, e tuttavia lontano nel tempo e nello spazio. In effetti lui, la Sede, l’aveva sì vista, ma mai adoperata, posseduta,
51
diretta; era come il quadro di un antenato guerriero per un discendente che si è ridotto a fare il sacrestano. In buona sostanza, neppure una nostalgia, ma soltanto un mito. Da internazionali che erano stati, adesso gli Alfano erano di rango provinciale, anzi paesano. E chissà cosa riservava loro l’avvenire! La Calabria li aveva travolti nel suo mottoso franare, soffocati nella sua immensa lontananza e solitudine. “Qui finisce il mondo.”
Sicuramente papà era troppo avvertito per ignorare che da tempo il mondo si era ritirato anche da Napoli e che ormai la città ricadeva fuori dal confine ideale della civiltà, come lui generalmente l’intendeva. Ma pur essendo tutt’altro che incline allo sciovinismo, su questo punto amava incantarsi. C’era un valore napoletano di natura eterna, incoercibile e insopprimibile, che gli altri spesso riconoscevano e gustavano, però da estranei. Del quale invece lui, in quanto interno, partecipava, e del quale, un giorno, anch’io avrei partecipato, se avessi saputo bere alla fonte fatata della napoletanità.
Quando, più grandicello, una volta gli chiesi che me lo indicasse, egli si spiegò con una breve frase: “A Napoli si parla.” Poi, come se ci avesse riflettuto su, aggiunse: “Il Verbo ... lo sai? ... Quando Dio volle farsi conoscere dagli uomini disse di sé: “Io sono il Verbo”. Ebbene, la parola è la superiore manifestazione della napoletanità”.
Una tale visione comportava che Napoli fosse la quintessenza del mondo, e per la legge dei vasi comunicanti, che la Sede napoletana della Ditta fosse stata partecipe di quella qualità mondiale.”
*
Ancor oggi ciascuna parte della città di Napoli è come specializzata in una funzione. A maggior ragione in passato. Secondo tale logica comunale, gli Alfano, armatori e mercanti per pubblico riconoscimen
52
to, sebbene amanti della musica lirica, mai avrebbero stabilito la loro sede accanto al San Carlo, ma sicuramente vicino al porto, anzi tra il porto e il Mercato.
Debbo confessare che come ogni non nato a Napoli, ho ancora una certa confusione in testa circa l’ubicazione e i confini degli storici rioni, o quartieri cittadini, ma se ce n’è uno che mi confonde più degli altri, questo è il Mercato. Non so bene dove cominci e dove finisca, meno che mai lo sapevo allora. Ma sono certo che il suo cuore storico è l’omonima, famosa Piazza dove fu giustiziato Corradino e dove si spense il sogno ghibellino di fare l’Italia senza l’intervento biforcuto di Cavour.
Sapevo che la sede della ditta sorgeva non lontano dal luogo dove fu mozzato il capo al giovanetto e cancellato per sempre ciò che simboleggiava. E invece la Napoli di poi, che qualche volta s’illuse d’essere giacobina, chiusa tra l’acqua salata e l’acqua santa, è stata sempre e soltanto papalina. E l’amaro tributo a Roma di una cavalla bianca è tuttora inavvertitamente versato e riscosso con funebre puntualità.
La Sede la vidi un giorno del 1939, quando il nonno era già morto.
Ai miei occhi l’edificio non parve niente di speciale. Papà mi spiegò che il fabbricato originario era stato rimaneggiato e sopraelevato per farne un albergo, ad opera di certi nostri parenti, che l’avevano acquistato dopo la Guerra e la prematura morte di suo fratello.
“Vedi quella finestra d’angolo al primo piano, proprio a mezzogiorno? ... Lì aveva dormito mio nonno e ci dormiva anche mio padre.”
Più che istruirmi, credo che, almeno per un istante, avesse in animo di trasmettermi un messaggio, di presentare gli antichi fasti degli Alfano come un traguardo da raggiungere, una posizione da ricon
53
quistare. Sicuramente un attimo di autoinganno, che sebbene ragazzo, non mi sfuggì.
“Mio padre - Patreppaolo, come lo chiamano anche qui - ci teneva ad avere una stanza a mezzogiorno ... Dovunque si trovasse, s’alzava presto e voleva vedere il sole. Nella stanza accanto c’era un salotto ... Sotto stavano gli uffici e i magazzeni.
“Al tempo di mio nonno, qui venivano persino i Rothschild per i loro affari, e i ministri della casa reale ... quelli dei Borboni ... Il principe di Terranova era di casa. Era il nostro protettore. Ci vendeva centinaia e centinaia di botti d’olio e veniva a riscuotere ...
“Proprio per ricevere le illustri personalità, il nonno s’era fatto fare dal miglior mobiliere di Napoli il salotto di seta bordeaux che adesso è nello studio di papà, a Capursi ...
“Quei tempi sono tramontati…
“In questa casa ci ho dormito pure io, qualche volta. Lì, sul retro ... Una stanza che rimaneva chiusa da quando mio fratello era partito in Calabria ... Sì, perché l’ultimo anno di scuola l’aveva fatto qui ...
“Raccontava sempre Giacchino che qui c’era allegria. Venivano i cugini Capone ... Erano di casa. Specialmente Ciccillo, che faceva il tirocinio d’avvocato ... Morti tutti e due...E Lorenzo...”
Ero già abbastanza cresciuto per comprendere che zio Lorenzo era stato ferito all’organo genitale, ma papà, con me, era molto pudico. Lo era tanto che, anche decenni più tardi, quando gli toccava nominare gli organi genitali, lo faceva ricorrendo ai freddi termini accettati dal vocabolario.
“Con papà, loro, avevano una gran confidenza. Non come noi, io e Giacchino, che ce la facevamo sotto. Figurati che Gioacchino bruciò l’ombrello di seta per non farsi vedere con la sigaretta da papà... C’era
54
allegria, qui, prima della guerra. Un mondo scomparso nelle trincee.
“Allora papà faceva ancora buoni profitti. Prima che io nascessi ... dopo che i Conforti si ritirarono dalla Ditta, lui rimase solo con zio Generoso. Cosicché vendettero le due vecchie golette, che erano arrivate a loro dalla divisione con i Conforti, e ne comprarono una nuova, più grossa ... più veloce…In Inghilterra. La chiamarono Anita, così pure mia sorella ... Questo nel 1898, due anni prima che io nascessi ...
“Ma l’olio era perduto. Ormai c’era la ferrovia e per viaggiare in Calabria le golette non servivano più. Andava, invece, in Grecia carica di cordami e tornava portando grano per il pastificio Tancredi di Salerno. Ma il guadagno maggiore papà lo faceva con il baccalà ... La Banca lo finanziava fino a tre, quattromila quintali e l’Anita andava in Portogallo a trasbordarlo. Poi lo rivendeva a Napoli, ma anche in Calabria, in Sicilia, a Genova, a Venezia…Papà non stava fermo!...“Anche gli acquisti per i negozi che tenevamo in Calabria, che allora erano quattro, si facevano qui a Napoli. La pasta, la farina, le patate ... Zio Generoso spediva un telegramma al giorno, per dire al fratello come andava la piazza in Calabria e quello di cui c’era bisogno, e papà si regolava ... E un po’ d’olio continuavano pure a commerciarlo, quello buono per il consumo. Avevano parecchi clienti a Napoli...
“Certo non erano più i tempi di mio nonno, quando con l’olio si facevano i milioni, ma si campava ancora bene ... Per questo mio fratello Gioacchino andò in Calabria a imparare il mestiere ... Tra me e lui c’erano otto anni di differenza ... Papà e zio Generoso erano andati a Marsiglia, a imparare, da Monsieur Leboyer, ma ormai l’olio era poca cosa, non c’era nessuna ragione che Gioacchino andasse in Francia ... Così mio padre stava a Napoli, e Giacchino in Calabria con zio
55
Generoso, a imparare ... Ma poi l’Anita fece naufragio ... Subito dopo venne la guerra ... la svalutazione ...
“Dopo la guerra papà chiuse. Teneva quasi settant’anni ... Era nato nel 1850. Un figlio perduto pochi giorni prima che la guerra finisse ... Era credente, ma per un momento dubitò di Dio ... Chiuse la Sede e vendette l’edificio. Lo comprò un cugino, che ci fece un albergo ... Cedettero anche tre delle succursali che avevano in Calabria ... Troppe ruberie. Si tennero soltanto il fondaco di San Policarpio. Di tanti che erano prima, erano rimasti soltanto due vecchi ... Dovetti lasciare gli studi e andare in Calabria ... Ma solo per gli alimentari, il commercio dell’olio non c’era più.”
*
Gli capitava raramente, ma quella fu una delle poche volte che papà steccò. Si era lasciato andare a una pretesa eccessiva; non si era reso conto che ero immaturo per intendere i suoi sentimenti. Certamente capivo che un tempo la famiglia era stata molto attiva, ma il fatto non mi toccava. Era un dato della storia familiare, niente di più.
Più che istruirmi, la visita all’antica sede mi aveva piegato. La bella Napoli mi lasciava assolutamente indifferente. Per giunta papà, che era un camminatore instancabile, mi aveva fatto macinare chilometri su chilometri. A quel punto le cose che desideravo più ardentemente erano nell’ordine: sedermi e mangiare.
“Bah, adesso andiamo da Michele.”
“Eccoti subito accontentato”, voi direte. Invece un invito a buttarsi nel cratere del Vesuvio, che allora ardeva e fumava, non sarebbe stato considerato più minaccioso di quel Michele buttato là con indifferenza. “Quando la mamma lo saprà, succederà il finimondo”, pensavo. Tuttavia seguii papà. Infatti i ragazzini d’allora eravamo usi a obbedir
56
tacendo, tal quale i carabinieri.
Altra scarpinata, questa volta in salita. Ci accolse la linda e fresca trattoria di don Michele, Al Pioppo Reale, dove - come sospettavo - mio padre non era un cliente ma un commensale. E’ veramente sorprendente l’attitudine degli adolescenti a captare e decifrare ciò che i familiari sussurrano. Nessuno me lo aveva mai apertamente spiegato, ma sapevo già che la moglie di don Michele, donna Elisa, era il frutto di un giovanile peccato del defunto zio Generoso, in effetti una prima cugina di papà.
La santità - l’avevo compreso - non era una virtù comune a tutti i vecchi Alfano. Sicuramente non era un attributo applicabile al prozio Generoso. Questo chiacchieratissimo (ma solo in famiglia, per il resto lodatissimo) zio morì quando io avevo appena tre anni. Fu il primo degli Alfano a fare la sua dipartita terrena da una stazione calabrese. Il nipote Genso preferiva non parlarne, in quanto, prima che morisse, avevano avuto forti dissapori. Invece ne parlava spesso la mamma, che tuttavia si ribellava persino all’idea di ricordarsene. Secondo lei si trattava d’un materialista senza fede, d’un massone incallito, d’un donnaiolo impenitente, d’un dissipatore senza affetti; nelle sue appassionate perorazioni, l’Animale. Come dire il Diavolo.
Ma in una famiglia di mercanti, questo era il meno; il più era l’accusa, che ella gli faceva, d’aver sprecato in amorazzi da trivio e scostumatezze innominabili il consistente, milionario patrimonio aziendale. Papà che, oltre a ripeterne il nome, ne era stato il discepolo e aveva imparato da lui tutto quel che sapeva del mestiere, taceva. Non tacevano, invece, i vecchi clienti, i bottegai della zona, il cui giudizio era assolutamente lusinghiero. A detta loro, nessuno lo eguagliava quanto a conoscenze merceologiche; nessuno sapeva pesarli meglio di lui,
57
che a colpo d’occhio distingueva il cliente buono dal cattivo. Nessuno, che loro conoscessero, sapeva tastare il polso al mercato con altrettanta sicurezza; cosa che negli affari, come tutti sanno, è una qualità decisiva; nessuno che sapesse, come lui, riconoscere la qualità di una partita d’olio solo dall’assaggio. Anche se, poi, tutti ammettevano che non difettava di “quella debolezza là”.
La mia posizione - ovviamente mai resa pubblica - era viziata d’immaturità. Infatti capivo perfettamente che gli uomini non sposati - persino i preti - hanno, di regola, delle mogli nascoste, dette amanti. Le quali invecchiano pure loro. E sapevo anche che, con il sopraggiungere della vecchiaia, il segreto cade, cosicché quelle che da giovani vengono chiamate amanti, da vecchie si collocano in una condizione incerta, tra la suocera e la cameriera.
Per esempio Assuntina, che ogni settimana veniva in negozio a fare la spesa, stava in casa con don Peppino Bianchi, il parroco di Sant’Eligio. Aveva quattro figli, che naturalmente Assuntina trattava da figli, e che anche don Peppino trattava da veri figli. Ma dal punto di vista della loro origine era come se fossero capitati in casa per virtù dello Spirito Santo. Quello che non mi quadrava era la circostanza particolare di zio Generoso, del quale si raccontava che, ormai vecchio e quasi ottantenne, nonché già titolare di un’anziana perpetua a nome donna Filomena, incettasse - e per giunta senza che donna Filomena si arrabbiasse - delle giovani amanti. La più importante delle quali era una signora che tutti chiamavano donna Jana, o anche ‘a Cavalera, essendo ella la vedova del Cavaliere Codispoti, e che in effetti si chiamava donna Diana Codispoti. Della cui esistenza ero pienamente al corrente e che, anzi, avevo qualche volta incontrato per strada.
A questa signora molto distinta, ma che secondo mia madre era,
58
invece, una gran sporcacciona, lo zio Generoso aveva lasciato il casino in usufrutto e una rendita, che papà doveva pagarle ogni mese.
Un’altra amante dello zio era stata la Zarina - al tempo una donna non più giovane, ma ancora bellissima: alta, distinta, prosperosa, coi capelli ramati. Una granduchessa si diceva, fuggita dalla Russia con un marinaio del paese al tempo della Rivoluzione. Adesso andava per le case a fare l’infermiera. Viveva con il figlio diciottenne, operaio all’officina Fiat e già considerato un meccanico di tutto rispetto. Insomma, zio Generoso - affermava la mamma - s’era mangiato un patrimonio con le donnacce.
Nonostante tutto questo, pare che quel vecchio scostumato mi adorasse. Ma doveva aver voluto bene anche a mio padre, se nel testamento l’aveva nominato erede universale. Che voleva dire - mi fu spiegato - d’ogni suo bene. Mammà, però, commentava: “Universale sì, ma delle sue vergogne”.
Senza esserne l’erede universale, anch’io avevo avuto dal prozio un lascito di centomila lire, come al solito in Buoni del Tesoro. Peraltro ho sempre sostenuto - con ciò suscitando lo scetticismo familiare - di ricordare lo zio in questo e quell’altro atteggiamento (fuori dall’harem, per fortuna). Comunque, ricordavo perfettamente Mister Free, che era stato il suo fedele cane da caccia e - molto tempo dopo capii – anche l’impotente protesta contro il fascismo; il quale Mister Free, si raccontava, morto il padrone, era venuto spontaneamente e immediatamente, neanche un cristiano, ad abitare da noi, anzi a dormire sul tappeto accanto al mio lettino d’infante, innervosendo oltremodo mia madre, che s’incaponiva a vedere nel cane l’anima scurrile del padrone.
Come l’altro prozio, Gabriele - fattosi frate non ho capito se per un obbligo familiare o per vocazione - il prozio Generoso era stato
59
condannato al celibato dalle ferree leggi della primogenitura. Ma egli, uomo molto vitale, espansivo, sommamente piacente e parecchio considerato presso il bel sesso, aveva avuto più avventure di quel che dio comanda. Una era stata con una certa donna Giustina, moglie di un daziere napoletano, dalla quale era nata donna Elisa che, rimasta precocemente orfana del padre putativo, seppe del vero padre quando questi volle che crescesse lontano dalla madre, in un convitto di suore, da dove era uscita soltanto al momento del matrimonio.
Evidentemente il prozio aveva molta più stima del marito cornificato che della propria amante.
Mio padre era affezionato a questa sua cugina spuria; una donna, al tempo del racconto, tra i quaranta e i quarantacinque anni, parecchio attraente. E i rapporti che intratteneva con lei e con suo marito erano franchi e familiari.
Diviso tra un’acerba attenzione per Iole, figliola dei predetti don Michele e donna Elisa, e quella per il pollo con le patate fritte, m’ero completamente dimenticato dei fasti e dei nefasti degli Alfano. Ma a richiamarmi sul terreno delle ubbie familiari fu proprio l’ignaro don Michele, il quale, da mite trattore, era preoccupato circa un mussoliniano e autarchico razionamento dell’olio e di altre derrate, di cui si sentiva già parlare.
“A te i soldi non mancano”, diceva rivolto a papà. “In Calabria l’olio c’è. Perché non riprendi l’antica attività?”
Mi resi conto che quel tasto solleticava papà, tuttavia egli si schernì. - “Ah Miché, si’ pazzo? I soldi miei, il mio lavoro di quindici anni e tutto quello che mi è venuto dalla famiglia è scritto a libro ... L’olio? Ma per carità… Ci vorrebbero decine e decine di milioni... Non sono più i tempi di una volta ... E poi dovrei pure fare la guerra a Genova…
60
I genovesi tu li conosci...Per una lira, che sia una sola lira ... Anche peggio i lucchesi ... ”
“Ma come avete fatto? ... Gente seria, che la fortuna non se l’è giocata a carte.. E tenevate pure una banca...!”
Eravamo al grande rebus familiare. Da una parte le note accuse al prozio Generoso, dall’altra, addirittura, la chiamata in causa di Patreppaolo; sullo sfondo, con un ruolo nebuloso, la possente e luciferina figura dell’onorevole Surrenti, il cognato dei vecchi Alfano, il marito di zia Minicuccia, lo zio disconosciuto, del quale in famiglia non si poteva neppure fare il nome.
A questo punto ebbi paura. “Se papà vorrà scagionare il nonno, non potrà tacere le scostumatezze di zio Generoso”, pensai.
Chi era il vero colpevole? Volevo molto bene al nonno, l’uomo più giusto e buono che avessi conosciuto nella mia giovane vita. Una sua condanna mi avrebbe addolorato. Però la giustizia storica non è un sentimento elastico. Anche il prozio Generoso - nonostante le affermazioni di mamma - aveva diritto a un deferente ricordo, come membro della famiglia e parte della Ditta.
Al centro di tutto c’era la Banca, che non avevo ancora ben capito se il governo aveva chiuso d’autorità, e perché. Di quale delitto, di quale indegnità s’erano macchiati il nonno oppure zio Generoso oppure l’innominabile zio Ferdinando? La gente stimava ancora e rispettava la memoria di zio Generoso, nonostante le sue scostumatezze. Nessuno invece diceva una sola parola di bene su zio Ferdinando. Sicuramente il colpevole era lui, ma cosa mai aveva combinato? E dei suicidi che c’erano stati, chi era il colpevole?
Dopo la morte del nonno, l’Alfano in capo era papà. A lui spettava il verdetto. 61
“La guerra?... La morte di mio fratello?...
“Non solo la guerra, caro Michele. Anzi, durante le guerre il commerciante disonesto s’arricchisce, quello onesto non perisce ... No, stammi a sentire ... La cosa è molto più vecchia, risale al tempo che ancora non era nato mio fratello Gioacchino. E’ da quarant’anni che la famiglia Alfano è sottoposta al martirio senza essere colpevole di niente...Non te la posso spiegare come si dovrebbe ... In questa storia dell’olio e della banca c’è una verità che mi sono impegnato a non dire fino a quando...”
“Fino a quando?”, chiese donna Elisa. Ma papà non le rispose.“Credi a me, Michele ... Rifletti. Era mai possibile che gli amalfitani cadessero tutti assieme? Nisciuno che si salvasse? ... E che! Erano diventati tutti minchioni?
“Non solo gli Alfano, ma i Cuomo, i Proto, i Gargano, i Lucibello, i Pagliaro, i Panza, i Savo ... tutti fessi? Il meglio della Costiera. Gente che navigava da mille anni, che ha tenuto banche, industrie, navi ... che ha combattuto contro i normanni e i saraceni... Mercanti, banchieri, capitani, ammiragli, consoli, dogi ... Dovunque, a Costantinopoli, ad Alessandria, a Beirut, a Tunisi ... All’improvviso tutti fessi. Persone esperte, famiglie millenarie, che all’improvviso si fanno mettere nel sacco! ... Insomma, ti pare? ... ”
Donna Elisa annuiva. Forse, per un attimo poté pensare che gli Alfano, tornati milionari, sarebbero stati generosi con lei, che pure Alfano era, anche se non ne portava il cognome; con lei che - lo si vedeva - amava tanto vestirsi bene e ingioiellarsi. Sicuramente maggiori larghezze non le sarebbero dispiaciute.
“I cugini Conforti vanno dicendo che sarebbe stato mio padre il colpevole di quella perdita. Ma se ciò fosse vero, avremmo almeno
62
otto colpevoli. (Rivolto a donna Elisa) Questo me l’ha insegnato tuo padre: otto erano le ditte che controllavano tutto l’olio calabrese, due sorrentine e sei amalfitane ... Tutte sconfitte allo stesso momento? ... Un solo fulmine?
“No, è troppo semplice buttare tutta la colpa su mio padre. Invece la cosa non è così semplice ... No, è stata tutta una questione di banche. Prima di tutto la Banca che revoca il conto corrente. E già questo non si spiega. Era la banca più ricca, l’unica sicura in quel periodo di scandali... Noi abbiamo la nostra banca, bene o male si tira avanti anche senza l’aiuto della Banca. Ma il governo...Insomma, la dobbiamo vendere. Poi, quando i prezzi crollano, arrivano i genovesi pieni di soldi. Pur d’incassare, i proprietari vendono l’olio già impegnato... Ma come te lo spieghi tutto questo?... Te lo spieghi dopo, quando ci sono i morti…
“Bah, lasciamo stare...Ci sono i ragazzini...”
Era la prima volta che vedevo papà accalorarsi. Ma subito si riprese. “No, Michele, io il pollo fritto non lo voglio. Tu mi devi fare un piatto di maccheroni con la besciamella e la noce moscata, come tu solo sai fare.”
Allorché, dopo pranzo, uscimmo per una passeggiata, volle che andassimo al porto. Cercò d’indicarmi il posto dove, qualche decennio prima che lui nascesse, stazionavano le botti d’olio calabrese in attesa d’essere reimbarcate sui velieri da mille tonnellate che facevano rotta per Liverpool, Anversa, Oslo, Boston. Ma l’impresa non gli riuscì.
63<>64
Con la morte del nonno finirono le mie coccolate estati capursine. Tornai in servizio attivo fra i compagni della ruga per undici mesi all’anno. Il dodicesimo dovevo dedicarlo ai miei cugini saluzzesi, il cui arrivo divenne un forte disturbo per la mia serenità. Zio Filiberto, più che un piemontese, sembrava un napoletano allegro e sfotticchiante. Coloro che l’avevano conosciuto negli anni in cui era stato pretore a San Policarpio raccontavano mille aneddoti sul suo modo di insaporire le udienze con battute pizzicanti all’indirizzo degli avvocati e specialmente del povero cancelliere Cavallaro che, a causa di quell’irrefrenabile cascata di punzecchiature, si fece la fama d’ignorante e pasticcione.
Anche adesso che a San Policarpio trascorreva soltanto un mese, intorno a lui, sulla spiaggia, si raggruppavano i bagnanti più pettegoli, chiacchieroni e allegri. Ricordo tutte quelle persone, tuttavia, ai fini del racconto, basterà citare l’onorevole Carlo Aversano, anche lui forestiero e anche lui ritualmente presente in paese nei mesi estivi.
L’Onorevole era il padre di Norina, la moglie di Totò Surrenti, primo cugino di mio padre, in quanto figlio di zia Minicuccia, sorella di mio nonno. Papà e Totò si detestavano. Quando il caso voleva che s’incontrassero, si salutavano appena. Era un’inimicizia antica, che pareva toccasse solo i maschi delle due famiglie. Infatti, se anche la mamma si teneva alla larga da Totò, non lo faceva tanto per essere solidale con papà, quanto perché dava credito a quello che tutti dicevano, e cioè che Totò e suo padre fossero dei jettatori.
Per il resto, tra le due famiglie, i rapporti erano quelli consueti fra parenti che non si frequentano. Da parte loro gli Alfano divenivano affettuosi e reverenti soltanto con zia Minicuccia, una vecchia signora,
65
buona e dolce, la quale soffriva molto per la ruggine esistente fra il marito e il fratello. Anche con Norina la freddezza era visibile, ma non derivava dai rancori pregressi. Norina era una donna precocemente appassita e stanca. Era anche lei avvocato, come il marito, il padre e il suocero, ma pare si limitasse ad aiutare nello studio. Si sussurrava che, per il fatto d’essere donna, il marito e il suocero non le permettessero d’andare in tribunale. Si sussurrava anche che l’onorevole Aversano e sua moglie, pur avendo altri figli, venissero a San Policarpio tutte le volte che potevano per starle vicino.
Personalmente, se la vedevo profilarsi all’orizzonte stradale, svicolavo con decisione. E non perché Norina fosse cattiva. Tutt’altro, era molto affettuosa con me. Solo che, alla fine dell’incontro, invariabilmente commentava: “Io non riesco a capire perché ti lascino crescere come un selvaggio”. E a me, l’idea di somigliare a uno con la cintura di foglie intorno alla vita e l’orecchino al naso, non mi andava giù. Comunque, mi avevano insegnato a essere discreto, e io quel commento, che avrebbe potuto essere causa di altri litigi, non lo riferivo a casa.
L’Onorevole, che era l’amico balneare di zio Filiberto, passava per essere un sovversivo, un nemico del fascismo, però in paese tutti ne avevano rispetto e deferenza, in quanto era un grande avvocato di Cassazione. Quando lui e la moglie venivano in paese, con loro veniva anche Vitulia, al tempo detta Lia, che viveva a Roma con loro. Vitulia era la terza e ultima figlia di Totò e Norina, che avevano anche due figli maschi. Vitulia era un nome strano e anche unico. Era lei stessa a spiegare che era l’antico nome della penisola italiana. Non frequentavo questi cugini. Appartenevamo a due mondi diversi. Loro erano dei signorini, mentre io crescevo in compagnia della più temuta monelleria
66
paesana. Se il caso o le ritualità ci facevano incontrare, ci scambiavamo un bacio sulle guance, e finiva lì. Un po’ meglio andavano le cose con Vitulia, che era la sola a venire a mare con il nonno, e quindi a fare il bagno con me e con i miei cuginetti piemontesi.
Meglio, ma poi non tanto. Infatti, sebbene fosse molto socievole, aveva un fare cittadino che l’accomunava ai miei cugini. Non sembrava una ragazzina, ma una persona adulta, o anche un maschietto. Parlava sciò-sciò, vestiva in modo elegante, s’interessava a cose alle quali io mai avrei pensato. Ad esempio, se Charlot fosse un grande artista, un maestro del cinema, quasi che nel cinema ci fossero maestri, o che la comicità di Charlot potesse essere paragonata a quella di Angelo Musco.
E tuttavia, quanto meno all’ora del bagno, me la dovevo sorbire. Ma era il meno. Il peggio era che dovevo sorbirmi per l’intera giornata mio cugino Enea e mia cugina Lucilla, i figli di zio Filiberto e di zia Giuditta, la sorella di mamma. A tal riguardo mamma e papà mi avevano severamente richiamato: “Sono nostri ospiti. Quando noi siamo assenti, devi fare gli onori di casa. Devi farli sentire a loro agio, farli divertire secondo la loro idea di divertimento e non secondo la tua. Loro con i sassi e le fionde non ci sanno fare, né devi provocarli con le gare di nuoto perché rischiano d’affogare… Metti i soldi in tasca… Qui nel taschino, in modo che non li perdi. Offri un’orzata, un gelatino … ”
Avevo perfettamente capito il discorso e cercavo di conformarmi il meglio che potevo, anche se poi loro – cioè Enea, Lucilla e Lia – ne approfittavano pesantemente, trattandomi da paesano e facendomi il verso per il mio italiano approssimativo. La mia ignoranza divertiva anche zio Filiberto, il quale, però, se ne preoccupava e diceva a papà
67
la stessa cosa che Norina diceva a me: “Genso, dovresti avere più cura della sua istruzione…”
Al che papà rispondeva: “Chi nasce tunno no pò morì chiatto. E’ nato calabrese, e calabrese morirà. D’altra parte ne sa già troppo. Sa già come si compila una fattura, sa controllare le rimanenze in magazzino. La sera, quando chiudo la cassa, mi aiuta a fare i torchietti di moneta … Lo mando in banca a pagare qualche tratta. Che vuoi di più? L’italiano l’imparerà quando andrà in Italia …”
Invece, non mi sfotteva mai l’Onorevole. Aveva una gran simpatia per me, e a causa mia litigava con zio Filiberto. Capiva che stavo con i cugini in ossequio a un dovere, e questo gli bastava per ritenermi un ragazzino maturo. Lo entusiasmava, poi, che io sapessi nuotare con la disinvoltura di un uomo fatto e che non avessi la minima paura di allontanarmi dalla riva. Gli piaceva che i pescatori mi conoscessero e mi trattassero come se fossi uno dei loro ragazzi. Apprezzava che io non recalcitrassi a correre sino al chiosco in piazza, a sua richiesta, per riempire d’acqua fresca la bottiglia.
Affermava che io ero vivo e che i miei cugini erano già tre mummie, capaci solo di sputare sentenze. Gli dispiaceva solo un fatto: che quando mi chiedeva “Ti piace Mussolini?”, io rispondessi: “Sì, Onorevole”. Allora lui si rannuvolava e mormorava qualcosa d’incomprensibile.
Un anno dopo l’altro, i nostri corpi crebbero. Enea, Lucilla e Vitulia cambiarono aspetto. E crescendo ebbero sempre più bisogno della mia precocità marinara. Un giorno che mutò tempo all’improvviso e arrivò un forte vento di ponente, mi toccò aiutare tutti e tre a non bere, e far loro coraggio finché non arrivò una barca a trarci d’impiccio.
Con gli anni la barca divenne la grande attrattiva. I pescatori non
68
avevano difficoltà a prestarmi un cianciolo, con il quale li portavo lontano dalla riva, a godersi il silenzio cantante del mare.
Poi venne la guerra, zio Filibertò fu richiamato, e ci perdemmo di vista.
*
Il palazzo dei Surrenti si affacciava sul corso, come quello di tutti i gnuri. Erano costoro i padroni degli uliveti e in genere delle terre collinari che serravano il paese a monte. Le famiglie veramente ricche erano pochissime; le altre lo erano state nei decenni precedenti. Ben lo si intuiva, perché tenevano superstiti atteggiamenti padronali e le finestre orbe di vita, negli aviti palazzi.
Nel ristretto gruppo dei più ricchi, le donne avevano ricevuto un’accurata educazione ai bei modi: le più vecchie nei collegi napoletani, le giovani, o meno vecchie, in quelli fiorentini e romani. Le nobildonne uscivano di casa soltanto per recarsi dai parenti, mai a passeggiare come le comuni mortali. Non era ancora venuta l’abitudine d’impiegare la macchina sui brevi tragitti, così che esse usavano le gambe come chiunque. Bisogna aggiungere: fortuna nostra, in quanto il loro passaggio era un colpo di teatro. Sempre eleganti, così da apparire belle anche quando non lo erano; sempre vestite alla moda - cosa che si percepiva più che sapersi - e delicatamente profumate.
Siccome erano conosciute, il loro avvicinarsi era preavvertito da un’ondata di cappelli maschili che riverivano e dagli spazi che si aprivano per lasciare loro il passo.
L’aristocrazia paesana non era sicuramente fatta di famiglie autenticamente nobili e dal risonante casato; apparteneva invece a quel padronato rurale che aveva approfittato dell’eversione dei feudi e che si era arricchito con l’appropriazione di terre demaniali. Dacché il
69
treno aveva reso la provincia meno lontana dalla capitale, i gnuri potevano raggiungerla facilmente e permanervi. Così avevano imparato la lingua, i modi e gli atteggiamenti dei gran signori. Non dico soltanto quelli epidermici, ma propriamente la distinzione.
I maschi, di regola, possedevano una laurea - avvocati, medici, qualche ingegnere - ma non esercitavano la professione, quantomeno in paese, mentre qualcuno di loro lo faceva a Roma. Né esercitavano professionalmente l’attività di agricoltori, tranne uno che aveva piantato un grande agrumeto. Delle loro terre, che non erano dei latifondi, ma un certo numero (a volte parecchie decine) di fondi piccoli e medi, si occupavano soltanto nei mesi in cui si raccoglievano le olive e i trappeti erano in attività. Allora lasciavano il palazzo, in paese, e andavano a soggiornare nella villa di campagna.
I figli crescevano e studiavano a Roma: chi in convitto, chi abitando un appartamento che la famiglia aveva comprato a tale scopo, nonché per avere un piede a terra per le vacanze capitoline, o in occasione di viaggi per l’acquisto di toilettes, e per ogni problema di salute.
La recente e insolita origine mercantile del paese portava a considerare come dei forestieri gli appartenenti al gruppo aristocratico e proprietario. In effetti i gnuri erano arrivati già ricchi dai paesi collinari, per godere delle maggiori comodità viarie che le marine presentavano. Ed erano veramente come dei forestieri, con abitudini diverse e poco inseriti nella vita locale, con la quale entravano in contatto mercé la mediazione di chi stava su un gradino più basso, come i professionisti e i medi e piccoli padroni di agrumeti, le cui case, palazzi e palazzine erano di minor tono e non sempre avevano trovato spazio sul dorso.
*
A quel tempo il nostro Corso, spazioso e lungo come il corso di
70
qualunque marina jonica, mostrava un tratto più frequentato dal passeggio, più ricco di vetrine e di caffè, con i tavoli all’aperto e le larghe tende che riparavano dal sole; uno spazio che noi indicavamo con l’espressione “al centro”. Su quei trecento metri di quotidiano svago i fratelli Bova avevano aperto un negozio di radio, grammofoni, dischi e quant’altro di moderno e avveniristico si potesse desiderare. In quanto commercianti moderni, essi credevano nella pubblicità e, volendosela fare, avevano istallato nell’arco dell’ottocentesca e smisurata porta del loro negozio due enormi e potenti trombe acustiche, una volta a sud e l’altra a nord. Collegate a un giradischi, le predette ci somministravano, durante le ore più consone al passeggio, un repertorio di musica leggera. Non credo che amassero particolarmente il duce e il fascismo, anzi, in quanto massoni, credo che non li amassero per nulla. Tuttavia il loro programma pubblicitario quotidiano non escludeva il Giornale Radio, e non escludeva, soprattutto, i discorsi del duce, i quali venivano solitamente annunziati con qualche anticipo, al fine di suscitare l’attenzione popolare.
In tali circostanze, sul marciapiede di fronte si formava un gruppo di persone, che potevano divenire un centinaio e più,se il discorso veniva trasmesso verso l’imbrunire, allorché il lavoro aveva avuto termine. Siccome Mussolini era un oratore brillante e abile, in un’epoca in cui le rappresentazioni teatrali erano scarse, i suoi discorsi costituivano uno svago. E siccome, poi, a quel tempo il possesso di una radio era solo di pochi, la gente si affollava dove venivano amplificati.
Ascoltando il duce, gli “itagliani” non sempre capivano tutto, e qualche volta non capivano niente, ma provavano egualmente un’emozione teatrale, un moto simile a quello che si prova ascoltando Marlon Brando nelle vesti di Marcantonio che commemora Cesare, o Vittorio
71
Gassman, che conciona e sragiona nelle vesti di Brancaleone, cavaliere crociato di branca e leon.
Non so perché - e solo ora me lo chiedo - la sera del 10 giugno 1940, mio padre non salì in casa ad ascoltare l’annunziato discorso. Si diresse invece al centro. Io lo seguii. La guerra era quasi certa, ed era anche quasi certo che quella sera Mussolini l’avrebbe annunciata. Questa volta la posta era alta, e la gente raccolta lì avrebbe preferito che lo spettacolo non ci fosse. Ci sorreggeva un solo filo di speranza. La Francia era vinta e piegata. Hitler, trionfante, non aveva certamente bisogno d’aiuto e sostegno. Mussolini, sapevamo, era un giocatore. E siccome voleva soltanto sedersi al tavolo dove i vincitori si sarebbero spartite le spoglie dei vinti, ci chiedevamo se veramente avesse già deciso di passare al gioco della guerra o avrebbe continuato il gioco non cruento che stava conducendo da quasi un anno.
Sul marciapiede di fronte al negozio dei Bova eravamo un centinaio di persone. Stavamo muti e pensierosi. Persino gli amici intimi s’ignoravano l’un l’altro. Appena squillò la prima parola del Duce, mio padre mi prese per mano. Il gesto era inconsueto. I quattordici anni di allora non avevano niente in comune con i quattordici anni di oggi. Certo portavo ancora i pantaloncini corti e ancora non conoscevo l’altro sesso, ma il cuore si era già formato. Dalla mano di mio padre passò alla mia una vibrazione carica di elettricità, simile a quelle che avvertivo quando, anni prima, mi prendeva per mano il nonno.
La mia reazione fu una domanda a me stesso: “Se lui muore in guerra, io ce la farò?...” Sottinteso a essere l’uomo su cui la famiglia potrà fare assegnamento. Una nube di pianto mi velò la mente e gli occhi. Mio padre non lo volevo perdere.
*72
I soldati arrivarono appena qualche giorno dopo. Erano più di mille e nel volgere di appena qualche ora il paese divenne un’appendice di Vicenza e di Ferrara, con qualche insaporitura di Salerno e Avellino. Il primo effetto fu che tutte le botti, sia quelle già spillate, sia quelle che i bettolieri tenevano di riserva, furono vuotate in men che non si dica. Sull’onda della nuova e imprevista domanda di consumo, il paese, da esportatore di vino che era, dovette importarlo. Qualcuno previde che sarebbero scomparsi anche, e in breve tempo, i cani, i gatti, i topi e persino le rane dallo stagno du Fegu Vecchiu. Ma a voler essere onesti, non mi pare che tale evento si sia verificato.
Sopraffatte dal numero dei maschi e dalla forestiera attenzione, le donne del paese cominciarono a vibrare. Siccome era già estate, nelle rughe esse sedevano dinanzi alla porta di casa, formando con le vicine ampi cerchi. I soldati si accostavano, e dovunque erano gran risate a gratificare il loro incomprensibile eloquio. Subito dopo, forse a colmare le diversità dialettali, cominciavano a venire fuori chitarre, mandolini, fisarmoniche, e la notte oscura si riempiva di suoni, di cori e d’allegria.
Non credo che la fraternizzazione andasse oltre. I padri, i mariti, i fratelli erano alquanto reattivi sul punto dell’onore. Un po’ di musica non lo comprometteva; andare oltre era vietato dal costume. In verità, la canzone fu per tutti noi la compagna degli anni di guerra; la melodica consolatrice dei pensieri amari, che sopraggiungevano con il buio dell’oscuramento totale. Ancora una volta ogni famiglia aveva uno dei suoi al fronte, anzi su uno dei fronti che il duce, nella sua infinita follia, andava aprendo. E non esisteva altro miele per la paura, la nostalgia, l’angoscia, la noia delle sere vuote, che la canzone.
A livello popolare, la guerra, l’oscuramento, la povertà alimentare, i
73
sacrifici duri che la gente era costretta a fare, la paura fisica per sé stessi e per i congiunti lontani - anzi irraggiungibili, perché spediti dal duce poco retoricamente al di là dei monti e dei mari, in Africa, in Russia, in Jugoslavia, da dove non arrivavano altre notizie se non di disagi e di morte - si accompagnarono a una certa qual sospensione delle chiusure familiari; un qualcosa che somigliava parecchio all’umana solidarietà. E ciò, forse, poté servire ad alleviare le sofferenze.
Il sentimento del comune pericolo - che fra il popolo si elevava a melanconia collettiva - a un livello più alto, cioè fra i gnuri, approdò invece, e di botto, all’empireo delle frivolezze. Con i militari di truppa, erano giunti in paese una settantina di ufficiali, anch’essi della riserva. A costoro - o meglio, a causa loro o per loro merito - l’aristocrazia paesana spalancò i suoi riservati e serici salotti.
Tranne i cinque o sei ufficiali di marina addetti al treno armato, gli altri erano persone provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; uomini infilati in una divisa dopo decenni di congedo illimitato; attempati padri di famiglia costretti a piantare in asso i propri affari, a lasciare la moglie e i figli, a separarsi dalla vestaglia e dalle pantofole. Per parecchi la divisa ebbe l’effetto di una mutazione dei connotati fisici e morali. L’assicuratore Sarti, divenuto il colonnello Sarti, non ragionava più di contratti e di premi, ma pareva potesse dare l’anima per la baronessa Lo Vecchio. Il ragionier Bussoni di Canneto Po, adesso l’azzimato e marziale tenente Bussoni, pendeva dalle labbra della signora Perez. L’avvocato Golini aveva l’occhio attento alle cameriere. A tali ricevimenti veniva invitata anche la mia famiglia, ed essa stessa dovette darne qualcuno. La cosa contrariava sia mia madre, che provava disagio a scimmiottare le gran dame (ma neppure intendeva offenderle) sia mio padre, che avvertiva un gran fastidio a
74
mettersi al fatuo livello dei nobilucci. Ma si era di fronte a un dovere d’ospitalità, oltre che a un dovere patriottico. Quando passai ai pantaloni lunghi, a tali mondanità dovetti partecipare anch’io - mi fu detto - onde esercitarmi sanamente a rispettare le convenienze sociali.
*
La guerra, fra tutte le altre cose, fu anche un impoverimento della vanità. Tutti vestivamo alla meno peggio, specialmente i ragazzi. Io ero cresciuto. Bisognava rivestirmi e dotarmi di pantaloni lunghi. Ma stoffa di vera lana non se ne trovava più. Nacque una diatriba tra la mamma, che voleva far rivoltare un vestito buono di papà, e papà, che si rifiutava energicamente di sacrificarlo. Così venne in ballo un mantello che quindici o venti anni prima il nonno, arrivato a San Policarpio, che ancora faceva freddo, e ripartito per la Costiera che già era caldo estivo, aveva dimenticato. I familiari che erano sul punto di prendere il treno per Capursi, invariabilmente, promettevano di riportarlo al suo proprietario, ma poi, al momento della partenza, per un motivo o per l’altro non lo facevano.
Il mantello aveva sì viaggiato, ma solo da un armadio all’altro e da una cassa all’altra. Peraltro, nessuno che non fosse nato prima della presa di Roma indossava più un simile indumento, ma nessuno aveva il coraggio di dar via un capo fine, confezionato in caldissimo loden e recante l’etichetta in indecifrabili caratteri gotici di un famoso magazzino della Vienna belle époque. Poi, la morte del nonno aveva concluso l’angosciante dilemma. Il mantello poteva rimanere a San Policarpio: non usato da alcuno, e tuttavia destinato a una futura e imprevedibile utilità. La quale sopraggiunse.
Siccome, per raggiungere la scuola, facevo in bicicletta cinque chilometri all’andata e cinque al ritorno, quel panno caldo - sosteneva
75
papà – faceva proprio al caso. Dal canto mio, inorridito da quel pelo dal colore incerto, dichiarai fermamente che a scuola ci sarei andato magari in canottiera, giammai vestito da Gengis Khan. Ma s’intromise la nonna con un discorso dal sapore spinoziano.
“Per cinquant’anni, tutte le volte che il freddo era più del solito, Paolo metteva questo ferraiolo. Fu nel 1891, doveva andare a Trieste per vendere l’olio, e io volevo andare a Padova a pregare Sant’Antonio che ci facesse la grazia di un figlio. E Sant’Antonio la grazia ce la fece. L’anno dopo nacque Gioacchino, e appresso Anita e poi Generoso.
“Ormai c’era il treno. Da Salerno andammo a Roma. Così vidi la nuova capitale. Il viaggio di nozze l’avevamo fatto in Sicilia e non conoscevo Roma. Una città molto antica, quieta e tranquilla. Anche Bologna e Padova sono paesi antichi. Per le strade gira poca gente, tutti avvolti in tabarri scuri. Fa molto freddo… I palazzi sono piccoli. Case di signori, antiche, molto antiche… forse dei tempi di Dante. Però sono pulite. La gente è pulita, buona e gentile, ma non li capivo… Loro capivano me, e io loro no…Parlano stretto…Solo il mangiare!…Sempre carne…Mattina e sera carne, non ce la facevo più!
“Da Venezia a Trieste andammo per mare… Trieste…! Potevo mai immaginare che mio figlio…! Il Signore, nella sua misericordia, ci condoni i nostri peccati… Lì Paolo era molto conosciuto. Persino le guardie. Il capitano non volle vedere neppure il mio passaporto, e mi baciò la mano… Andavamo in una trattoria che sapeva cucinare napoletano.…Le donne sono bellissime…alte, robuste, chiacchierone.
“A Trieste non facemmo buoni affari, cosi Paolo decise d’andare a Vienna.
“Fu li che Paolo comprò il ferraiolo…Faceva freddo, era un ghiaccio…però nella stanza c’era il caminetto. Paolo mi comprò una
76
pelliccia di volpe, che poi la regalai a mia sorella Rosina che stava a Chiunsi… Vienna è grande, più grande di Napoli. I palazzi sono nuovi, grandi, le vie larghe. Allora c’era l’imperatore. Le persone erano vestite da signori. Le strade erano pulite come un piatto strofinato con la cenere e il limone. Paolo riuscì a vendere una parte dell’olio. Un affare senza guadagno, ma senza perderci. Il guadagno era di venderlo, perché ormai a Trieste non ne volevano più.
“Da Vienna andammo a Praga, sempre in treno. Un treno veramente comodo. E lì riuscimmo a vendere il rimanente, più cinquecento quintali di olio lampante, a un buon prezzo. Lo comprò il padrone di una fabbrica, un gran signore che parlava benissimo l’italiano…Gentilissimo, voleva persino invitarci a un ricevimento, solo che non avevamo gli abiti per l’occasione.
“Il ferraiolo è un ricordo di Paolo, ma il vero ricordo di Paolo io ce l’ho nel cuore ogni minuto della mia vita… nell’anima che nostro Signore ciha dato… Gli altri non possono avere lo stesso ricordo. Se Paolino s’aggiusta il ferraiolo, ricorderà il nonno a ogni momento…Solo prego Dio che la guerra ci risparmi quello che ho visto nel 1918”.
In verità, indossando, dopo anni di mussoliniane e orbaciche tessiture, una lana di qualità superiore, al primo impatto il nuovo vestito mi sembrò il meglio che ci potesse essere, una roba divina. Anche il sarto aveva fatto un lavoro eccellente. Ma poi amici e compagni di scuola mi riportarono con i piedi nel mondo. Ve lo immaginate voi un ragazzo già sviluppato, o per meglio dire un giovanotto, con indosso un abito che, se il cielo è coperto, può sembrare sia marrone sia grigio, ma anche verde, e che visto in pieno sole assume la tonalità “cammello in corsa”, o per maggior chiarezza, color giallo cacca, quello stesso che
77
pare avesse il cavallo con cui d’Artagnan parte per le sue avventure? Per di più, un indumento peloso come un gatto girovago, che ricordava il Maresciallo Radetzki e le Guerre d’Indipendenza? Messi di fronte a quel capo d’abbigliamento, l’attenzione più graziosa che gli amici presero a rivolgermi suonava così: ”Maresciallo, le nostre armate hanno già scaldato l’Oglio e stanno per soffriggere il Micino...”
Per compiacere la mamma e dimostrarle che non ero lo scugnizzo di strada che lei sosteneva, avevo già partecipato a tre o quattro ricevimenti. Ma, trascorrendo la mia giovane esistenza tra una scuola burbera, uno scrittoio solitario di fronte al mare vuoto, un campetto di calcio tutto buche e pozzanghere, una bicicletta che pesava 25 chili, il bigliardo, la strada e i ragazzi del basso popolo con i quali passavo le ore di svago, non avevo alcuna dimestichezza con i figghi di gnuri. Né loro l’avevano con me. Io, sospettoso della loro boria, loro, forse memori delle sassate intercorse soltanto qualche anno prima, e comunque trattenuti dal mio impaccio, il dialogo mancava. Così, chiuso nel mio abito color cammello in corsa, anche quella sera me ne stavo muto e solitario, appoggiando le spalle contro lo stipite di una porta, a fare tappezzeria. Quando...
Quando i miei occhi incrociarono lo sguardo curioso e divertito di Vitulia Surrenti, che ballava un valzer con Donato Muscari. La salutai alzando una mano ritrosa, con due sole dita aperte. Era bella, bellissima, ma certamente la cosa si sarebbe esaurita in un po’ d’invidia per Donato, che la teneva fra le braccia, se, terminato il ballo, lei non mi si fosse parata davanti ridacchiando, senza per nulla dissimulare che la causa del suo spasso era costituita dal mio vestito.
“Mai visto un vestito così bello. Dove l’hai comprato?”
Naturalmente mi feci di brace. Avrei voluto rintuzzare il dileggio,
78
ma non seppi trovare il calibro giusto per una risposta. Il cervello mi era andato in tilt, la lingua mi si era legata al palato. Non la vedevo da qualche anno. L’essere che rideva di me, di fronte a me, pur essendo sicuramente Lia, non era più Lia. Era un’ammutolente bella signorina, fresca ed elegante. Insomma la Deanne Durbin che un ragazzo di allora sognava.
Già la qualità supersudtirolese del loden che indossavo aveva cominciato a mettere a disagio le mie ghiandole sudorifere, adesso la risata divertita di Vitulia, e più ancora la posizione, che inopinatamente lei assumeva, di giudice, mi spensero la ragione. Quando, sempre sorridente, mi sfiorò la guancia per il rituale scambio di baci, mi sentii percorrere tutte le membra da un’ebbrezza mai provata, da una sensazione travolgente.
Eppure c’è qualcosa più potente dell’amore, ed è - non so come chiamarla - la stupidità, l’ipocrisia, la soggezione alle mere apparenze. Comunque, cose che mi portarono a fare la faccia da ebete, proprio mentre avrei voluto chiedere alla superiore volontà che regge il mondo di farmela accarezzare ancora, d’inchiodarla lì, in modo che lei parlasse solo e sempre con me.
“Vieni, balliamo.”
“Non so ballare.”
“E’ facile. Su, vieni, t’insegno io”.
Questa volta il sudore prese a scendermi a rivoli lungo la schiena. M’insudiciava la fronte, le guance e il collo. La camicia e la cravatta mi strozzavano.
Poi, quello zampettare senza estasi né gioia - qual è il ballo per chi non sa ballare - stancò Vitulia e mortificò me. “Lasciamo stare”, dissi e me ne andai in giardino a incontrare me stesso. E lì compresi finalmen
79
te cosa volesse significare il nonno allorché mi diceva: “Non mischiare mai il loro sangue con il tuo”.
*
L’inimicizia, appena dissimulata dalle formalità in uso fra parenti, la profonda avversione che correva tra gli Alfano e i Surrenti aveva le sue radici in fatti lontani nel tempo, lo si sapeva bene. Molto più difficile era appurarne le vere cause. Queste stavano in una nube tossica che aleggiava intorno alla figura di zio Ferdinando. La nube si vedeva a occhio nudo; cosa ci fosse oltre era invece confuso, anzi misterioso. Un mistero che doveva esistere obbligatoriamente, per non addolorare ulteriormente zia Minicuccia.
Quando la incontravo, le baciavo la mano reverente e affettuoso. Lei, altrettanto affettuosamente, mi chiedeva di tutti. Avute le notizie, si metteva a scuotere la testa. Poi, appena la prima lacrima le imperlava le pupille, si allontanava senza dire altro. Con il temuto zio Ferdinando, nel corso dei miei sedici anni d’esistenza, avevo sì e no scambiato soltanto qualche parola. Peraltro, la sua vecchiaia non somigliava alla vitale vecchiaia dei miei nonni. Si diceva in giro che la sua diabolica intelligenza funzionasse ancora alla perfezione, ma si vedeva che le gambe lo reggevano male, i suoi pantaloni erano sempre umidi davanti. In effetti usciva di rado e sempre in macchina.
Invece, nell’andare a scuola incontravo spesso suo figlio Totò, in quella fase bellica, anche lui costretto a pedalare su una vecchia bicicletta per recarsi a Sottovento, in tribunale.
‘U Siccia, questo era il nomignolo con cui la gente lo indicava, era un avvocato che sembrava già maturo. Aveva soltanto qualche anno più di papà, ma sembrava un cinquantenne. Come professionista era
80
ben considerato, però si diceva che non avesse molti clienti. E non tanto per il fatto che fosse antifascista (la gente se ne fregava di simili preclusioni, si deve dire anzi che per un avvocato l’essere antifascista era la prova di una personale indipendenza verso la legge, dalla quale i privati dovevano appunto difendersi) quanto, piuttosto, per il fatto che la gente lo riteneva un jettatore. Cosicché cautamente lo emarginava. Quando lo si vedeva spuntare, invariabilmente qualcuno esclamava: “Mò ‘a siccia ti tingi”. I più toccavano ferro e chi poteva se ne stava alla larga.
Invece a me Totò era simpatico. Il giudizio del paese mi sembrava ingiusto e cattivo. Si sapeva che non era ricco. In altri tempi, l’Onorevole aveva dato fondo al patrimonio familiare per spesare le sue costose permanenze romane e le ricorrenti campagne elettorali. Molte proprietà erano state vendute, molti debiti erano ancora da pagare, mentre la professione forense, se in qualche modo aveva dato dei buoni compensi al padre, si mostrava poco generosa con il figlio. Che Totò se la passasse male, era assolutamente evidente. Ed anche commovente. L’appassionata lettura di romanzi russi mi metteva le lenti adatte per immaginare le angustie - a dir poco - di un padre che non ha i mezzi per mantenere i figli studenti e studentesse; nutrirli, vestirli e tenerli al caldo.
Lo vedevo infelice e tuttavia sforzarsi d’essere socievole, anzi mellifluo. Pensavo: “I pregiudizi”... E lo salutavo. “Buongiorno, Totò”.
“Oh, mio caro. Buongiorno, mio caro... Molte lezioni oggi, eh ?... Virgilio, eh ?... Il maestro di color che sanno, il donno Virgilio... Arma virumque canò... Troiaeque qui primus abòris...”, recitava pasticciando un pochino.
Al contrario di me, papà non poteva soffrire il cugino e lo giudicava
81
severamente. Le volte che la mamma ne parlava, per commiserare le ristrettezze in cui la famiglia versava, egli esclamava invariabilmente: “Ma perché non se ne va a Milano, invece di stare qui a marcire? Così non mi toccherà più d’incontrare la sua faccia di jettatore.” Difficilmente lo nominava, anzi li nominava. Intendo dire il padre e il figlio. Se c’era da commentare una loro malefatta, sussurrava: “Lazzaroni con lo stemma araldico sopra il portone!”
Se il loro nome sopravveniva mentre stava in compagnia di estranei, non diceva niente, ma sorrideva amaro sotto il baffetto spagnolo. Non toccava ferro come tutti - non lo faceva mai - ma posso immaginare che, nel caso, gli sarebbe piaciuto essere superstizioso. Zio e cugino erano la sua bestia nera.
*
Papà chiuse il negozio nei primi mesi del 1942. Ma già prima era come se fosse chiuso. Due dei giovani erano partiti militari. Don Pantaleone, che ormai aveva poco da fare, aveva trovato un impiego presso l’ufficio ammassi. Era rimasto soltanto il sofistico don Aniello. Alla bisogna si chiamava qualcuno della ciurma, i cui componenti erano ridotti alla fame nera. Le cisterne erano state requisite dalla prefettura per l’ammasso obbligatorio dell’olio e il magazzino era stato diviso da un muro all’altezza della prima navata.
La guerra si faceva più vicina e non passava giorno senza che i bimotori inglesi mitragliassero la linea ferroviaria e sganciassero delle bombe. Andammo ad abitare nel casino che zio Generoso aveva lasciato in eredità a mio padre. La Cavalera, che ne aveva l’usufrutto, era morta l’anno precedente.
Il fronte interno, come allora veniva chiamata la popolazione civile, era in una condizione non meno avvilente di quello combattente. La
82
povera gente trascorreva un altro inverno senza pane e senza fuoco. La paura cresceva e la demoralizzazione straripava nelle nostre coscienze.
La famiglia di Vitulia era scomparsa dal paese parecchi mesi prima di noi, seppi inghiottita dall’antica collina, dove possedeva ancora una vecchia villa.
Sicuramente avrei potuto raggiungere il luogo e vederla. Le lunghe pedalate non mi spaventavano, né spaventavano gli amici che mi avrebbero fatto compagnia, ma non lo feci. Anzi, volendo essere più chiaro, dopo il ballo, per molti giorni non ebbi altro pensiero e bisogno che rivederla, dirle che l’amavo e chiederle se mi voleva. Ma poi non mi muovevo. A trattenermi non era tanto la lontana e impubere ingiunzione del nonno circa i sangui che non dovevano congiungersi (in effetti un pensiero del caso non l’avevo, o non l’avevo ancora maturato), quanto uno strano pudore. Non volevo che la gente sapesse, o capisse che ero innamorato. E questo, nello stesso momento in cui sentivo l’opposto impeto di urlarlo ai quattro venti.
Poi, lontan dagli occhi, lontan dal cuore, improvvisamente mi innamorai di un’altra, a nome Elsa.
Per quel poco che si andava a scuola, Elsa frequentava le magistrali. Era bionda, alta e forte, molto probabilmente titolare di un DNA tenacemente sopravvissuto al lontano passaggio dalle nostreparti, ottocento anni prima, dei barbari e intraprendenti normanni. Portava delle trecce incredibilmente lunghe, per cui era anche diffusamente appellata Ermengarda, in onore dell’ottimo Manzoni.
Durante la primavera, il mio travolgente amore comportò fatiche e rischi notevoli, e non solo per me, ma per l’esteso gruppo degli amici. Siccome le scuole avevano chiuso i portoni sul finire di marzo,
83
in tutto il periodo successivo bisognò quotidianamente raggiungere in bicicletta - onde renderle omaggio - il paesino dove abitava, posto a venti chilometri circa da San Policarpio. L’omaggio consisteva nel girare per un’ora circa, sempre in bicicletta, intorno all’isolato in cui la vichinga aveva il suo malioso castello. Poi, quando il sole calava, attendevo che la celestiale fanciulla scendesse nell’orto, in modo che arditamente potessi stringerle una mano attraverso i robusti pali della staccionata. Anzi, mi pare - ma non sono completamente certo - che nel corso di tali furtivi incontri ci sia scappato pure un fugace bacio, reso possibile, anzi facilitato da due pali storti, i quali, oltre al passaggio delle mani, consentivano l’accostamento delle punte dei nasi. Mentre ciò avveniva, qualche inglese impertinente sventagliava raffiche di mitraglia sulla rocca della Rocchetta. Nel contempo il vasto popolo dei miei compagni ciclisti intratteneva non altrettanto casti conversari con le ragazzotte che, richiamate dal nostro intenso ronzare in bicicletta, si affacciavano alle finestre delle loro case, più basse e meno difese di quelle del maniero.
Il fiorire di tali disinvolti amori ciclistici avrebbe sicuramente favorito il mio, ancor più travolgente, se non mi fosse capitato d’innamorarmi anche di Assuntina, la quale era una contadinella mora, tenera e flessuosa, del tipo danza del ventre, nostra vicina di casa nel luogo dove eravamo sfollati.
Qui non c’era la staccionata, quindi le cose andarono un po’ oltre. In mancanza dei pali, c’erano però il fucile e il coltello di suo padre, cosa che mi consigliò una certa prudenza. Ma la calma mi mandò rovinosamente in tilt. Presi a rimproverarmi l’evidente incostanza. Improvvisamente mi scoprivo capace di infedeltà e tradimenti. Peggio, incapace di dominare gli impulsi della carne e di tracciare un solco
84
lineare in cui far marciare i pensieri e i sogni.
Qual mai amletico Romeo ebbe altrettanti e tremendi dubbi? E certamente, se non fossi stato il ragazzo controllato che ero, quei mesi di congiuntura tra bombardamenti inglesi e bombardamenti americani, i miei amici e confidenti li avrebbero vissuti con molto fastidio.
*
Nei primi mesi di quell’anno m’incontrai con due parole che oggi la televisione ci somministra a colazione, pranzo e cena: inflazione e svalutazione.
Debbo confessare che neppure dopo averle afferrate mnemonicamente riuscivo a capire di cosa in effetti si trattasse, né a rendermi conto del perché spaventassero enormemente i miei. Certamente non ero tanto distratto da non notare la presenza del mercato nero e dei corrispondenti prezzi, ma debbo dire che continuavo a spiegarmi il fenomeno con la dicotomia ricchi e poveri: i primi in condizione di comprare pane, pesce, carne e quant’altro, i secondi impediti a farlo. Ma, per i miei genitori, la questione era ben altra. Per la precisione - finalmente capii - di vedersi evaporare dalle mani i cospicui risparmi familiari. Si trattava, ben sapevo, di una somma considerevole, con la quale si sarebbero potuti comprare, o far costruire, parecchi palazzi e aprire un nuovo deposito. Con l’inflazione quei soldi avrebbero perduto ogni valore, e se fossimo stati sconfitti - come ormai appariva razionalmente non dubitabile - sarebbero bastati appena ad acquistare qualche chilo di patate, come era accaduto in Germania alla povera zia Wilma. Un altro chilo di patate sarebbe stato il controvalore della dote materna, costituita da 300 mila lire in buoni del tesoro. Insomma, saremmo stati belli e rovinati nel volgere di qualche mese.
In una situazione non migliore si sarebbero trovati i vecchi zii
85
materni, i fratelli della nonna Fazio, e i loro figli e nipoti, in fama d’essere anche loro milionari. Cominciarono allora, nella famiglia allargata, dei gran consulti, ai quali mi fu permesso d’intervenire data l’eccezionalità del momento. L’ardimentoso zio Rosario, prendendosi in tal modo una storica rivincita sui prudenti fratelli, propose di mettere assieme tutte le risorse e di costruire un secondo sbarramento subalveo per l’irrigazione, questa volta a nord del paese. L’idea era buona, ma la sua applicabilità era subordinata non tanto alla difficoltà di ottenere l’assegnazione del cemento necessario e di trasportarlo, per oltre cento chilometri, sotto l’infuriare dei bombardamenti, quanto a quella di ottenere in breve tempo l’autorizzazione prefettizia a sbarrare il fiume.
A sua volta zio Bixio, che era scappato dalla Sicilia con i figli, le nuore e i nipoti, propose di costruire una distilleria con degli alambicchi fabbricati artigianalmente. L’uva c’era, e sicuramente la guerra non avrebbe toccato i vigneti. Quest’idea apparve anche migliore della prima e la raffineria sarebbe stata certamente avviata, se i bolli della guardia di finanza non fossero arrivati a guerra abbondantemente finita.
Ci furono altre proposte, ma tutte difficili da mettere in pratica. Alla fine la mamma sbottò dichiarando che, in quel particolare momento, l’unico investimento serio consisteva nel comprare della terra. I soldi c’erano, in campagna si poteva fare a meno del cemento e del prefetto; la terra stava inchiodata lì e nessun inglese o americano avrebbe potuto portarla via. Ma non la vinse. Quantomeno non l’ebbe vinta subito. La maggioranza degli zii decise d’andare a chiedere consiglio al Senatore De Ruocco, un illustre mercante, il quale s’era arricchito nel corso dell’altra guerra. 86
Il Senatore era sfollato nelle campagne del Marchesato, cosa che significava un viaggio di centocinquanta chilometri, non esente da pericoli. Su questo punto l’opposizione di mia madre salì di tono. Andare a Crotone era cosa facile a dirsi, ma difficile a farsi. Le incursioni aeree erano ormai così frequenti che affrontare un tragitto del genere equivaleva all’esporsi in prima linea. La strada e la ferrovia erano tenute sotto tiro di giorno e di notte.
L’idea del treno venne subito scartata. Ne passavano ormai pochissimi e senza alcun rispetto degli orari. Si trattava di convogli ridotti al rango di tradotte militari e spesso carichi di armi e munizioni. C’era ancora un treno passeggeri ogni giorno, il cosiddetto Bari che, fatti i debiti trasbordi nei punti in cui la linea era interrotta, portava militari in licenza dalla Sicilia in Puglia e viceversa. In stazione si potevano persino avere notizie circa il suo mutevole orario, cosa che offriva la possibilità teorica di servirsene. Ma bisognava anche accettare l’alea di rimanere fermi in qualche stazione per un tempo imprecisabile, se sulla linea c’era o c’era stato un bombardamento.
“No, non fare pazzie. A Crotone!... C’è il rischio della vita... E poi lo sappiamo bene a cosa pensa questa gente...E’ gente che si è arricchita durante l’altra guerra con il contrabbando... magari facendo la spia per i tedeschi. Mettersi nel contrabbando non è cosa per te... Per queste cose c’è il carcere... la fucilazione alla schiena...I soldi si possono rifare, la vita no...Il disonore...”
“Pizzeche e vasi non fanno pertusi. Non c’è niente di male che vada a sentire. Di un commerciante si tratta, non d’un bandito... Don Ernesto è senatore del Regno, e scusate se vi pare poco...Ti sembra mai possibile che uno come lui si mette negli impicci?”
Ma la paura di mia madre si autoalimentava. La sua sfiducia verso
87
ogni forma d’impresa, che non fosse quella agricola, era riemersa nel corso degli ultimi mesi di guerra, e con essa la sua foga intimidatrice. Proprio il giorno della decisione, lo shock di un cannoneggiamento navale fece crescere la tensione in famiglia. A sera, ella pose apertamente il veto. “Tu da qui non ti muovi, o me ne vado con i ragazzi da mio fratello, in Sicilia.”
“Vattene pure in Sicilia, ma io la figura di chi prima s’impegna e poi si ritira, non la faccio.”La mamma non andò in Sicilia e papà andò all’incontro. Anzi noi – lui e io - andammo all’incontro. In fondo, le bombe nemiche ti potevano colpire anche a casa. Eravamo nelle mani di Dio.
*
Per il viaggio fu adottata la lussuosa Isotta Fraschini di zio Bixio, dio solo sa con quali arti salvata dalla requisizione. Pippo, il figlio maggiore, eletto nocchiero, approvò la mia presenza. Gli avrei potuto dare un aiuto nel caso di forature. Si trattava di un’eventualità tutt’altro che remota, essendo ormai tutte le gomme delle poche auto ancora in circolazione ridotte a un velo. Tanto consunte erano quelle dell’Isotta Fraschini che Pippo si portò dietro ben quattordici ricambi, ovviamente rappresentati da gomme ancor più usurate di quelle montate.
Don Ernesto De Ruocco - o per meglio dire il Senatore De Ruocco, o più sinteticamente e antonomasticamente il Senatore e basta - era stato elevato dal re al laticlavio per via del suo plurimilionario portafoglio, e non invece, come oggi si potrebbe essere indotti a immaginare, per benemerenze politiche. Bisogna poi precisare che i suoi meriti erano piuttosto fondiari che commerciali, perché, ancor prima che il vero padrone della Società Commerciale Jonica, era un grande proprietario terriero; proprietà - si diceva - equamente divisa tra Parma,
88
l’Agro nocerino e il Marchesato di Crotone.
Nonostante il rango, il Senatore si diceva fosse persona alquanto affabile, disponibile, senza puzze sotto il naso, oltre che molto intelligente, abile negli affari e addentro nelle segrete cose dello Stato e dell’economia nazionale, nonché a contatto personale con il duce.
Partimmo che albeggiava. Un sibilante vento di tramontana spazzava la vecchia e disselciata nazionale. Il mare, in apparenza liscio come una tavola, era, però, segnato da piccole creste di spuma bianca. E noi della costa sappiamo bene come ciò riveli che sta fremendo sotto il contropelo delle raffiche.
I soldati tedeschi che incontravamo, per proteggersi il volto dalle sferzate, stavano con l’elmetto incastrato dentro il bavero del cappotto; quelli italiani si attorcigliavano intorno alle falde dei loro miseri pastrani. I vecchi contadini, che a quell’ora antelucana si avventuravano a piedi dal borgo al campo, tirandosi dietro, nonostante le intemperie, la moglie rinsecchita e i nipotini a frotte, procedevano curvi, quasi carponi. Altri contadini, meno vecchi o del tutto giovani - forse militari in licenza - s’infilavano nelle folate spingendo a mano la bicicletta, come se volessero perforare l’aria. Visti dalla macchina in corsa parevano burattini impazziti.
Tenendo conto dell’inclemenza del tempo e delle condizioni della strada, l’Isotta Fraschini procedeva velocemente e, fortunatamente, senza beccare un solo chiodo. Cosa che si doveva al fatto che anche i cavalli e i muli erano stati requisiti, mentre gran parte degli asini erano stati tradotti in gustosa mortadella.
Stavamo attraversando una parte di Calabria che praticamente non conoscevo: un percorso fatto altre volte in treno, ma sempre di notte. Qui il paesaggio si allargava. La montagna si distendeva e propagava
89
verso il mare con un più lento degradare di colline. Anche l’arsura della terra pareva essersi spenta. Il verde industriale degli aranceti aveva lasciato il posto al triste neroverde dell’ulivo. La freschezza dei campi arati, lungo le acclività collinari, addolciva i colori dolorosi del paesaggio. Un cielo tersissimo, azzurrissimo, prendeva le distanze dai sottostanti, severi, terragni affreschi.
Intorno ai frequenti torrentelli, la folla chiassosa dei canneti si dibatteva sotto la violenza delle raffiche, le cime degli antichi pioppi danzavano terrorizzate, le querce, spavalde, sostenevano l’urto, però rabbrividivano esse stesse del proprio coraggio.
L’infuriare del vento incitava il guidatore a coniugare un vero rosario di bestemmie, che da Cristo Salvatore Nostro scendeva giù, passando per i Santi Medici Cosimo e Damiano, fino al cane di San Rocco. Le raffiche arrivavano violente e improvvise, e Pippo faceva fatica a tenere le ruote dentro la strada. Le buche, di cui era disseminata, gli facevano ballare lo sterzo in mano. Bisognava, però, correre quanto più si poteva, e far presto. Avevamo scelto di partire all’alba, quando gli aerei erano ancora a rullare sulla pista. Alle dieci, o magari alle nove e mezza, sarebbero arrivati per farci ascoltare le loro cantate di morte.
Per fortuna, poco dopo le otto e mezzo eravamo già al casino del Senatore, immerso in un bosco di poderosi ulivi.
Sotto l’oliveto era come se il vento si fosse placato. Soltanto le cime degli ulivi stormivano protettive. C’erano due ragazzi della famiglia ospitante. Secondo il Senatore, mi sarei annoiato. Per tal motivo - dopo averci mostrato dall’alto di un terrazzino, lontane qualche chilometro, le Castella, un maniero medievale circondato dal mare - mi affidò a loro.90
“Non andate per la via diretta. Prendete lungo il fiume ...”
La riunione mi avrebbe attratto di più. Ero ancora troppo giovane per non partecipare alla vita della mia famiglia e per non essere sensibile ai suoi interessi. Tuttavia non potevo proclamarlo proprio per via dell’età. I ragazzi non dovevano intervenire in certe cose, questa era la regola. “Parra sulu quandu u gallu faci l’ovu”. Così me ne andai con i due, ma invece di seguire i dettami del Senatore volemmo vedere, sia pure da lontano, l’aeroporto.
In fondo la Calabria era zeppa di vecchi castelli in rovina, nonché circondata da un vasto mare, sempre uguale a sé stesso, mentre, di aeroporti, non ne avevo mai visto uno. Fu una grossa e mussoliniana delusione. Si trattava soltanto di terra spianata e coperta da un cereale spontaneo a noi non noto. Pochi nidi di mitragliatrici, non si capiva bene se ancora in funzione, una decina di carcasse di velivoli, una decina di carcasse di camion, due o tre alti pali metallici, che forse avevano sorretto delle maniche a vento, poi portate via proprio dal vento, i resti sforacchiati di un edificio, probabilmente il vecchio comando. Di aerei in funzione, neppure l’ombra. Solo un gregge a pascere e degli avieri a far finta di fare il picchetto intorno all’alta rete, anch’essa sforacchiata a ogni passo, ma questa volta, con tutta evidenza, ad opera di mani umane, per farci passare le pecore.
Quando fummo tornati al casino, ovviamente, nessuno si curò d’informarmi circa i consigli del Senatore. Dovetti ricostruirli faticosamente da me, attraverso i discorsi che ascoltai durante il pranzo e nel corso della serata. Il punto era questo: l’inflazione, che era già in atto, sarebbe sicuramente aumentata ancora, come era già capitato durante l’altra guerra e nel successivo dopoguerra. Ciò avrebbe colpito i creditori. Il capitale commerciale si sarebbe salvato solo acquistan
91
do merci e, poi, aspettando che il prezzo aumentasse. Praticamente la via d’uscita era il mercato nero. La capacità d’acquisto della moneta avrebbe ceduto quote rilevanti. Forse la metà, forse due terzi, o forse peggio, perché questa volta l’Italia avrebbe perduto la guerra. Anzi, se Mussolini non si sbrigava a chiedere l’armistizio, questa sarebbe arrivata sul territorio nazionale. La trasformazione sociale sarebbe stata, sicuramente, di vaste proporzioni.
L’alternativa proposta del Senatore consisteva nella formazione di una società, da lui diretta, con venticinque milioni di capitale, che avrebbe acquistato la Cassa Bruzia di Credito. Nel caso di svalutazione monetaria la banca non guadagna e non perde. Secondo il Senatore, una volta finita la guerra, sarebbe emersa una nuova classe di ricchi, composta dai proprietari terrieri, che producevano gli alimenti, e da chi si sarebbe inserito nel mercato nero. Impiegando i depositi dei nuovi ricchi, la banca avrebbe potuto finanziare le attività dei soci.
*
La proposta non andò a genio alla mamma. Mettersi con la gente che ruotava intorno a De Ruocco significava farsi aggiogare a un carro che percorreva strade tortuose. Quali soci? Un’autentica banda di ladroni. Perché nessuno ignorava che alcuni di loro corrompevano i capistazione e acquistavano per poche lire le merci contenute nei carri che i bombardamenti avevano bloccato in stazione. - “No e poi no. Non voglio vederti in galera. La guerra finirà. E non sappiamo ancora se gli inglesi ci ammazzeranno tutti. In queste condizioni vuoi pensare al dopo? Ma se non vogliamo perdere il nostro capitale, ci sono mille altri modi. E fra questi mille modi, il più tranquillo è quello di acquistare un bel fondo.”
L’argomento era pertinente e papà appariva perplesso. Lo aveva
92
toccato non tanto l’idea delle prevedibili difficoltà, quando l’interrogativo sui compagni di strada. “Forse hai ragione tu. Chi va con lo zoppo… D’altra parte, io non ho mai fatto il banchiere, e quando non si possiede il mestiere, è meglio non mettercisi ... “
Alla fine decisero di dividere il tesoro in tre parti. Una l’avrebbero affidata a De Ruocco, se non altro, per non disgustarselo: con la seconda avrebbero acquistato un fondo, mentre con la terza avrebbero tentato di acquistare dei metalli preziosi, che sarebbero stati sommamente utili se si fosse stati costretti, da uno sbarco sulle nostre coste, a scappare al Nord.
La ritirata di papà caricò sulla mamma l’arduo compito di salvare i nostri danari dalla svalutazione. Era un’idea alla quale non pareva volesse rinunziare, e tuttavia non riusciva a trovare un braccio secolare per realizzarla. Gli zii erano vecchi, i cugini innamorati di De Ruocco, altre persone difficilmente abbordabili senza lo schermo del capofamiglia.
Sapemmo dopo che, guardatasi attorno, aveva concluso che ‘u Giomu, figlio di un colono del nonno Ninai, ed egli stesso colono nel fondo ereditato da mamma, un mafioso scaltro, duro, ma affidabile più di un familiare, era la persona che faceva al caso suo. L’aveva perciò chiamato in disparte, e in segreto gli aveva spiegato il percome e il perquanto.
‘U Giomu che, come imparai in appresso, era sensibile all’idea di proprietà privata più di un illuminista inglese, mise in moto la macchina dell’onorata società, nel cui seno, si diceva, era una persona di spicco, forse il capo della ‘ndrina d’a Batìa. Nel giro di otto giorni egli trovò quel che la mamma cercava: un esteso appezzamento di terra a pascolo, trasformabile in terreno irriguo. Lo vendeva un anziano
93
ufficiale, che ne aveva avuto pieno mandato da una sorella altrettanto anziana, sposata a un signore toscano.
Una sera del giugno 1942 arrivarono al casino il notaio Brucculeri e il ragionier De Luca, direttore della Regia Banca. Papà, mestamente, e mia madre, che aveva venduto alla Banca i suoi buoni del tesoro, armata di molto spirito di rivalsa e con gran cipiglio, acquistarono in comune l’indivisa terra denominata “Vasia” per la somma di lire 650.000 (seicentocinquantamila), “somma che il qui presente Ragionier Carlo De Luca, intervenuto come sopra con procura istitoria allegata all’Atto, afferma liquida, disponibile e trasferibile sul conto della venditrice contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita”.
Il capitano medico Moccaldo, parente di certi nostri parenti casertani, al momento di stanza a San Policarpio, nonché don Damiano Reale, lo scrivano del notaio, fecero da testimoni al solennissimo atto, in base al quale “il qui presente dottor Generoso Alfano, del fu don Paolo e di donna Maria Celeste Staibano, di anni quarantadue, commerciante all’ingrosso, e donna Sara Alongi, del fu dottor professor Beniamino e della fu donna Isabella Fazio, di anni trentanove, gentildonna, contraenti della cui identità io Notaio sono certo”, divennero proprietari di una terra ex nobiliare.
Per l’occasione, si aprirono parecchie bottiglie di greco ben invecchiato. Bellicamente, potei berne a volontà, per la qual cosa stetti male tutta la notte. Ma molto meno male di coloro su cui piovevano le bombe che, tra un conato di vomito e l’altro, sentivo esplodere al di là dell’Aspromonte. Papà e mamma mi stavano accanto, per il caso che dalla sbornia non sortisse un maggior danno; lei pacificata, lui rannuvolato, potei notare nonostante i fumi dell’alcol. Qualche giorno dopo
94
gli chiesi il perché dello scontento. “E’ finito un capitolo della mia vita. Adesso sono anch’io un proprietario. Che vuoi di più?”
L’eventualità, a cui non avevo mai pensato prima, di mio padre senza il suo lavoro mi lasciò perplesso. Quello splendido Alfano, che scendeva atleticamente le scale di casa per raggiungere il suo negozio, quel signore che tutti riverivano, sufficientemente ricco da poter spendere duemila lire per comprarmi, da un ufficiale tedesco, una magnifica Leica, quell’agile nuotatore, quell’ardito velista, e - aggiungeva la mamma per gli ignari – quel provetto schermitore; il mangiatore raffinato di quell’orrenda cosa a nome “le cervella”; il fumatore impenitente, che adesso sapeva non soffrire per la mancanza di sigarette; l’uomo distinto a cui le donne correvano dietro facendo impazzire di gelosia la povera mamma; il padre mio e di mia sorella Celeste, che fra dieci o dodici anni si sarebbe dovuta maritare, per cui bisognava preparare sin da adesso una dote all’altezza degli Alfano; quell’uomo che sembrava nato per lavorare e guadagnare, non avrebbe avuto più un lavoro, non avrebbe prodotto ogni anno centomila lire di utili con il suo negozio, come già non le produceva più.
Cosa gli sarebbe rimasto? Ce ne saremmo andati, lui e io - similmente a quei gnuri che mi aveva abituato a guardare con un pizzico di sufficienza - la mattina presto in campagna a sorvegliare le raccoglitrici di olive? Ci saremmo forniti d’un fucile da caccia, per sparare orrendamente a dei poveri uccellini? Chissà cosa c’è nel destino di un essere umano la cui esistenza pare già disegnata, e per sempre!
In appresso, insistetti ancora con la domanda. La sua risposta mi riportò con i piedi a terra: “Stiamo franando,figlio…E’ uno scivolone interminabile. Facciamo i passi del gambero, una generazione dietro l’altra. Dietro le spalle di mia madre ci sono quaranta generazioni…Da
95
quando Napoli era un ducato bizantino…Cavalieri di Malta, generali, banchieri, ministri, cardinali, abati…Cos’è rimasto degli Staibano? Neppure i ritratti…Tutto sparito, venduto, distrutto… Pure i ricordi…Le targhe all’angolo delle vie… Abbiamo cancellato la nostra storia e abbiamo adottato quella degli altri…
“ E mio padre? e mio nonno? … Armatori e mercanti mondiali, conosciuti dovunque…. Pareva che avessero preso la rincorsa per arrivare lontano…Ci siamo perduti dietro un sogno…Un’illusione… Forse un inganno…Chissà, forse una trappola…Siamo tornati indietro a scatti, e adesso siamo alla fine della rappresentazione. Non mi piace, proprio non mi piace essere inchiodato alla terra come un contadino, come un servo della gleba… “Vedi, figlio, la vita di un uomo è sua… Il giudizio su di sé e sul mondo sta dentro di lui…Ma dove nasce, dove muore, come trascorre l’esistenza, quello che fa, quello che è indotto a fare, non dipende da lui. E’ dove è nato, il suo paese…Un americano è più libero di un cinese, un genovese è più libero d’un calabrese…E’ la storia…Sono i corsi e i ricorsi…Non è filosofia, è la vita vera d’ognuno…
“Il commercio non chiude qui, è eterno. Ma quando quest’inferno finirà - sempre che abbiamo salva la vita - non sarò più io a dettare le regole, ma chi avrà in mano i capitali…Forse quelli che oggi fanno il mercato nero, forse i fornitori, forse le banche, forse gli inglesi…E tu e Celeste?…La vostra indipendenza non sarà più vostro padre a costruirla. Per te non c’è altro che la professione. Una miracolosa carriera, come quella di tuo nonno Ninai, è un caso su mille. I più finiscono nell’impiego. E dovrai ritenerti fortunato se avrai un posto di pretore, come Filiberto. Ma per un posto del genere devi studiare…. Eccome, se devi! Se no ti tocca di fare il cancelliere…Che so, il maresciallo dei
96
carabinieri, della finanza! E per Celeste sarà anche più difficile.“
*
Quando ormai pensavo a lei solo di tanto in tanto – e solamente quando stavo per addormentarmi - ringraziando Dio per avermela fatta perdere, in modo da non avere più la materiale possibilità di trasgredire all’ingiunzione del nonno - lei ricomparve. Avvenne a scuola, e proprio nella mia classe. Una tegola in testa mi avrebbe stordito di meno. Le gambe mi si afflosciarono. Una sensazione simile l’ho provata soltanto dopo moltissimo tempo – proprio da vecchio – quando un infermiere distratto mi praticò due iniezioni di papaverina una dietro l’altra.
Caddi seduto nel mio banco, senza udire e capire più niente. Finita l’ora, Vitulia uscì dal suo banco, venne verso di me, mi dette la mano e, come al solito, si protese per il rituale scambio di un bacio sulla guancia. Il contatto fisico mi portò alle stelle e, contemporaneamente, le buone maniere nel mondo della ritualità. Infatti seppi chiedere come mai fosse lì, e poi come stava zia Minicuccia, come stava Norina, come stava Totò, come stavano i fratelli. Dimenticavo sempre zio Ferdinando, ma non per colpa mia. Vitulia mi spiegò che i nonni Aversano si erano rifugiati in un paesino della Sabina e lei era tornata in paese per paura che un’invasione la tagliasse fuori dal resto della famiglia. Aggiunse che adesso viaggiava con due altre ragazze. Un’intera ora di calesse a scendere, due ore al ritorno.
“Il posto dove abitiamo è bellissimo. E’ in alto. Almeno cinquecento metri. Vedo tutta l’insenatura, da punta a punta. Un sogno. Non sapevo che ci fossero posti così belli.
“Studiare con il lume è molto dolce. La luce è più morbida. Mi piace persino il cattivo odore del petrolio.”
Tutti i giorni, alle undici, passavamo il quarto d’ora di ricreazione
97
assieme, innamorati senza dircelo, parlando di questo e di quello. Poi un giorno, a causa di un’incursione aerea, abbandonammo la classe e corremmo verso il rifugio; una specie di trincea scavata nel mezzo della strada. All’entrata, la calca era enorme. Era l’occasione sperata. Come per un tacito accordo riprendemmo a correre, questa volta verso i campi non lontani. Ci buttammo per terra, in un punto in cui il suolo si avvallava. E siccome a ogni deflagrazione, Vitulia si aggrappava a me, io la baciai tutto tremante, come il mio omonimo dantesco. E lei, tremante, si protese, per essere ancora baciata.
In classe non le staccavo gli occhi dalla nuca. Lei, di tanto in tanto, si voltava a sorridermi. Era quanto bastava perché i compagni capissero di ben altro trattarsi che di effusioni tra parenti. D’altra parte Vitulia non fece un mistero dei suoi sentimenti, e io mi adeguai.
Assieme, per così dire, sul posto di lavoro, potei conoscerla meglio. L’idea che fosse o volesse apparire una reginetta era falsa. La sua spigliatezza di cittadina era sorretta da un carattere spontaneo, ben lontano dai miei contorcimenti. Era bella, piena di vitalità, fiorente di morbidezze femminili, intelligente e fine. Metteva assieme un’indole ferma e un fare dolce e appassionato. Inoltre si rivelò essere in tutto la prima della classe, persino in matematica, materia in cui tenevo la palma da sempre. Ma la sua vera passione era la storia, in cui era ferratissima, specialmente a proposito della Rivoluzione francese; chiaramente una suggestione del nonno Aversano.
*
La scuola andava avanti arrancando. Con l’ingresso sulla scena delle fortezze volanti, che sorvolavano più volte ogni giorno le nostre teste, gli allarmi aerei si succedevano l’uno all’altro. Spesso non si aveva il tempo di sedersi in classe, che già si doveva correre fuori.
98
Finito l’allarme, finiva anche il giorno di scuola. Il calesse attendeva, Vitulia era tenuta a partire. Insomma niente scuola, niente incontri; una deprivazione che faceva di me l’unico studente che preferiva le lezioni alla vacanza.
Nei giorni in cui, per fortuna, c’era lezione, attendevo con ansia il quarto d’ora di ricreazione per stare con lei. Avevamo scoperto un angolo più appartato nel giardino pubblico dove scambiare, con il cuore in gola, un bacio e un abbraccio fugaci. Per quanto le rispettive famiglie, in quel momento, fossero di ben altro preoccupate, il fatto che Vitulia e io ci vedessimo come dei fidanzatini arrivò alle loro orecchie. Temetti il peggio, ma fortunatamente non avvenne alcunché di tremendo: il cugino Totò non sguainò la spada e papà incassò la sorprendente novità con un innocuo commento: “Il tempo passa, il mondo cambia. Chissà se domani saremo ancora vivi!”
La mamma bofonchiò qualcosa, quindi, come al solito pianse sulle future sciagure che mi sarei avventatamente procurate, alla fine ammutolì.
Contraddittoriamente l’unica a protestare fu la nonna, di solito transigente: - “Tu tradisci tuo nonno ... Il suo nome ... l’onore di tutta la famiglia ...”
Quell’uscita mi sembrò veramente strana. L’inattesa e insolita severità mi portò a riflettere, ad avvertire dei pesanti sensi di colpa verso il nonno; cosa che non riassorbiva l’amore, anzi lo rendeva più vivo, ma mi suggeriva atteggiamenti cauti e circospetti, m’induceva a impormi freni e remore, a evocare paure inconsistenti. Per esempio a cambiare strada quando stavo per incontrare Totò. O a tenere lontani da mamma e da papà i miei amici, per tema che si mettessero a parlare di Vitulia e me. Ma l’idea che mi faceva veramente impallidire era un
99
incontro con zia Minicuccia. Il buon senso m’invitava alla calma. La zia era vecchia, gli americani si facevano pesantemente sentire. Era, quindi, difficilissimo, praticamente impossibile, che lasciasse ‘a Gonia per venire in paese. Ma l’ansia non si quietava. A chiunque altro avrei dato una risposta elusiva, mentre con lei non avrei saputo tacere la grandezza del mio sentimento. E se oltre a ciò, la zia mi avesse chiesto come pensavo di superare le avversioni familiari, non avrei saputo cosa risponderle. In effetti era questa la verità su cui mi era piaciuto autoingannarmi. L’onda dolce dell’amore poteva momentaneamente travolgermi, ma non doveva andare oltre nel tempo. Doveva necessariamente finire.
Il pensiero che Vitulia potesse soffrire dell’addio non arrivava sulla soglia del mio contorto cervello. Vitulia mi appariva non so se come una dea non lambita dalla comune vicenda umana o come una fonte di gioia corporale inesauribile. Ero il suo idolatra e nello stesso tempo il mercante di Venezia che voleva pascersi con la sua carne e forse anche con la sua anima.
Il pomeriggio del lunedì, Vitulia s’era precostituita una lezione di pianoforte, e scendeva in paese con il padre, che ci veniva a incontrare un qualche cliente. La cosa le dava il modo di stare un po’ con me. In previsione di ciò, andavo a parcheggiarmi nelle vicinanze della sala da bigliardo, e da lì la vedevo avviarsi verso la Via Marina, dove abitava la maestra di piano. Dopo la lezione, la raggiungevo e ci mettevamo a camminare sulla spiaggia, dove la sabbia si attacca al terreno più solido, coperto di cespugli marini. Ci accompagnava il cri cri dei grilli, che lì abitavano: una mite canzone d’amore.
Camminavamo solitari lungo la quieta distesa marina. Le sfumate trasparenze del cielo arpeggiavano dolcissime canzoni. Io scattavo
100
una fotografia dietro l’altra. Mi piaceva, è vero; ma, in effetti, era un fanciullesco alibi che voleva coprire la trasgressione. L’appartarsi in luoghi romantici era cosa insolita, rarissima a quei tempi - roba da cinema. Avvertivo la silenziosa invidia dei miei coetanei aleggiarmi attorno. Capivo anche che, nella logica del paese, stavo compromettendo la buona reputazione di Vitulia e dei Surrenti. Ma vedendola felice e sicura, non osavo affrontare il discorso delle eventuali cautele.
D’altra parte, se capitava che un brutto pensiero mi attraversasse la mente, lei subito lo intuiva. Allora trovava il modo di offrirsi a un bacio, e io dimenticavo ogn’altra cosa.
*
Arrivò il tragico inverno 1942/43. Il Padreterno disse al cielo: piovi!, e il cielo non si fece pregare. Neppure i nuovi arrivati sulla scena celeste, i quadrimotori americani, si fecero pregare. Cominciarono ad arrivare più presto, a trenta, quaranta, sessanta alla volta. Verso le dieci un rombo molto più insistente del tuono ci avvisava. Eravamo esperti, sapevamo che non venivano per noi. Il guaio era se al ritorno facevano la stessa rotta. In quel caso, le bombe non impiegate sulle città, le lasciavano cadere prima d’inoltrarsi sul mare. Dovunque capitava.
Distesi pancia a terra, dove il terrapieno della ferrovia dava l’idea di una trincea, ci mettevamo, impotenti e umiliati, a scrutare il limite dell’orizzonte per osservare se arrivavano da est o sud-est e se poi, una volta sulla linea della sponda marina, viravano verso nord-ovest, nel qual caso l’obiettivo sarebbe stato la Campania, o verso sud-ovest, nel qual caso l’obbiettivo sarebbe stato la Sicilia. A Reggio e Messina, sapevamo ormai, erano riservate le incursioni pomeridiane.
Qualcuna di quelle terribili bombe la lasciarono cadere anche sul paese, cosicché la famiglia si rifugiò in un casolare più remoto. La
101
scuola venne praticamente chiusa. Vitulia scomparve fisicamente dalle mie giornate, per riapparire come fantasma di giorno e di notte.
Vedendomi mesto, papà commentava: “E’ l’aria del Continente, come la chiama Angelo Musco…L’aria della gente alla moda, che abita a Roma o a Milano e sa tutto di tutto…Ti sei costruito un idolo, un feticcio…Prima o poi la farai soffrire, e non è giusto, non è da galantuomo…. Così non va”.
La mamma mi guardava smarrita. Qualche volta disse anche: “Parla, figlio!”, ma siccome io tacevo, non insistette. Giomo, il fattore, che era diventato una specie di sentinella (sicuramente armata) del casolare, mi fissava dritto negli occhi, come per leggermi dentro, e poi diceva: “Fate a botte con qualcuno, così rimettete i piedi a terra”.
Le notti erano fredde, il casolare dove eravamo sfollati era costantemente battuto da un vento pungente. Per scaldarmi avevo preso a bere, prima di coricarmi, un intero bicchiere di greco. Con un tale narcotico, facevo un sonno pesante, dal quale mi svegliavo stordito e desideroso di moto. Allora inforcavo la bicicletta e scendevo in paese con la scusa di portare qualcosa da mangiare e magari qualche messaggio a don Pantaleone, che abitava sempre il suo appartamentino nel convento. In realtà, per passare la mattinata con gli amici della ruga, quei tre o quattro che non avevano i mezzi per sfollare. Gli scherzi, i litigi, la pesca, il pallone, i pattini, le gare in bicicletta, il bigliardo abbattevano l’incubo di una giornata che sarebbe stata di malinconiche fantasie e di stupido ozio.
Non si trattava di uno stato d’animo soltanto mio. Anche la guerra diventa quotidianità, però una quotidianità diversa, la cui costante è rappresentata dalla sospensione delle attività impegnative, in attesa che l’evento minacciato arrivi. L’attesa si traduceva in noia. Qualcosa
102
di simile alla vuota attesa nella sala d’aspetto del dentista, finché non arriva il tuo turno. In un luogo del genere, anche il volo tortuoso d’una mosca rappresenta una distrazione.
Quel che mi accingo a raccontare fu, per molti, una gran distrazione tra un’incursione e l’altra. Per me, invece, fu una svolta esistenziale.
Sestia apparteneva alla ruga, ma stava a mezza quota tra la mia brigata e i grandi. Per la concezione allora corrente, non era più una ragazza, ma una donna da marito, quasi una zitella. La conoscevo da sempre. Quand’ero bambino stava sempre a casa nostra. Erano tempi in cui una giovane doveva avere un buon motivo per uscire di casa da sola e incontrare gente; e quale motivo migliore che perfezionarsi nel ricamo con mia madre, che godeva della meritata fama di essere una ricamatrice provetta? E qui un’infilata di siccome: siccome mia madre aveva soltanto venticinque anni, siccome entrambe avevano una bellissima voce, siccome l’una suonava il mandolino e l’altra la chitarra, e siccome, poi, Sestia le finezze della ricamatrice le imparava effettivamente, le due stavano benissimo assieme. Ovviamente con me fra i piedi.
Al tempo accadeva immancabilmente che a una certa ora - sempre la stessa - Sestia esclamasse: “Sono le dodici. Passau ‘a Rinomata Ditta”.
‘A Rinomata Ditta era suo padre. Sulla base dei ricordi infantili, in appresso mi ero fatto l’idea che Sestia odiasse ferocemente il padre; un genitore manesco, burbero e obbligatoriamente taccagno, uno dei peggiori nemici del genere umano; una specie di quinto cavaliere dell’Apocalisse. Anche mia madre aveva contribuito a trarmi in inganno, in quanto pure lei si riferiva a mastro Mico chiamandolo la Rinomata Ditta. E Rinomata Ditta lo chiamava persino mio padre, anche se lo
103
faceva soltanto qualche volta, e sempre sorridendo.Siccome l’insolito e stridente nomignolo era una cosa che colpiva la mia immaginazione di ragazzino, il ricordo si è fissato al momento del quotidiano transito di Don Mico Parisi per la via sotto casa. Era, questi, un uomo alto, robusto e solenne, dal vasto mantello, in cui s’avvolgeva fino alle orecchie se spirava la tramontana; che invece teneva appoggiato sulle spalle e aperto davanti, se il tempo era clemente. Così intabbarrato, passava senza mai accarezzarmi, anzi senza mai guardarmi. Incedeva lento, pesante e offensivo, burbero e chiuso; la barba ispida, più nera che bianca; un cappello nero e torvo, a larghe tese.
Se incontrava mio padre, semialzava una mano con tre dita aperte, in un gesto ambiguo tra il pretesco e il diabolico, e lo salutava senza parola.
Pareva la Malanova. Ne avevo paura. Soltanto con il passare degli anni capii che la sua era rabbia per i tempi avversi e per un mondo che lo aveva messo ai margini. In fondo non era l’orco. Infatti, così cupo e arcigno, andava semplicemente, ogni giorno alle dodici, a comprare il giornale presso il chiosco di don Sarvaturi Carbunaru - un manufatto belle époque che a me sembrava la cosa più artistica del paese, con cupola, fiori di ghisa e vetri colorati, intonato ai lampioni e posto all’angolo della vasta piazza Caricatoio.
Qui giunto, ‘a Rinomata Ditta inforcava un paio di occhiali e sfogliava attentamente il giornale; ne leggeva qualche articolo stando appoggiato con un gomito sull’alta soglia del chiosco, e subito dopo si metteva a dottoreggiare con gli altri avventori. Pretendeva di saper dare un’esauriente spiegazione di tutto e su tutto: su Dio, su Mussolini, sul Re, la Regina e il Principe di Piemonte, su Maria Josè, sul re d’Inghilterra, che forse voleva abdicare per amore di una di quelle; sulla
104
Francia, che era repubblica, ma meglio era se fosse rimasta monarchia; sulla Russia, che era una repubblica negativa, perché i comunisti ammazzavano chi la pensava diversamente; sulla Spagna, che non era una repubblica ma propriamente un casino. Non parlava invece di quel nostro passato borbonico, che tutti consideravamo fosco e vile - la negazione di Dio. Non ne parlava per non andare al confino, ma tutti presupponevamo che fosse quello l’argomento su cui gli sarebbe piaciuto dottoreggiare.
Sì, perché il mutismo, che ne faceva un uomo poco socievole in tutti gli altri rapporti, si scioglieva quando poteva trattare di politica. E tuttavia la gente non amava intrattenersi con lui perché era un interlocutore non solo strambo, ma anche presuntuoso; quanto più informato, tanto più fastidioso. E poi quell’incubo che da un momento all’altro potesse mettersi a inneggiare ai Borboni, faceva tutti guardinghi.
Sospinto, evidentemente, da tale preoccupazione, don Sarvaturi, l’edicolante, dopo averlo lasciato tranquillo per dieci minuti, infilava una mano attraverso le metalliche volute del suo chiosco e toccandogli la spalla diceva: “E mò, Micu, vattindi, ca mi cacci i clienti” .
Mastro Mico grugniva, ma se ne andava. Si sedeva allora poco distante, su una panchina di ferro, dando le spalle al sole, e stava lì fino al rintocco della mezza, cioè fin quando suonava la mezz’ora dopo mezzogiorno. Stando a sedere, il rigido colletto del mantello gli risaliva lungo la nuca. Senza che lui se ne rendesse pienamente conto, il cappellaccio si sollevava dietro e si abbassava sugli occhi. Così messo, mastro Mico a me sembrava meno orco. Allora chiedevo spiegazioni.
“Mammà, cos’è una Rinomata Ditta?”
“Una ditta famosa; una ditta di cui puoi fidarti.”
“E mastro Mico ha una ditta?”105
“L’aveva suo nonno... Anche suo padre... Anche lui, però...”
“Ma suo padre quando morì?”
“Più di trent’anni fa, io non lo conobbi. Aveva una fabbrica di botti di legno. Le vendeva alla nostra Ditta per l’esportazione dell’olio, al tempo che lo si mandava in Francia... Si racconta che guadagnasse molti soldi.”
“Le botti le portava anche al re borbone?”
“Forse.”
“E il re non gliele pagava?”
“Una volta, i re, era come se fossero i padroni di tutto.”
“Quel re l’hanno impiccato?”
“No, figlio, se ne è andato con i suoi piedi.”
“L’ha cacciato Garibaldi?”
“Sì, lui assieme al vero Re d’Italia.”
“E adesso mastro Mico è povero?”
“Non propriamente. È un ricco impoverito. Ma certamente non gli manca il pane”.
“È brutto essere povero?”
L’argomento era doloroso. - “Non devi chiedere queste cose, Paolino... Non le vedi da te?... È brutto... bruttissimo... Ma tu non aver paura. Se vuole Dio, non lo sarai mai... I tuoi genitori, se Dio vuole...”
“Mastro Mico è brutto perché è povero?”
“Anche se fosse ricco, mastro Mico sarebbe egualmente un malvagio...”
“Cos’è un malvagio, mammà?”
“Una persona che non ha carità... Uno che fa il male senza un motivo...”106
Poi continuava: “Tu sei troppo piccolo per capire la vita... Non devi chiedere queste cose... La vita è difficile spiegarla... Quando sarai grande capirai che le cose cambiano intorno a te, senza che tu possa far niente... Noi diciamo il destino, ma non è il destino... è la vita... Allora bisogna rassegnarsi. E’ la volontà di Dio... Principalmente non pigliarsela con quelli che non c’entrano...”
“Sestia ha colpa?”, chiedevo.
“Sestia è buona... un angelo, figlio mio... Solo che il destino...”“Sestia ha un brutto destino?... Il fidanzato non la vuole più?”
“Diciamo il destino, perché non abbiamo studiato. Ma è la vita... Tu però studierai... La vita cambia continuamente, cambia la sorte delle persone... Per esempio... la nonna te lo racconta sempre... Un tale andò a Napoli a imparare a fabbricare cappelli, ma quando tornò, in paese le persone non avevano più la testa.... Vuol dire la fortuna...”
“Ma questo non è possibile, mammà. Le persone, se gli tagliano la testa, muoiono.”
“L’uomo vede e Dio provvede. Le cose si combinano fra loro, senza tener conto del dolore umano... Accade che uno paghi senza averne colpa... Il padre di mastro Mico fabbricava botti di legno e faceva fortuna, ma dopo la gente prese a volere i fusti di ferro, e lui dovette chiudere.”
“E perché non si mise a produrre fusti di ferro?”
“Non era il suo mestiere. I fusti li fanno in America.”
“Qui non li sanno fare?”
“No, qui no... Forse a Genova... Domanda a papà.”
“Don Aniello dice che la guarnizione di un fusto non deve perdere neppure una goccia di petrolio.”
“Sì. Se poi è benzina, è molto pericoloso... Te l’ho detto, devi stare
107
sempre lontano dai fusti di benzina. Ti raccomando.”
“Don Aniello dice che anche la benzina la fanno in America.”
“Sì, credo di sì. La benzina si fa con il petrolio, e il petrolio si trova sotto terra, come le miniere... Qui non ci sono pozzi di petrolio. In America sì.”
“In America si trova tutto?”
“Sì, così dicono.”
“E questa è Calabria Ultra... Don Aniello dice: ‘Ultra eguale a dimenticata da Dio e dagli uomini’... Dice che qui ci sono soltanto briganti ... Anche mastro Mico è un brigante?”
“Che dici, figlio!... I briganti sono finiti, sono cent’anni... Non stare ad ascoltare i giovani del negozio. Parlano male della Calabria perché vorrebbero essere ad Amalfi... Hanno la famiglia...”
“Oh mammà, sai cosa ho visto nel film di domenica scorsa? Anche in America una volta si usavano le botti di legno... Perché lì hanno imparato a fare i fusti di ferro, e qui no?”
“I vecchi dicono che da quando hanno costruito la ferrovia, invece d’andare avanti, qui, stiamo tornando indietro... Veramente, se debbo dire, troppe cose arrivano da fuori... La gente non ha lavoro e così non impara mestieri nuovi... Stiamo qui solo a pagare le tasse.”
“Qui lo sanno fabbricare un treno?”
“Un treno!... Sicuramente no... Forse a Milano... Mah... forse a Torino... a Genova... Non so bene... In Altitalia.”
“Ma mastro Mico non potrebbe fabbricare quelle botti grandi, quelle che abbiamo visto in Sicilia, da zio Bixio?... Non ti ricordi?... Quelle che tanto sono grandi che possono entrarci dentro le persone in piedi... Così farebbe la dote a Sestia, e Sestia finalmente si sposa.”
*<>
<>
108
In appresso, scacciato con gli altri ragazzini dalla piazza Caricatoio a opera del deciso intervento di due guardie, approfittavo della complicità di Sestia per guidare i miei coetanei nel vasto orto di mastru Micu, per giocarvi a palla.
L’orto non era un orto ma un grande spiazzo incolto - quasi un campo sportivo - recintato da un muro perimetrale, all’interno del quale vi era un’antica casa d’abitazione, direi anzi un palazzotto padronale. Anche il termine mastru (o mastro, come si stava cominciando a dire) non era quello appropriato. Si trattava piuttosto di un “don” degradato: quello che sarebbe spettato al predetto Parisi, ove egli avesse conservato i fasti della
Rinomata Ditta Antonio Parisi & Figlio
BOTTAZZI SECCHIE BARILLI
Benemeriti Approvviggjonatori del Real Esercito
e delle Reali Castella della Ferdinandea
Fabbricatori Esclusivi
per le Stive del Principe di Terranova
SAN POLICARPIO DI CALABRIA ULTRA PRIMAcome risultava dalla targa bombata in lamiera nera, vergata con caratteri romani dorati; tutt’attorno un fregio egualmente dorato e in cima uno stemma reale; targa che veniva periodicamente ripittata e rifissata sulla possente colonna a sinistra della porta carrabile, proprio all’entrata dell’orto, e che poteva rimanere lì dov’era, nonostante il divieto di legge, in quanto, sosteneva mastru Micu, da ben tre generazioni i Parisi erano pronti a “spaccare la testa a dominiddio, anche ai Reali
109
Carabinieri”, se qualcuno avesse osato manometterla.Quella pubblica offesa al decoro della Patria, qual io la ritenevo, restava lì - sosteneva invece mio padre - “perché nessuno la vede, essendo il luogo assolutamente fuori mano; e poi, a leggere quell’epitaffio sgrammaticato sei rimasto soltanto tu.”
Quanto al ruolo di Sestia nel farci penetrare nello spiazzo recintato e ingombro di montagne di trucioli e di seghe a nastro arrugginite, esso era minimo, poiché dell’intera famiglia, composta di padre, madre, una vecchia zia e otto fra figli e figlie, soltanto il citato mastro Mico tentava di interdirci l’accesso, svillaneggiandoci e prendendoci a sassate.
Sentivo spesso dire che, tramontata la fabbricazione delle botti, mastro Mico aveva fatto una fallimentare esperienza di “fabbricatore” di cassette per la frutta, e che dopo il fallimento era stato costretto a prendere l’ascia in mano e ad acconciarsi a fare l’umile mestiere del bottaio su commissione.
Che Mastro Mico fosse un bravo artigiano non v’era dubbio. Lo vedevo sbrigare alquanto rapidamente e ottimamente, con l’aiuto di qualche discepolo, nonché di un apparato di seghe speciali e di molta perizia con l’ascia, le commissioni di buttazzi che gli facevano i produttori di vino. E tuttavia era diffusamente mal giudicato, perché non solo era caristusu, ma anche arrogante nelle relazioni commerciali.
Come ho già detto, anche fuori il lavoro mastro Mico era mal visto e paventato. Principalmente per quel passato innominabile che l’ossessionava. Bastava vederselo spuntare davanti, perché riesumassero a livello della coscienza privata e sociale le nostre responsabilità collettive verso l’idea santa di Patria: i Martiri di Gerace, il tradimento dei fratelli Bandiera, il Vallone di Rovito, Carlo Pisacane, i contadini di Sapri, e più lontano il Cardinale Ruffo e i corpi penzo
110
lanti di Francesco Caracciolo e Luigia Sanfelice. Ma anche per la sua arroganza. Suppongo che difficilmente ci si potesse imbattere in un simbolo umano più intonato di mastro Mico a rappresentare la negatività dell’infame dominazione borbonica. In effetti era sufficientemente violento, sufficientemente scostante, sufficientemente sconfitto per offrire una brutta immagine di sé, e di riflesso dei suoi ascendenti politici e dinastici.
Passarono gli anni e facemmo amicizia. L’anno prima era scoppiata la guerra. Facevo il liceo e quell’estate andavo a lezione privata da un bravo studente universitario per riempire i vuoti che la scuola regolare, a causa della guerra, si lasciava dietro. Studiavo l’intero pomeriggio. Scendevo a mare soltanto al tramonto. Oltre tutto mi piaceva. Sulla spiaggia le persone erano poche e il mare, quasi sempre tranquillo a quell’ora, favoriva una bella nuotata. Era proprio l’ora in cui Mastro Mico, finita una giornata di lavoro, usciva dall’orto e si dirigeva, lungo il muro di cinta, a passo lento verso un cespuglio alto quanto una siepe, evidentemente per fare un bisogno. Dopo di che percorreva, sempre lentamente, i venti metri che separavano l’orto dalla riva. Portava con sé un lenzuolo. Qui giunto, si metteva dietro una barca, al riparo da sguardi estranei, e si spogliava lentamente a cominciare dalle scarpe, ancora quelle alte, e dalle calze, che probabilmente erano di lana. Alla fine si toglieva la maglia di lana e le mutande di lana, e infilava il costume. Uno di quelli in uso vent’anni prima. Dopo di che si buttava in acqua.
Ci rimaneva quieto e tranquillo alquanto tempo. Poi cominciava a urlare: “Don Paolino, don Paolino, che ora è?”
Glielo dicevo. Lui tornava a riva, si copriva con il lenzuolo e si toglieva il costume bagnato. Per pudore, non avendo una terza mano,
111
lo faceva con mille contorsioni onde reggere il lenzuolo e contemporaneamente far scivolare l’indumento. Poi, coperto in modo da richiamare il ricordo di Catone il Censore, si sedeva vicino a me e cominciava: “Sapete, don Paolino?…Ma voi fate il liceo, è vero? … Potete capire. Sapete che la guerra noi non la possiamo vincere?”
Cercavo di obiettare, ma lui: “Vedete, l’America non può restare fuori…Si tratta di tempo…L’America vuole aiutare l’Inghilterra. Questo è un fatto. E’ un fatto anche che l’Inghilterra non ce la fa più. L’America è ricca e potente. Quando entra in guerra si trascina dietro l’Australia, il Canada, il Brasile, il Cile, l’Argentina… Manderanno i loro eserciti in Inghilterra…. Milioni e milioni di uomini e da lì passeranno in Germania…Un bombardamento navale su Rotterdam, su Amburgo, su un altro posto…persino in Danimarca e poi sbarcheranno. La Germania non può fronteggiare le flotte dell’America e dell’Inghilterra assieme…”.
Mastro Mico era un analista perspicace e puntiglioso, e io un buon ascoltatore. Parlava di cose che io non sapevo e che neppure immaginavo. La sua informazione non veniva dai libri ma dai giornali. Infatti parlava di tutto, meno che delle cose che si studiano a scuola. Spesso s’era fatto buio e noi eravamo ancora sulla spiaggia, lui a parlare, io ad ascoltare.
*
La tragedia scoppiò nel febbraio 1943. Ai primi del mese, mastro Mico venne a diverbio con don Pasqualino Baggetta, gestore del Consorzio Agrario, il quale aveva messo in esposizione, proprio dinanzi alla porta del negozio, delle botti fatte venire dalla vicina Serra. Si sapeva che su questo punto c’era un vecchio contendere tra i due. Pare - ma la verità non la si è mai saputa - che ci fosse una promessa
112
del negoziante di non guastare la piazza all’artigiano. Però i prezzi del mastro bottaio non tendevano al ribasso, cosicché molti viticoltori erano a fare pressioni su Baggetta perché ne rompesse il monopolio, importando botti da fuori. Come ho già ricordato, nel corso della guerra il vino fu il solo prodotto agricolo - e un bene alimentare - non di-stribuito con la tessera. Il suo consumo era entrato in una fase alta in quanto molto domandato dai soldati di stanza.
In paese, scorreva a fiumi e gli agricoltori e i bettolieri pregavano la Madonna che la guerra (magari senza morti) durasse in eterno. Comunque, l’aumento spropositato del consumo aveva comportato un aumento della domanda di botti, a cui corrispondeva un aumento dei prezzi di mastro Mico. E certamente una maggior pressione su Baggetta perché lo scavalcasse. Alla fine, accusato di connivenza dal segretario del fascio, per non perdere la concessione del lucroso Consorzio, egli si indusse a cedere.
Quando mastro Mico vide quelle novità forestiere, s’infuriò. Penetrò d’impeto nel locale e subissò Baggetta di male parole, ribadendo l’assurda pretesa che soltanto lui, in paese, aveva il diritto di vendere botti nuove. Forse in un altro momento Baggetta se la sarebbe tenuta, ma a quel tempo il Consorzio Agrario era una pubblica istituzione controllata dal fascio, il quale certe private jattanze non le tollerava; specialmente poi se provenivano da chi dava l’impressione di barcollare in materia di fedeltà al Duce e al Re, e faceva supporre pensieri sovversivi, mentre la Patria era in armi. Per tal motivo don Pasqualino, titolato esponente della pubblica e consortile Autorità, intese fosse un suo preciso e istituzionale dovere di placcare l’irriverente energumeno. Tentò di farlo con l’aiuto dei propri dipendenti, ai quali - forse - dette anche l’ordine di pestare l’invasore. Ma il Mastro era parecchio pre
113
stante, così sbaragliò con una sola manata gli assalitori, quindi, estratto un coltello, intimò a Baggetta di farsi avanti.
Quando questi si trovò faccia a faccia con l’amico/nemico tradito – un coltello in mezzo - la situazione si mise a suo sfavore. La dea Paura gli ispirò il consiglio. In appresso la sentii raccontare in mille modi diversi. In realtà nessuno udì gli argomenti con cui don Pasqualino perorò la sua salvezza, ma sicuramente le parole dovettero essere grandemente eloquenti, se la furia di mastro Mico fu dirottata verso un diverso, imprevedibile bersaglio. Infatti, abbandonata la sua preda consortile, l’infuriato mastro percorse, urlando “traditori... traditori”, i venti metri che lo separavano dalla sede della Banca e, penetrato come un rapace nelle stanze interne, alzò il coltello sull’esterrefatto ragionier Pisanti, il nuovo direttore, e glielo conficcò in mezzo al petto.
Il poveretto fu dichiarato salvo solo dopo tre giorni trascorsi tra la vita e la morte, e soltanto per merito del dottor Arrigo, chirurgo emerito, il quale aveva fama di non essere al primo dei suoi miracoli.
*
Nonostante la guerra e le privazioni, nonostante che i bombardamenti si fossero fatti più frequenti da quando gli americani s’erano impadroniti dell’Africa Settentrionale, quell’improvviso volgersi in tragedia di una farsa, che prima divertiva solo gli sfaccendati sconvolse tutti.
La mia famiglia ne fu toccata in modo immediato. Infatti, gli anni erano trascorsi inutilmente: Sestia era ancora zitella. Il suo fidanzato era andato in Etiopia, in cerca di fortuna. Prigioniero o morto, non aveva più dato notizie di sé. Come ricamatrice, Sestia aveva fatto progressi straordinari, ma le commissioni erano poche, e non solo per lei; ormai per chiunque. Non erano sicuramente giorni in cui pensare ai corredi
114
ricamati. Il tempo che trascorreva a casa nostra l’aveva trasformata in una specie di non remunerata dama di compagnia di mia madre.
La coltellata inferta al ragionier Pisanti fece scattare la pubblica commozione. Tutto il paese s’interrogava. Il pubblico dibattito si svolgeva la mattina presto, allorché si riteneva che gli aerei nemici non fossero ancora decollati. Aveva inizio alla Cancella, il mercato coperto, e proseguiva sui marciapiedi del centro. I due fratelli Panajia, Nicola, dottore, e Gaspare, ingegnere, ne erano gli speaker per pubblico riconoscimento. Si trattava di signori molto distinti, e in tutto il resto anche molto riservati. Ultimamente, però, pareva che avessero perduto ogni freno inibitorio. Erano, infatti, sempre in giro a parlare di politica. Proprio tutto il contrario degli ordini mussoliniani pittati sui muri con la vernice: “Taci, il nemico ti ascolta!”
Per salvarsi, quale argomento aveva usato Baggetta in quel momento drammatico in cui stava di fronte a un coltello brandito? Non c’era dubbio alcuno, aveva accusato la Banca di un vero misfatto ai danni di Mastro Mico. “Sicuramente le cassette”, tutti lo giuravano.
Raccontava il dottore Panajia che, circa vent’anni prima, Mastro Mico, vedendo deperire l’avita industria di bottazzi, aveva tentato una diversa attività. Richiamato in guerra, durante i periodi in cui il suo reggimento aveva qualche mese di riposo nelle retrovie, aveva notato che le classiche ceste intrecciate, che gli ortolani usavano per conservare e trasportare la frutta, a volte lasciavano il posto a semplici ma solide cassette di legno. Gli fu facile immaginare che gli esportatori agrumari di San Policarpio le avrebbero adottate volentieri in sostituzione delle ceste di castagno rivestite di tela di sacco, in quanto si prestavano più delle ceste a costruire, nei depositi, delle alte pile di merce.
Già pratico del lavoro del legno, Mastro Mico mise insieme i super
115
stiti capitali familiari, comprò le macchine necessarie e aprì un cassettificio. L’iniziativa ebbe successo. Le richieste arrivavano anche dalle piazze vicine. Naturalmente il prezzo delle sue cassette era diverso a seconda del legno impiegato. Se erano di faggio costavano di più, mentre quelle di pioppo avevano un prezzo più basso, e perciò erano le più richieste dagli esportatori, il cui ricavo non era determinato dalla qualità della confezione, ma da quella del contenuto.
“Ora – diceva sempre il dottore - essendo la nostra zona piuttosto ricca di faggete che di pioppeti, Mastro Mico prese a comprare tavolame di pioppo nei paesi del Cosentino.”
L’ingegner Panajia rimarcava che, dopo la Prima Guerra, l‘immenso bosco, da noi chiamato la Foresta, che faceva parte dell’appannaggio reale, era stato concesso ai fratelli Radler, degli invisibili tedeschi rappresentati sul posto dal ragioner Mittiga. Gli affittuari erano parecchio interessati al commercio del legno di castagno, con cui, fra l’altro, i montanari fabbricavano le ceste per le arance e per i limoni da imbarcare, diretti in Inghilterra e i paesi del Nord. Però il legno di castagno non si prestava alla lavorazione delle cassette.
Insomma, l’iniziativa di Mastro Mico aveva recato pregiudizio agli interessi di quei signori. Ma egli, lo sappiamo, non teneva in alcun conto gli altri. Né, in questo caso, era tenuto a farlo.
Il primo anno, gli affari del Mastro erano andati gagliardamente. Le sue cassette avevano fruttato quasi quanto i barili del nonno. Ma si era trattato soltanto di profitti contabili, perché, quanto a danaro contante, Mastro Mico ne aveva incassato ben poco. Anzi più cresceva lo smercio, più crediti segnava a libro. Pare infatti che chi doveva pagarlo aspettasse l’arrivo di una rimessa inglese o francese; e che questa, prima d’imboccare la via della Calabria, dovesse essere trasformata in
116
lire dalle autorità romane. Pare, inoltre, che dette autorità se la pigliassero molto comoda per quanto atteneva alla trasformazione.
Cosi andando le cose, il povero mastro era venuto a imbattersi in una brutta crisi di liquidità. Non piacendogli mancare di puntualità con i fornitori e con gli operai, il nostro fabbricatore si era presentato in banca a chiedere che il finanziamento di cui già godeva fosse aumentato. Il poveruomo aveva le carte in regola per ottenerlo, e invece gli era stato risposto che, avendo il governo bloccato il credito, la banca era costretta a rifiutare ogni nuova esposizione.
La risposta non era apparsa credibile. Si era preso a sussurrare che la banca veniva influenzata dai Radler, i quali – si sussurrava inoltre – vi depositavano decine di milioni. Altre banche a cui rivolgersi non c’erano. Non restavano che gli usurai. Non fu mai chiarito se Mastro Mico fosse veramente approdato a quella sponda. Di sicuro era avvenuto che, perduta alquanto la bussola, egli se ne andava in giro invocando ad alta voce l’ombra del nonno. E non solo: anche quella di Ferdinando II.
La stramberia aveva fatto scalpore. Tanto che il sindaco del tempo, persona in forte odore massonico, si era sentito in dovere di convocarlo e di redarguirlo severamente. Qualche giorno dopo la commedia si era volta al tragico. A petto di una fattura di chiodi di appena settecento lire, la cui tratta era tornata insoluta al venditore, il Tribunale di Sottovento aveva dichiarato il fallimento della Rinomata Ditta, nella sua nuova, nipotile versione di cassettificio. Da quell’evento erano trascorsi vent’anni e il paese, impotente di fronte al mutare delle umane sorti, l’aveva quasi dimenticato. Il fallito mastro Mico, per campare la famiglia, aveva ripiegato sul mestiere di bottaio. Ma la sua caduta era somigliata a un tonfo; una famiglia, che
117
stava ancora in alto, si era ridotta a navigare alla deriva. Di conseguenza non tutta la testa del povero mastro aveva retto.
Adesso il sangue d’un innocente forestiero metteva il paese di fronte all’esigenza morale di giudicare un suo componente. Persino di fronte alla propria storia collettiva. Non solo quella recente, ma anche quella lontana, con tutta la questione delle botti borboniche e della Rinomata Ditta.
In buona sostanza – spiegava il dottor Panajia - il tentato omicidio di Pisanti era la fine di un capitolo iniziato intorno al 1830, quando i Parisi non fabbricavano ancora botti ma già fornivano barili al Reale esercito, che in paese aveva una fabbrica di salnitro. Bisognava stabilire cos’era stata veramente la Rinomata Ditta, e se mastro Mico dovesse o non dovesse accettare il suo destino. E se potesse, esso Destino, comportare la follia.
“Insomma, Parisi non è il colpevole, ma la vittima”, tuonava il dottor Panajia.
Al tempo dell’avo, la prosperità della Rinomata Ditta aveva superato i cinquanta dipendenti; la stagione felice si era però conclusa intorno alla fine del secolo, allorché l’olio aveva preso a partire per ferrovia, in sicuri carri-cisterna. Ma il vero colpo di grazia le era arrivato qualche anno dopo, quando i fusti in lamiera avevano preso il posto delle botti di castagno. L’olio, che in precedenza aveva rotolato in malsicure botti, da quel momento prese a rotolare per le vie del paese, con moderna svagatezza in fusti di lamiera, fino ad arrivare alla Piccola della stazione, dove veniva pompato nelle cisterne ferroviarie.
Sicurezza certo, ma quanto lavoro aveva perduto la gente? Eziologica e successiva quaestio: in detta congiuntura, cosa doveva e poteva fare la gente, l’indistinta collettività, il paese, a propria difesa?
118
Certamente non mettersi contro il progresso, anche se veniva da fuori. E allora?
“Se ci avessero lasciato le Ferriere della Ferdinandea e l’Officina di Mongiana, quaranta chilometri di qua, i fusti di ferro li avremmo potuti fare benissimo noi. Adesso non più”, proclamava petulantemente l’ingegnere Panajia. Dopo di che voltava le spalle e se ne andava insalutato ospite.
Diversamente dal fratello, conservava qualche paura e faceva il brusco. Non salutare poteva significare che lui, a quella conversazione, non aveva mai partecipato. E sì, perché l’affermazione che aveva lasciato cadere pareva a lui stesso un pericoloso inno al passato. Un passato patriotticamente e anche fascisticamente da dimenticare, e persino ragionevolmente dimenticato.
A spiegarlo era lui stesso. - “Al punto a cui sono arrivate le cose, che senso ha farsene assertore e paladino?... Solo un pazzo come mastro Mico... Ma il sottoscritto, ingegner Gaspare Panajia, Politecnico di Torino, voti 108 su 110, Maggiore del Genio, medaglia d’argento al valore, un ponte sull’Isonzo proprio sotto il martellante fuoco nemico, più volte ferito, pazzo non è”. In effetti non lo era, era anzi l’Ingegnere per antonomasia.
Se ne andava, ma, registrato che attorno non c’erano i noti delatori, tornava sui suoi passi. - “E non venite a dirmi che si trattava di roba vecchia, che non funzionava, perché altrove ha funzionato. Eccome se ha funzionato... Sicuro... e qualche pezzo certamente funziona ancora!”
Il professor Vittorio Russo, che insegnava letteratura alle magistrali, prendeva cappello. “Ingegnere, voi siete pazzo! Allora i Malavoglia dove li mettiamo? Il processo storico, l’avvento del capitalismo, i
119
retaggi feudali…l’inettitudine delle nostra borghesia… Benedetto Croce?”
“Sì, croce e delizia, delizia al cor…” Questa volta l’ingegnere se n’andava veramente. Perdere altro tempo sarebbe stato da sciocchi. Sapeva che la peculiarità dell’argomento costituiva il miglior alibi per la comune voglia di quieto vivere. “Ma che ne sappiamo noi di fonderie!”, e gli astanti avrebbero fatto muro di gomma.
*
Se la gente restava inerte di fronte alle incazzature di Panajia, non aveva tutti i torti. Le idee erano sommamente confuse in quella materia. Fare e disfare era compito dei governanti. Era soltanto puerile - sostenevano i benpensanti - star dietro a Panajia, il quale era indubbiamente un ottimo ingegnere, ma quanto a presunzione, era meglio non parlarne. Si ripiegava, ovviamente, sull’avverso Destino. Perché, oltre al destino dei singoli, c’era un destino delle collettività, dei paesi e paesini. A tal riguardo, anche se nessuno era così retrogrado da parteggiare per mastro Mico a proposito delle botti, le quali evidentemente non potevano reggere il confronto coi fusti, molti dubbi sopravvenivano a proposito delle cassette, nonché sulla funzione della banca.
“Ma quale destino!…Il governo…il governo…”, urlava don Nicola, il dottore.
“Sì, dillo forte, così finisci al confino.”
“Ingegnere, Ingegnere...”, chiamavo. Mi appostavo con Dino all’angolo del Caffè Ritorto, aspettandone il passaggio.
Lui si voltava spaurito, ma vedendo che ero soltanto io tornava a sorridere.
“Ah, sei tu Paolino...E a scuola...?”
“Ingegnere, cos’è ‘sta Ferdinandea, che voi dite...?”120
“Come?...Non sai la Ferdinadea?...Un posto bellissimo...I funghi...Pochi chilometri di qua...Don Genso non ti ci ha mai portato?”
“Lo sapete, papà è forestiero…I posti non tanto li conosce…Ma voi parlavate di una fabbrica...?”
“Caspita, e che fabbrica!...Un fonderia in piena regola… Migliaia di operai, un paese appositamente fondato. L’avevano fatta i borboni, ma poi il governo italiano la portò a Terni...Forse funziona ancora...”
“E poteva fare i fusti?”
“Questo a Mongiana. Certo. Alle officine di Mongiana, con qualche ammodernamento…”
“E perché le hanno chiuse?”
Adesso, a rispondere era il fratello. Le questioni più squisitamente politiche toccavano a lui, che non si capiva bene se fosse un comunista. Certamente era un sovversivo convinto, anche se poi era molto guardingo e il sabato, sotto la giacca, indossava la camicia e la cravatta nera.
“E perché?...perché!...Allora la storia di Brenno non l’hai studiata?...Vae victis!...”
“Ma siamo italiani, Ingegnere!”
Eravamo in parecchi a voler capire cosa era successo al paese. Qualcuno, dopo aver consultato un libro di storia, prese a spiegare che il governo era stato costretto a chiudere la fonderia e la fabbrica perché i filoni carboniferi della vicina Agnana si erano esauriti. Un altro, però, lo rimbeccò, dicendo che ciò non poteva essere vero, perché proprio in quello stesso momento, ad Agnana, una cinquantina di minatori stavano spalando carbone. Chiunque di noi avesse voglia di controllare, bastava che si fermasse qualche minuto al bivio della 121
provinciale per veder passare i camion che trasportavano il minerale in stazione.
“Sì, è vero – gracidava Panajia – sono filoni poveri, antieconomici. Ma non mi risulta che a Terni esistano dei filoni ricchi, anzi che esistano delle falde carbonifere.
Io, Piero, Dino, Gustino e tutto un intero manipolo di ragazzi che non avrete modo di conoscere, in quanto, per loro naturale modestia, si sono sottratti alla rappresentazione, continuammo a seguire il gran dibattito mattutino.Accertatosi che non c’erano spie nelle vicinanze, l’Ingegnere riprendeva l’argomento. - “ Tutti italiani? Lo credevo anch’io...Ho dato il mio sangue… Tre anni di guerra, mille giorni a pericolo di vita, due ferite, una medaglia d’argento...Ma, poi, se studi i fatti presenti e passati, ti accorgi... Ti accorgi che...”
“Di cosa, Ingegnere?”
“Di cosa!...di cosa!”, urlava. “Quando sarai grande, capirai. Non è cosa da ragazzi...Poi...quando...”
“E la banca, Ingegnere...?”
“Tutto pare aver congiurato contro...Allora non hai capito niente…La banca… la baaannncccaaaa…”
“Sta cazza di banca…”
La gente aveva un moderato timore di Dio e delle sue giuste punizioni; aveva anche un certo qual timore dell’arciprete, che ogni domenica ricordava ai fedeli che chi ama i soldi non ama Dio; ma quelli erano timori domenicali, che non spostavano di un ette le coscienze e i comportamenti feriali. La banca, invece, incuteva una paura concreta, reale e feriale a chicchessia, anche alle persone più sveglie e pratiche della vita. Chi avesse per caso bisogno della banca, si doveva consi
122
derare un uomo finito. Essa era un’autorità severa con i non abbienti, questo lo sapevamo. Ciò di cui andavamo prendendo coscienza soltanto in quel momento era la sua insospettabile fellonia. Qui il governo non c’entrava; il terreno era libero. Anche se fosse arrivata una spia, l’argomento non era di quelli proibiti. D’altra parte, se fosse stata un’altra banca - una di quelle banche milanesi arrivate a Reggio, come diceva papà, per intascarsi le rendite agrumarie - qualche prudenza non sarebbe mancata. Ma per questa banca tutta meridionale, no. La gente l’aveva proprio sullo stomaco e la criticava. Era un’istituzione arcigna e avida, mancante di qualunque socievolezza e, diremmo oggi, di democrazia. Dava con due dita e riprendeva tutto con mano perfida, e pure l’aggiunta. Anche i ragazzi l’odiavano.
*
“Sta stronza di banca…Io non la posso vedere…”
“Neppure io”.
“Ci ha rotto a tutti.”
La cosa ci cresceva nell’animo. Le bombe nemiche, le sconfitte su tutti i fronti, lo sfollamento, la paura, la carestia, l’inganno mussoliniano, l’immiserimento di tutto ci conducevano a mettere inconsapevolmente una pietra tombale su molti miti del passato. Tutto era divenuto falso e miserabile. E poi si sa, i ragazzi sono meno tolleranti, accomodanti, prudenti degli adulti. Personalmente, poi, mi sentivo dentro un bisogno di rompere l’attesa, avevo paura che domani Vitulia potesse non volermi più.
“No, la Regia Banca, proprio non la posso vedere…E poi quella faccia di culo del cassiere Murdocca…Ce l’ho sullo stomaco, ecco…”
“Per il momento te lo tieni…”
“Mi tenarrìa ‘a cugnata, chilla bonazza… Illa sì …ma illu!… La
123
prossima volta che viene al campo e lo vedo tifare per la squadra dei militari, gli sparo una pallonata in mezzo a quella faccia di culo, che porta sfortuna…”
“Sì, ‘nci fai na carizza…”
“ No, ‘nci sfasciu i vitrini, si vo’ mu sai…”
Gustino voleva riferirsi alle lenti, ma ci fu chi pensò alle solenni e costose vetrine della Banca, da poco ripristinate dacché lo spostamento d’aria provocato dall’esplosione di una bomba le aveva mandate in frantumi. A partire da quel momento, esse divennero il nostro obiettivo militare. Bisognava rompergliele, e poi rirompergliele ogni volta che le avessero rimesse nuove. Dovevamo, quantomeno, piegare quelle facce di culo dei dipendenti, fino a portarli alla rassegnazione e alla pubblica resa: alla vergogna di quattro fogli di compensato al posto dei vetri smerigliati.
I miei amici mi fecero l’onore di considerami il più ardito fra loro, oltre che un abile fromboliere. “Scegli tu, chi deve venire con te.”
Logica avrebbe voluto che scegliessi Dino, con la fionda più bravo di me. Ma il fatto che il padre fosse, per pubblico riconoscimento, un socialista, mi indusse a temere che, se ci avessero scoperto, la sua colpa sarebbe stata strumentalmente estesa all’intera famiglia. – “Faccio venire Michele ‘u Ndiano e Filici Tri Sordi. Sono bravissimi e non corrono il pericolo d’essere esclusi da tutte le scuole del Regno”.
Infatti non frequentavano la scuola, ma una bottega d’artigiano. Erano coraggiosi, affidabili e anche fra i più destri della mia ruga in materia di sassate.
La sera successiva, ci appostammo fra i muri in costruzione della nuova clinica Arrigo e aspettammo che scoccasse l’ora fissata. Era febbraio e si fu d’accordo di procedere al tramonto. In controluce,
124
difficilmente ci avrebbero riconosciuti. A quell’ora gli impiegati erano ancora lì, a fare i conti, e l’alamarato usciere non aveva ancora abbassato le saracinesche. Per godersi la scena, gli altri avrebbero finto una gara a tiro a segno, al chiosco che un’impavida zingara teneva aperto in Piazza dei Martiri.
Alle quattro e un quarto, ora legale, tre sassi ben scelti fendettero l’aria. Fu un capolavoro, uno vero schianto. La cristalleria affumicata, con al centro la cifra della Banca graziosamente intrecciata in un arabesco, venne giù in tre secondi. Per un’intera settimana i carabinieri, i vigili urbani, le guardie di finanza cercarono confidenze in giro. Nessuno fiatò.
*
I vetri furono rimessi: due metri di finissime lastre, su tre porte. I vigili urbani, i carabinieri, le guardie di finanza, i pompieri e, adesso, persino la truppa presidiavano l’intera zona. Era impossibile ripetere l’impresa. Eppure questa era la sfida. Bisognava farlo, e farlo anche a regola d’arte, questa la sfida per la ruga.
Via Speranza, partendo da Piazza Caricatoio, spartiva in due l’omonima ruga per tutti i suoi trecento metri. Andava, quindi, a sbattere contro il muro di cinta della Villa Sansalone, che occupava tutta un’area compresa tra il Corso e la Via Marina. Siccome, superata la Villa, Via Jonio appariva la continuazione di Via Speranza, era facile intuire che i due vicoli fossero, un tempo, un’unica via, lunga sei o settecento metri – forse la strada centrale della Marina al tempo dei Borbone.
La villa era una costruzione nuova; nuova per lo stile e per l’insolita ubicazione in un rione chiaramente ottocentesco, mentre, in paese, i nuovi insediamenti abitativi si stavano sviluppando nella cosiddetta Zona Industriale, che al tempo della mia adolescenza designava
125
un’estesa ruga in formazione. Ma poi non tanto nuova, perché risaliva certamente a una ventina d’anni prima. Il professor Sansalone era stato il più apprezzato degli oculisti napoletani della generazione di mio nonno. Con i guadagni della professione aveva potuto costruire una lussuosa dimora per la figlia Adele.
Al tempo del racconto il Professore era ancora vivo e vegeto, viveva a Napoli ed era ancora attivo come professionista, anche se aveva lasciato la cattedra. Veniva in paese soltanto una volta al mese, in visita alla figlia. Era questa l’occasione buona per tutti coloro che avevano problemi agli occhi. Il suo arrivo in paese era infatti atteso, cosicché aveva appena il tempo di scambiare un bacio con la figlia, il nipotino e il genero ché subito doveva correre in ospedale a ricevere i pazienti. Se doveva operare, si fermava più di un giorno, o veniva apposta. Era il medico meno venale del mondo. Chi poteva lo pagava, e chi non poteva non solo non pagava, ma spesso riceveva un aiuto. Nei racconti familiari, era anche l’amico inseparabile di zio Generoso, con cui condivideva la cattiva nomea di femminiere.
Il risvolto romantico di tale inclinazione era proprio la figlia Adele, nata da una relazione con una ballerina dell’avanspettacolo e affidata a una famiglia di contadini delle Serre.
Quindici anni dopo, il su nominato Professore, andandosene a caccia con il su nominato zio Generoso, incontra una fanciulla che regge in capo un fascio di rami secchi. La guarda per caso e si accorge che la fanciulla è il preciso ritratto di sua madre. Superfluo raccontare il resto. Un romanzo di Mastriani? La verità? Il romanticismo ne fa una cosa sola, ed è bello proprio perché confonde la realtà con le fughe dalla realtà. In paese, la villa era l’illustrazione migliore della ricchezza proveniente dall’esercizio di una libera professione. L’abitazione
126
era un edificio belle époque. Il vasto giardino che la circondava era una splendida confusione di aiuole tenute a prato inglese e di palme tripoline che, in numero di tre, erano piazzate al centro di ciascuna di esse. La somma di undici aiuole dava 33. Molto bella, e sicuramente non allusiva, era l’inferriata che dava sul Corso, tutta coperta di verdi e odorosi rampicanti.
Del mio personale arruolamento nei ranghi della ruga era stato pronubo mastru ‘Ntoni Romeo, che aveva la sua bottega in Via Amalfi, non lontano dal portoncino di cui ci servivamo noi familiari per entrare e uscire di casa, evitando così di aprire e chiudere il pesante portone, all’ingresso del cortile. La mamma mi raccontava spesso che da bambino l’asilo non mi piaceva. Ricordo vagamente che difendevo la mia indipendenza con calci e morsi. La cameriera si rifiutava di accompagnarmi.
Sempre secondo il racconto materno, le poche volte che ci misi piede fu perché mi ci portò papà. Ma fu proprio papà a decretare la resa familiare: “Non è cosa. Lasciatelo stare…” Mi piaceva, invece, la bottega di mastro ‘Ntoni. Le volte che ci passavamo davanti m’incantavo a guardare. Al che il mastro, evidentemente per usare una cortesia alla famiglia dei suoi ricchi vicini, si offrì d’intrattenermi tutte le volte che volessi andare in bottega. E io, non avendo ancora gli anni per andare a scuola, ci passavo mattina e pomeriggio. Mastru ‘Ntoni era ormai anziano e non aveva più la forza di reggere un’intera giornata di fatica, né di affrontare i lavori più pesanti. In pratica la bottega restava per lunghe ore nelle mani di suo figlio Peppe, il quale non era un artigiano dello stesso calibro del padre. D’altra parte – lo compresi in appresso - la gente non accettava più il disegno e lo stile del mobile artigianale. Lo considerava rozzo e contadinesco, insomma non sufficientemente
127
borghese per poter essere accolto nelle case agiate. Cosicché i Romeo s’erano rassegnati a fare dei lavori ripetitivi, specialmente infissi.Mastru ‘Ntoni non si lamentava della nuova situazione. Era stato in America e sapeva bene quali scarpe usava il progresso per camminare. Di conseguenza non rifiutava le commissioni di porte e finestre, ma, ritenendole poco impegnative, le faceva sbrigare al figlio, il quale, se gli davi un modello, lo ripeteva pedissequamente. Peraltro la produzione di infissi non era cosa che non richiedesse una buona professionalità, a cominciare dalla scelta del legname, fino alla riduzione dei tavoloni in tavole della misura desiderata; cosa che si faceva con l’aiuto di un enorme cavalletto piazzato in mezzo alla strada. Brandendo un’enorme sega con una grande lama al centro, i discipuli lavoravano ore e ore per ridurre il tavolone in tavole. Io stavo ad ammirarli incantato, sognando il giorno in cui mi avrebbero messo a segare, ma perfettamente consapevole che si trattava di un sogno, perché immaginavo che bisognasse possedere un’attitudine sovrumana per fare una cosa del genere.
Mastro ‘Ntoni, che aveva tracciato con la speciale matita dei falegnami le linee del primo taglio, ora cominciava a specificare i dettagli. Rivedo, come in un vecchio film girato al rallentatore, il gesto con il quale si liberava della sua eterna giacca grigio chiaro, fatta di un tessuto stranissimo e come inamidato - forse seta industriale americana. E i gesti successivi, sempre identici, per togliersi prima i polsini e poi il colletto, anche questi inamidati, ed infine la cravatta nera, cosa che faceva allargando la parte legata, senza snodarla. In gilè e con le maniche rimboccate, mastro ‘Ntoni mostrava impudicamente i suoi anni: la schiena íngobbita dall’età, la pelle cadente sotto il mento e sotto l’esile ossatura dell’avambraccio. Si toglieva gli occhiali e prima di riporli nell’astuccio ne estraeva un altro paio. Poi, come un prete
128
sull’altare che ripete sempre gli stessi gesti, lentamente protendeva la mano destra all’indietro e prendeva, senza guardare, le squadre e le righe che il figlio, stando un passo indietro, gli porgeva. Procedeva con tale sicurezza che, rileggendo nella memoria i suoi movimenti lenti ma sicuri, mi vien da pensare che la finestra, o la porta o la persiana da costruire, fosse già perfettamente disegnata nella sua mente.
*
Lasciai la bottega ai tempi della scuola elementare per divenire un attivo dirigente del branco rugaiolo. Tornato da scuola, avevo appena il tempo di mangiare che già correvo verso i compagni. All’origine s’indossavano divise da antico guerriero, fabbricate con cartoni e pezzi di latta. Le armi erano alquanto disuguali. I più disponevano di un ramo approssimativamente dritto e pazientemente ripulito della corteccia, altri avevano spade crociate fabbricate da un falegname in vena di munificenza. Il sottoscritto, nel ruolo di Masaniello, Duca d’Amalfi, innalzato lo stendardo con la Croce di Sant’Andrea, guidava pe-rigliosamente i Cavalieri di Malta fino a una piattaforma di cemento, che era stata costruita durante la Grande Guerra per l’attracco degli idrovolanti. Da questo spalto avanzato sul mare, il predetto Duca lanciava feroci sfide ai Pisani, vituperio delle genti.
In verità i Pisani non giungevano dal mare, ma dalla Zona Industriale, cioè dalla parte opposta del paese. A quel punto bisognava abbandonare gli elmi e le spade all’uso dei grilli, che popolavano la spiaggia, e farla a sassate. Proprio con i sassi veri, quelli che, quando s’incontravano con la capoccia, pretendevano l’intervento del dottore Bosco e dei suoi paventati punti.
Meno temibili e meno temuti erano invece i signurini, cioè i figghi di gnuri, ché bastava alzare il braccio simulando una sassata, per
129
vederli correre via a perdifiato. Fra costoro Nandu ‘u Siccicella, il fratello maggiore di Vitulia, era sicuramente il più veloce.
La fine della mia militanza in ruga avvenne con onta e disonore.
Via Speranza era il luogo in cui si confondevano le classi, specialmente a livello adolescenziale. Certo non mancavano i concetti di ricco, di povero e di chi sta in mezzo, né veramente ricco né veramente povero. Sicuramente non era povero don Ciccio Trombetta, ma neppure ricco. Il suo vero cognome era Lucà. Trombetta gli veniva dal fatto che accordava i pianoforti suonando un piccolo piffero e che in bottega teneva oltre che spartiti, chitarre e fisarmoniche, anche trombe e tromboni. Il terzo figlio di don Ciccio si chiamava Gaetano, in onore di Doninzetti, ed era la disperazione della famiglia, diversamente da Vincenzo (in onore di Bellini) e di Gioacchino (in onore di Rossini), entrambi a Napoli a studiare piano nel celeberrimo Conservatorio di San Pietro a Maiella.
Tra l’orto di don Ciccio e le finestre della casa dei Burranca correva via Speranza. Il vecchio maresciallo Burranca era morto prima della guerra d’Africa. Gavino e sua madre, donna Rosina, conducevano una vita stentatissima, in quanto le cure per Gavino, ex maestro elementare, tornato dall’Africa con la sifilide all’ultimo stadio, erano molto costose.
Il paese non era pietoso. Il povero Gavino, in preda alle allucinazioni, era divenuto lo zimbello di tutti. Gaetano, detto Tano, era fra quelli che più inferocivano. Poco dopo le sette del mattino, si piazzava al centro dell’orto paterno e faceva tre squilli con una tromba sfiatata. Al che Gavino si alzava, indossava la divisa da tenente, metteva il cappello in testa e la sciarpa azzurra a tracolla. Così rivestito si affacciava alla finestra. Appena Tano lo vedeva comparire, si metteva a suonare,
130
come sapeva e come poteva, l’alza bandiera. Uno di noi, accorso alla bisogna, provvedeva a innalzare la bandiera su un palo appositamente piantato lì. Al quel punto, Gavino sguainava la sciabola e faceva il presentatarm.
Finché quella mattutina sceneggiata fu vista e goduta da qualche abitante della ruga, ci furono soltanto dei mormorii di disapprovazione da parte delle persone dabbene. Poi, quando il pubblico cominciò a farsi numeroso, mastro ‘Ntoni Romeo, che era fratello di donna Rosina e quindi zio di Gavino, s’incazzò e chiamò i carabinieri. Tano finì in gattabuia per qualche mese e il povero Gavino in manicomio, dove morì meno di un anno dopo.
Il sottoscritto era coinvolto, come tanti altri, in quanto spesso aveva provveduto ad alzare la bandiera. Debbo, però, dire a mio onore che quello stupido scherzo alle spalle dell’infelice Gavino mi rivoltava lo stomaco. La vergogna di aderire o sottostare ai bassi istinti del branco - vergogna che mi aveva afferrato in corso d’opera - fu ben più pesante del ceffone piazzatomi in pieno volto, e debbo dire con singolare e imprevista destrezza, da mia madre. Ma il capo della squadra, fino a quel momento, ero stato io. Ero stato io in mille occasioni a pretendere l’obbedienza ai principi che la consuetudine dettava. E uno di questi diceva che era possibile dissociarsi dall’azione prima di partire, ma che una volta in azione non era più concesso di cambiare idea.
*
Mi dimisi da capo con un’aperta spiegazione. Il comando passò a Fabio Sava, un forestiero integrato. La famiglia veniva dal Veneto. Era giunta in paese dopo la disastrosa alluvione del 1931, al seguito di non so quale impresa padana, che aveva appaltato i lavori di ricostruzione del maestoso ponte sul torrente Lordone, che la piena aveva porta
131
to via. Don Aldo, finiti i lavori con l’impresa maggiore, era rimasto in paese per costruire, come appaltatore in proprio, la nuova chiesa madre. Portato a termine questo lavoro, aveva vinto l’appalto per la rete fognante. Siccome era una persona onesta e capace, in appresso erano arrivate altre commissioni pubbliche e private, così da indurlo a insediarsi definitivamente qui con la famiglia. In effetti con l’appaltatore Sava il paese scopriva le virtù edilizie del cemento armato, raramente impiegato in precedenza a causa dell’impreparazione delle maestranze.
Fabio aveva la mia stessa età. Frequentavamo la stessa classe ed eravamo divenuti grandi amici, credo perché ripetevamo entrambi la mentalità dei nostri rispettivi padri, che erano degli imprenditori agiati, non dei ricchi redditieri. Fabio era un moro per tutti gli aspetti della persona - dai capelli riccioluti e nerissimi, agli occhi mesti e carezzevoli; la figura agile e scattante, i muscoli di ferro – insomma era tutto moro, meno una cosa: aveva la carnagione bianca come la neve.
Era un ragazzo calmo, ragionevole, beneducato. Quando una delle imprese, che noi ragazzi della ruga andavamo progettando, non gli sembrava moralmente accettabile, diceva francamente: “Non ci sto”. Ma guai ad offenderlo. Il ragazzino dolce e giudizioso diventava una furia. Lui, che era alto sì e no un metro e sessanta, riusciva a battere ragazzi alti e forti quanto un corazziere. Nella nostra azione contro la Banca, ebbe un ruolo decisivo. Sapemmo dalla sua stessa bocca che il padre doveva correre a Roma tutte le volte che gli servivano i soldi per portare a compimento un’opera, perché la Banca si rifiutava di fargli tutto il credito necessario. E ciò, più che un danno, era un’offesa per una famiglia onesta come la sua.
Il cantiere di fronte era sorvegliato a vista. Impraticabile l’idea di
132
scavalcare la staccionata senza esser veduti. Solo i passeri e, forse, i piccioni non provocavano militari attenzioni. Ma Fabio conosceva un percorso alternativo: la nuova fognatura, la cui costruzione era stata interrotta e mai più ripresa. Così com’era, offriva un corridoio sotterraneo al gioco dei ragazzi del paese.
A causa della guerra, anche la costruzione della clinica Arrigo era rimasta ferma alle strutture murarie. Una volta scavalcata la recinzione di tavole costruita dai muratori, era aperta a chiunque, perché mancavano le porte e le finestre. Tra le finestre dell’edificio e le tre vetrine della Regia Banca, che davano sul Corso, c’era una distanza di non più di quindici metri.
“Almeno le tre sul Corso…”. Mi coricai con quel pensiero. La mattina appresso scesi in paese. In un ripostiglio conservavo sette o otto forcelle ricavate da un ramo di elce e perfettamente bilanciate, che nel corso degli anni avevo avuto in dono da qualche pastore. Nel garage trovai una camera d’aria da camion sufficientemente larga. La ritagliai a dovere e fabbricai tre fionde di altissima qualità. Andai a provarle sulla spiaggia. Non sbagliavano un colpo. Corsi a chiamare Michele e Filìci e le riprovammo assieme. Meglio di quelle non ce n’erano al mondo.
Arrivò anche Fabio. Ci ripetemmo mentalmente il progetto. Ciascuno scelse dieci sassi marini, i più acconci a volare e colpire. Una volta fatta la scelta, riponemmo tutto sul fondo di una vecchia barca in disuso. Saremmo passati il pomeriggio a prenderli.
Prima che scoccassero le quattro eravamo a ‘i gghiandari. Fabio ci ripeté il piano da eseguire. In vigenza dell’ora legale, gli impiegati della Banca non smontavano dal lavoro prima delle cinque. Alle quattro e venti uscimmo dal settimo tombino che ricadeva nel recinto
133
predisposto dai muratori. C’infilammo non visti nell’edificio in costruzione, salimmo i gradini ancora grezzi, e raggiungemmo il balcone più prossimo alle vetrine della banca. Rimanemmo, però, lontani dall’apertura, in un angolo morto sia per chi guardasse da sotto, sia per chi guardasse dai balconi di fronte, quelli del palazzo del marchese Cicero, che rappresentavano il pericolo maggiore, in quanto la casa era piena di camerieri.
Ciascuno di noi edificò un sedile con dei mattoni forati e così, chiacchierando sottovoce e con il cuore in gola, aspettammo le cinque meno venti, prefissate come ora x. Per comprimere il battito del cuore, spesso, ci alzavamo e aspiravamo ed espiravamo profondamente. Intanto recitavamo a bassa voce, a mo’ di tranquillante ante litteram, i versi della Cavallina storna, che Fabio ci aveva imposto di mandare a memoria, dopo averne fatto tre copie con la macchina da scrivere del padre.
I secondi trascorrevano lentamente. Così fermo, io avvertivo una sensazione di freddo. “E’ la paura. E’ mai possibile che t’impressioni per una cosa da ragazzi?”
Il cielo era terso e il pomeriggio luminoso, tuttavia l’ombra era già lunga e il trovarci contro sole avrebbe nascosto la nostra identità. L’ora si avvicinava lentamente, ma all’improvviso ci fu un mutamento. L’alamarato usciere della Banca uscì prima delle cinque, con in mano l’asta per abbassare le saracinesche. Nacque il dilemma se agire immediatamente, sotto gli occhi di don Ciccio, oppure rimandare a domani.
Don Ciccio si spostò sulla strada che faceva angolo, per tirare la saracinesca a due porte laterali non comprese fra i bersagli. “Via”. Innescammo il primo sasso, tendemmo le fionde. Fu un capolavoro,
134
un crollo irreparabile. I vetri affumicati vennero giù in tre secondi.
Già avvertito dall’evento precedente, don Alessio, il proprietario del Bar Adua, con uno straccio ad asciugarsi le mani e un grembiule intorno alla vita, apparve sulla porta urlando. Dei pompieri che parlottavano fra loro, seduti al posto di guida di una vecchia autobotte, non seppero far di meglio che avviare il motore con la manovella. Una pattuglia di militi fascisti corse verso di loro. Don Ciccio, l’usciere, lasciata precipitosamente cadere la saracinesca che stava tirando rispettosamente giù, sull’altra via, apparve sull’angolo, con l’asta in mano, come un oplita sconfitto.
Qualcuno degli avventori del bar, che giocava a tressette nel retrobottega, venne fuori. E venne fuori, passando sui vetri rotti, quella faccia di merda del cassiere.
Don Alessio, che subito intuì da dove proveniva l’aggressione, corse verso l’apertura centrale dell’edificio, tirandosi dietro i clienti, i pompieri e i militi. Ma non poterono scorgerci. Per consiglio di Fabio non avevamo commesso l’errore di attraversare i pochi metri di terreno scoperto tra l’edificio in costruzione e il tombino. Restammo nell’edificio per circa due ore, nascosti dietro il lucernario delle scale, per tutto quel tempo recitando i versi di Pascoli, a titolo di tranquillante. Andammo via, sempre attraverso la fogna, solo quando l’agitazione ebbe fine e si fu fatto buio pesto. Un quarto d’ora di corsa carponi, al lume di una torcia elettrica, e fummo di nuovo a i ‘gghiandari, dove Fabio ci attendeva più morto che vivo.
*
Mentre Mastro Cicciu ‘u Pàsseru provvedeva a sostituire con dei fogli di compensato le ampie vetrate bancarie, qualcosa della bravata trapelò. La prima reazione arrivò da fuori. Il cugino Civale, consigliere
135
d’amministrazione della banca, scrisse a papà una lettera raccomandata, in busta sigillata con la ceralacca, in cui diceva come fosse stato sommamente spiacevole l’apprendere ciò che si sussurrava. Sperava che non fosse vero. Comunque, dati i meriti acquisiti dall’Istituto presso le popolazioni meridionali, egli mai e poi mai avrebbe immaginato un fatto del genere. Papà ne ridacchiò, invece la mamma ne fu seriamente preoccupata: – “Questo brigante finirà in galera…” Subito dopo anche papà dovette prenderla sul serio. Fu, infatti, chiamato dal Procuratore del Re. Per fortuna, questi era un suo amico e spesso nostro commensale. Dall’incontro scaturì una specie di perdono per me e la degradazione della vicenda a ragazzata, in cambio però di un solennissimo rimbrotto, e magari – sottinteso – di una dose di solennissimi ceffoni.
Ma ciò su cui la Giustizia si era mostrata disposta a sorvolare, parve non fosse perdonabile da parte della Casa del Fascio, la quale volle punirmi diversamente. Ma forse, attraverso me, si voleva arrivare a incolpare Dino, che i fascisti immaginavano l’istigatore se non il responsabile del misfatto, essendo suo padre uno di quelli che non si curavano di nascondere la propria soddisfazione ogni volta che il Bollettino di Guerra annunziava una batosta militare.
Comunque la pensassero, sta di fatto che fui incolpato d’aver compiuto “un’azione da masnadiero” e patriotticamente imputato di sedizione sovversiva. Il povero mio padre cercò di muovere tutte le pedine massoniche che poteva, ma non ci fu verso. A causa delle periclitanti sorti della guerra, il fascio si era indurito. Il comando locale era passato in mano a gente nuova. Niente più facce ben rasate di ricchi proprietari, ma volti scuri di ex subalterni in fase ascendente. Venni severamente giudicato. Volevano sapere il nome dei miei
136
complici. Per averli usarono le blandizie, ma continuai a sostenere ciò che mio padre mi aveva suggerito, cioè che ero un ragazzo studioso, come attestava il mio curriculum scolastico, e che, come tale, non rientrava nei miei pensieri neanche lontanamente l’idea di rompere i vetri a chicchessia. Per fortuna, nessuno osò picchiarmi, come temevo. Fui tuttavia condannato a essere pubblicamente degradato da capo squadra a semplice avanguardista moschettiere.
La cerimonia si svolse in un plumbeo sabato fascista del febbraio 1943. In Piazza dei Martiri, gli Avanguardisti vennero schierati sul lato maggiore, i Giovani Italiani del Littorio sul lato destro e le Giovani Italiane sul lato sinistro. Sul lato opposto al maggiore c’era la formazione dei Balilla moschettieri (i Balilla semplici e le Piccole Italiane furono lasciati a casa); il tutto in un ordinato e spazioso quadrato. In mezzo stavano il Segretario, il Capitano Fimognari e altri capi; in seconda linea, a cavallo, l’avvocato Furci, ispettore di zona, e altri cavalieri di pari rango.
Affinché non mi sottraessi alla cerimonia, guastandogli la festa, sin dal primo mattino erano arrivati nella casa di campagna, dove eravamo sfollati, Ciccio, l’Asu ‘i Coppi, e Vici ‘u Cagnolu, entrambi barbieri, in uniforme della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i quali, tra mille scuse -“Noi non abbiamo nessuna colpa... Si vede che sono impazziti... Un ragazzo come si deve...”- m’avevano scortato (per fortuna in bicicletta) fino alla Casa del Fascio e poi vigilato a vista.
La coreografia messa in piedi rappresentava soltanto la parte umiliante della cosa; la parte veramente preoccupante stava invece nella minaccia di un’espulsione da tutte le scuole del Regno; minaccia appena sussurrata, ma alquanto realistica a causa della grande importanza che i fascisti locali davano all’accaduto.137
Anche se in appresso qualche volta mi è capitato di ricordare il passaggio solo per riderci sopra, debbo ammettere che vissi uno dei momenti più drammatici della mia vita, con Celeste sommessamente piangente, mia madre a mordere un fazzoletto, la nonna pietrificata, papà muto e inebetito, a mescere bicchieri di ottimo vino ai due ceffi, mentre io – racconta Celeste - sfigurato dal tremore represso, mi consegnavo senza fare resistenza.
La mamma volle essere presente all’oltraggio. Ricordava spesso che decisero di presentarsi in piazza parati con i vestiti migliori. Lì, si raccolsero intorno a Celeste piangente, sotto al monumento ai caduti, su cui, ironia delle cose, il primo nome del lunghissimo elenco scolpito nel marmo era quello di suo fratello Tommaso.
“Non piangere”, mi dicevo e stringevo i denti. Data la risibilità della cerimonia, la sola cosa importante era che resistessi alle lacrime.
Mi avevano messo in fila al solito posto: il primo a destra. Gli amici e i compagni sfottevano sottovoce:- “E adesso come fai, ché ti sei giocata la carriera?” …”Sei fottuto. Hai perduto la pensione”, et cetera. I minuti trascorrevano lancinanti. Mi pareva mille anni che tutto finisse. I capi indugiavano a dare disposizioni. Sentivo le budella bruciarmi. Era prossimo il momento in cui due compagni mi avrebbero condotto al centro del quadrato. Pregai: “Signore, aiutami”.
Appena dietro di me, ‘u Pinu du Broccia, uno della mia ruga, sussurrò: “Vogghiu propriu u viju cu’ su’ ‘sti du ’ nfami”.
“Giusto,” pensai, “non finisce qui. Chi farà questo, domani certamente gli finisce male”. Invece, finì bene. Inattesi deus ex machina, gli angloamericani decisero la situazione. Infatti, mentre mescolavo preghiere e pensieri di vendetta, sopraggiunsero due cacciabombardieri, dei Mitchell, facilmente riconoscibili per la loro strana forma.
138
<>Forse dall’interno delle carlinghe, i piloti notarono un assembramento. A uno straniero lo schieramento poteva apparire una parata di truppe. Andarono un po’ avanti, poi tornarono e sorvolarono la piazza a bassa quota. A quel punto qualcuno scappò. Il quadrato vacillò paurosamente. L’avvocato Furci, volendo probabilmente mettere una toppa sulla mancanza di mussoliniano coraggio, prese a ordinare la ritirata, ma il segretario del fascio pensando forse che la ritirata sarebbe stata una magra colossale, si oppose spavaldamente. Cominciarono a litigare fra loro su chi aveva il potere, nonché il diritto di dare gli ordini. Ma mentre, italianamente, fra i due si dibatteva, si udirono prima degli scoppi e poi gli aerei riavvicinarsi.
Fu allora che, con supremo disprezzo del pericolo, si scatenò un generale fuggi fuggi, che coinvolse anche la cavalleria.
Io cambiai appartenenza. Passai nella schiera dei sovversivi. Quella stessa sera inzuppai di petrolio la divisa d’avanguardista, la ficcai nel forno, che era a qualche metro dall’abitazione, assieme a due fascine di rami di elce e le detti fuoco. Bruciò l’intera notte ma neanche al mattino successivo era ancora completamente ridotta in cenere. Allora mia nonna cercò dei rami di pino, ricchi di odorosa resina – di quelli che si riducevano a schegge, per usarle, in cucina, come innesco del carbone - e me li porse. Con quest’aiuto – assicurò - la combustione accelererà.
139<>
La sconfitta e l’invasione furono per la mia generazione uno spartiacque morale ed esistenziale. Dopo lo sbarco degli angloamericani in Sicilia, vivemmo la paura giorno per giorno, minuto per minuto.
140
Mancando la corrente elettrica, mancavano anche le notizie. La nostra sorte era amara: un domani sicuramente difficile, forse mortale, ci aspettava. Dopo la caduta di Mussolini le truppe presero a sbandare. Tra noi e il nemico c’era soltanto Dio. Di armi tradizionali, abbandonate dai militari, ne avevamo a iosa. Le provammo e le riprovammo. “Se sarà necessario, le useremo”, disse papà.
Poi una sera, Giomo arrivò prima del solito dalla Vasia, dove si stavano effettuando i primi lavori di bonifica. Mentre mia madre gli mesceva un bicchiere di vino, si guardò attorno con fare circospetto, come per accertarsi se ci fossero altri ad ascoltare. -“Don Genso, Signora, ebbi una buona notizia direttamente dalla Sicilia, da un mio compare…Una notizia splendida… I nemici non vennero con brutte intenzioni. Rispettano le donne e tutte le persone…Non ammazzano nessuno…I soldati li rilasciano… Ci fu l’armistizio. Si voli Dio ‘a guerra finiu. Portano farina, roba i mangiari, sicarette, cicculatini, carne e latte per i bambini, li regalano alla gente…In Sicilia la gente canta e balla, ‘a paura finiu…Solo gli indiani…”
Lo abbracciammo, è dire poco. – “Giomo, siete un vero amico…”
Lo era sicuramente. E non un qualunque amico. Era sicuramente un capo, come qualcuno sussurrava e come adesso si evidenziava. Era un uomo all’antica; uno strano mafioso, amante del lavoro, rispettoso degli altri e della proprietà. In cambio voleva altrettanto rispetto, e quando l’otteneva era come se si sentisse obbligato ad accordare la sua contadinesca protezione.
“Sapremo in anticipo il giorno che saranno qui…Se gli indiani vengono di qua, per tranquillità nostra, il giorno prima portiamo la famiglia alla Limina. Don Paolino rimane qui con la nonna…Per lei non c’è pericolo…Non può farcela, sono ore di cammino. Io vi accompagno e
141
torno subito…
“Alla Limina sono persone di fiducia…meglio che a casa vostra…Solo un po’ di scomodità”.
L’8 settembre del 1943, sulla nazionale arrivarono gli angloamericani, i nemici. A guerra non ancora finita cominciava per noi un’era nuova, ma non lo capimmo subito. Ciò che vedevamo era la disfatta. Tra l’agosto e il settembre un interminabile fiume di uomini in fuga attraversò il paese. Non ho un ricordo più amaro e pietoso di quello. Venivano scalzi, con i piedi sanguinanti, affamati, coperti di stracci, sudici, il volto sporco di barbe non rasate, i pori intasati di sudore e miseria; pronti a uccidere e a subire per un pezzo di pane. Dormivano nei casalini abbandonati e semidistrutti dalle intemperie, o lungo la scarpata della nazionale e della ferrovia. Qualcuno fu ucciso perché trovato a rubare. Forse qualcuno di loro uccise anche, per rubare. Erano soprattutto siciliani, padri di famiglia della riserva, militari imboscati negli uffici, ma anche giovani che avevano combattuto in Jugoslavia. Qualcuno veniva dalla Grecia, qualche altro dalla Russia.
I primi giorni la gente dette tutto quello che poteva, e anche di più, poi prevalse la dura, umana/disumana legge della sopravvivenza. Oggi, nessuno ricorda più quella tragedia. In appresso gli angloamericani dettero un aiuto. Gli sbandati continuarono a passare a piedi, ma senza più stendere la mano e senza disturbare nessuno.
Era il momento di piangere sull’immane disastro, ma i vecchi antifascisti non ebbero gran rispetto per la gente dolorante. La corsa al potere fu preannunciata dalle esibizioni comiziali di gente che si era fatto un suo pacifico e vezzeggiato antifascismo di chiacchiere la sera a cena dai Surrenti, o al Circolo di Società. In quei primi mesi di non fascismo, l’apologia dell’ideale democratico fu assunta da un mani
142
polo di vecchietti, le cui carriere politiche s’erano bloccate venti anni prima. Le loro perorazioni ci apparivano demenziali e fuori luogo nel momento in cui un esercito, considerato ancora da tutti nemico, risaliva la penisola per portare a termine l’occupazione d’Italia; terra lontana e sconosciuta ai più, ma che i superstiti della Prima Guerra ci avevano insegnato ad amare e a riverire.
I Surrenti avevano aspettato la vendemmia prima di tornare in paese. L’indugio non era certamente addebitabile al poco mosto che mettevano nelle botti, ma piuttosto al desiderio di non imbattersi con gli sbandati. Ma ancor prima che la fiumana si esaurisse, si seppe che il nuovo prefetto aveva nominato Totò Surrenti sindaco del paese. I vecchi spiegarono che il premio non si doveva ai meriti di Totò, ma a quelli del padre. Per l’Onorevole – si sosteneva – sarebbe stata, comunque, ben poca cosa. La giusta ricompensa era un ministero: quello di Grazia e Giustizia o l’Agricoltura. Cosa che, “onestamente parlando, non è troppo”. Non per altro, ma perché aveva acquistato una lunga esperienza di uomo di stato proprio in quei due dicasteri, come sottosegretario. Ma mentre di ciò si discuteva, l’Onorevole, novantenne ormai, lasciò questa valle di lacrime.
Il paese gli tributò le solenni esequie che in un altro momento non gli avrebbe fatto. Gliele dovette fare perché, ora, era il vincitore. La sua parte, collettivamente, prendeva il posto di Mussolini. Venne persino un drappello della Regia Marina, composto da una decina di marinai ben vestiti e ben calzati, che non si capì bene dove li avessero trovati e come fossero arrivati fin qui.
In detta circostanza la nonna proclamò che non poteva non fare visita a sua cognata. La cognata Minicuccia era venuta a riverirla quando, dopo la morte del nonno, si era trasferita a San Policarpio. Fare quella
143
visita costituiva un suo elementare dovere. Di conseguenza divenne un elementare dovere per papà accompagnarla. Accompagnare la nonna e papà divenne un elementare dovere per la mamma. E siccome la mamma ci andava, ci andavo anch’io. Solo Celeste, a causa della sua età immatura, sarebbe stata esentata. Ma lei si mise a pestare i piedi, e ci venne.
Fu così che, per la prima volta dopo ben ventitré anni dalla sua venuta in Calabria, papà, indossata la cravatta nera, salì le scale di palazzo Surrenti.
Ma non finì lì. Non passò una settimana che telefonò personalmente il neo-sindaco Totò, per dire a papà che, se fosse stato d’accordo, gli americani gli avrebbero affidato il deposito degli aiuti alimentari. Gli aiuti erano gratuiti. I comuni facenti capo a San Policarpio avrebbero ottenuto di volta in volta le forniture disposte in prefettura. L’attività sarebbe stata ricompensata e sarebbe stato pagato anche l’affitto dei locali.
Papà accettò subito, perché voleva ricominciare a lavorare. Ma poi commentò negativamente. – “La gente ha fame, e io, con i magazzini pieni corro il rischio di passare per un affamatore del popolo…Forse ho fatto male… E poi mio cugino lo conosco. E’ gente che vuole mangiare. Ma con me non mangia, quindi la cosa finisce presto.”
I soccorsi alimentari americani dettero un sostegno decisivo alla popolazione del paese sfiancata dalla penuria. Anche la mia famiglia, sebbene ricca a sufficienza per reggere l’offensiva del mercato nero, ne ebbe un sollievo, in quanto a tavola si sentiva fortemente la punizione di dover consumare della pasta e del pane fabbricati con farina di scarsa qualità. Per via del deposito, avemmo caffè e zucchero a volontà. Potemmo mangiare tutti i giorni pasta ‘i casa preparata con i ferri per
144
le calze e con farina di grano. E che farina! Quella ottenuta dal grano Manitoba che, diceva mio padre, era la migliore che avesse mai visto.
*
Il passaggio dei carri armati tedeschi e americani s’era mangiato il manto d’asfalto dello stradone che da San Policarpio porta a Sottovento. L’acciottolato era venuto in superficie e la strada s’era ridotta un pavé di pietre aguzze. Cosicché a scuola si andava a piedi, percorrendo lo stretto bordo sterrato fiancheggiante la strada da entrambi i lati. Camminavo a fianco di Vitulia, ma non sempre con agio, in quanto il viottolo era stretto. Per lei, quella di recarsi a scuola a piedi, era una scelta. Infatti, in quanto figlia del nuovo sindaco avrebbe potuto usufruire della jeep che gli americani avevano regalato al Comune. Ma “a costo di non frequentare più la scuola” aveva deciso di rifiutare qualsiasi vantaggio che le potesse venire dalla posizione del padre. Condividere la condizione degli altri, nella sua posizione, era un dovere. E ciò non per imbellettarsi di un ipocrita spirito di classe, ma con sincerità, con compostezza, in nome della profonda fede socialista a cui l’aveva avviata sin da ragazzina il nonno Aversano.
Il quale socialismo era poi divenuto il principale argomento del nostro dialogare. Oggi, due innamorati che dedicano i loro incontri a discutere di politica parrebbero una stranezza. Non allora. Caduto il fascismo, firmato l’armistizio, tornati alla ribalta i vecchi notabili del prefascismo, la società e lo stato erano in via di rifondazione. Tutti, ma i giovani specialmente, vivemmo – dovemmo e volemmo vivere - intensamente la fase della rinascita. La collettività ribolliva a ogni livello. Antichi oggetti della vicenda politica e mute incudini della storia, come i contadini meridionali, balzarono sul suo proscenio con le vesti del primo attore. Comparse senza nome e senza volto per lo stato
145
e per lo stesso movimento operaio italiano, quali erano stati i lavoratori dell’escluso Sud, non accettarono più l’idea della disoccupazione endemica e dei salari infimi; o la dura emigrazione come fuga disperata dalla povertà. Volevano essi stessi farsi protagonisti dello sviluppo e lo reclamavano come fatto loro.
Non fu quello, in alcun senso, un clima confuso. Soltanto la retorica unitaria, che colloca la Resistenza a fatto totale, può portare all’idea di un Sud, in quel momento, indifferente, supino e qualunquista. Invece, le idee erano chiare e lineare fu l’azione alla partenza. Indifferenza, supinità e qualunquismo appartengono a un momento successivo, allorquando, riunificata l’Italia, il Comitato di Liberazione Alta Italia subordìnò a se uomini e cose.
Sicuramente non avevamo la coscienza, la consapevolezza storica e politica d’essere un paese a sé stante, ma la divisione d’Italia, che durò quasi due anni, ci consentì una breve fase d’autonomo giudizio nell’affrontare i nostri problemi. Parlando di politica e di socialismo, Vitulia e io parlavamo di noi, allo stesso modo di due innamorati dei tempi attuali che progettano d’avere una casa, un’automobile, un giardino. Disegnavamo il nostro futuro optando per una certa società, e non per un’altra, allo stesso modo che i fidanzati di tempi normali optano per una certa residenza, e non per un’altra.
E’ necessario che lo ricordi. A quel tempo, e per giunta in un paesino di Calabria, la passione civile e politica era un fenomeno che si coniugava solamente al maschile. Durante gli ultimi anni del fascismo quattro o cinque signore avevano indossato la sahariana nera, ma la cosa era apparsa come un fatto coreografico, più che altro collegato alla loro professione di insegnanti di ginnastica. Le ragazze e le giovanette in divisa di Giovani italiane del littorio erano apparse più libere e
146
spigliate, e più graziose che in abiti borghesi, ma la cosa era connessa alla condizione del sesso debole e non alla politica.
Vitulia fu la prima donna impegnata in politica che abbia conosciuto. Ma niente di scamiciato, niente che potesse ricordare le suffragette in corteo. Vitulia era, nel suo intimo un’aristocratica, e come tale lontana da ogni spirito popolaresco e men che mai piazzaiolo. Il socialismo era per lei quello che era Dio per San Tommaso: una verità di cui la ragione dava conto, una conoscenza razionale, giacobina, illuminata. E anche una missione alla quale l’essere razionale doveva adempiere. Nella quale mi coinvolse, anche se non ci intendevamo pienamente. A posteriori è facile spiegare che per lei il popolo era l’uomo astratto, potenzialmente puro. Invece io ero cresciuto tra la gente, cosicché l’idea di popolo che avevo in testa era la somma dei Ciccio, dei Cola, dei Peppe, delle Mariucce che conoscevo, la cui povertà mi mortificava, ma sulla cui purezza non avrei scommesso neppure due soldi.
Quelle persone in carne e ossa erano a volte buone, altre volte cattive, qualche volta oneste, altre volte disoneste. Erano da difendere soltanto perché tutte sofferenti nella carne; perché il pane era poco, le case misere, la vita dura, perché la loro dignità subiva un affronto in ogni atto sociale; perché la speranza e l’amore, che spesso portavano in sé, erano sempre frustrati.
Non avevo un buon giudizio degli uomini, però li amavo. Per tal motivo il mio amore disincantato, terreno, passionale, istintivo, coincideva nell’oggetto con il credo filosofico di Vitulia. In hoc signo, avviammo il sogno al confronto con la realtà; una cosa di cui il mondo d’oggi riderebbe.
*
La scarpinata fino a Sottovento non era breve, ma riposati da una
147
notte di sonno era amena, e piacevole era farla discorrendo di cose grandi. Vitulia mi dette la prima istruzione politica. Poi volle che entrambi ci iscrivessimo alla sezione giovanile socialista; una formazione collegata al PSI e chiamata MoGiS.
La sezione aveva più di duecento iscritti. C’erano molti studenti di liceo e delle magistrali, ma il vero corpo della sezione era costituito da giovani operai, disoccupati già prima di cominciare, e da apprendisti artigiani; ragazzi della zona industriale. Prima della guerra l’occupazione operaia era stata elevata a San Policarpio. Gli stabilimenti d’olio al solfuro, proprietà di ditte liguri, erano prossimi all’abitato e non lontani dalla ferrovia, da dove partiva l’olio rettificato, destinato ai saponifici. Gli stabilimenti sorgevano in mezzo a un arcipelago di isole di sansa. Erano, queste, delle colline artificiali a forma di piramide tronca, che occupavano estesi spiazzi non ancora edificati fra le case e gli orti. Sui loro fianchi si muovevano gli operai - unti, ricoperti dalla cima dei capelli alla pianta dei piedi di una patina oleosa, color terra di Siena. Essi possedevano la magica arte di scalarle con il sacco in spalla, lungo una specie di gradinata costruita con la stessa sansa e qualche tavola. Portavano i sacchi in alto, e là li svuotavano, innalzando così la collina della loro fatica.
Tutt’intorno cigolavano, a decine, i carri venuti da lontano con il loro carico di noccioli spremuti, che poi, sulla via del ritorno, si fermavano al negozio di papà a caricare mercanzie da portare al loro paese, in modo da pagarsi un nolo anche al ritorno. L’odore acre du nozzulu era una componente primigenia del nostro inverno. C’era da sempre, sin da quando ero nato, come da sempre c’erano stati, a ritmare la nostra quotidianità, le frequenti esplosioni di vapore liberato per alleggerire la pressione delle caldaie - sbuffi improvvisi, inaspettati, eppu
148
re normali, consueti come il fischio del treno che arrivava, o come l’esplodere di trombe, grancasse e piatti, quando, a sera, il Cavaliere Costantino provava al Concerto, l’enorme magazzino dove venivano effettuate le prove bandistiche; o come il grido atteso/inaspettato, roco, aggressivo e sfacciato del banditore, quando il pesce era abbondante.
Al tempo delle elementari, qualcuno dei miei compagni di scuola riusciva a distinguere, per via della diversa articolazione del suono, la specifica caldaia che aveva emesso il rumore. E siccome conosceva anche i rispettivi macchinisti, diceva: piditau mastru Cosimu, piditau mastru Micu, piditau u Cicciu du Surdu. Allora, la cosa ci faceva ridere. Finita la guerra, ci stringeva il cuore il non udire più quei tuoni di vita.
*Segretario della sezione giovanile era Aurelio, un mio ex compagno di scuola al ginnasio.
Aurelio usciva dal carcere. Negli ultimi due anni era avvenuto che nelle famiglie della piccola e media borghesia i giovani erano tornati a rappresentare, come nel mondo contadino, una risorsa immediatamente spendibile L’avventura di Aurelio era una vera lezione in tale materia. Conoscevo già il fatto, ma egli me la raccontò nella versione autentica, ridendoci su e forzando le tinte quando descriveva i suoi compagni di cella, i secondini, il fornitore di vivande, il direttore, il medico, il prete, il cibo. Per la verità, la cosa era stata un tantino più patetica di come lui la presentava. Era il maggiore dei figli di un carabiniere morto prematuramente. La sua famiglia non aveva altra risorsa che una pensioncina. Ad Aurelio la scuola non piaceva. Forse avrebbe fatto con piacere il calciatore, ma la madre si era fissata che dovesse arrivare a una professione. La fedina penale se la bruciò in
149
malo modo nell’autunno del ’42. Difatti, quando la famiglia si trovò sul limite della morte per fame, Aurelio si fece prestare trecento lire da un collega del padre, inforcò la vecchia bicicletta paterna e cominciò a salire e a scendere dalla montagna. Partendo dal paese, ci sono circa cinquanta chilometri di strada per raggiungere i pianori delle Serre. Non è la zona dell’Appennino più vicina; era però la realtà montana che tradizionalmente forniva alcuni prodotti tipici al paese. La strada per arrivarci non è facile neppure oggi in automobile, figurarsi a quel tempo. Sicuramente costituiva un’autentica impresa arrivarci pedalando una robusta bicicletta di allora. Lo sarebbe stata persino per un ciclista di professione.
“Tutto il mio capitale erano le trecento lire. Le carte da dieci le tenevo nascoste nella calza, sotto la pianta del piede, le lire spicciole nel taschino. Lo so, era una precauzione superflua: a quel tempo i furti si facevano di notte e i ladri scappavano se vedevano il padrone. Qualche volta scendevo anche con quaranta chili sul portabagagli.
“Li sai i portabagagli che fa mastro Ciccio ‘u Binda. Sembrano ‘na ferrazza. Ci avrei potuto portare anche due quintali, ma più di quaranta chili era pericoloso nelle curve. In discesa la bicicletta sbanda.
“Quaranta chili di fagioli, guadagnavo cento lire. Pure di più. Quaranta di patate, cinquanta lire. Anche con i ceci e ‘u jermanu si guadagnava. Poco con l’orzo. Solo i fornai lo chiedevano. La famiglia campava. Certo non navigavamo nell’oro, ma mangiavamo carne tutti i giorni. Mia nonna mi mandava benedizioni e diceva: “Forse ci ammazzano le bombe, ma almeno non moriamo di fame”.
“Non meno di cinque lire me le mangiavo io. Due piatti di fagioli, ché il pane non c’era. Anzi c’era, ma era la cosa che costava di più, sempre che lo trovavi. E le ulive d’u cugnettu, e carne e patate. Le uova
150
non le volevo. Le uova senza pane non dicono.
“La fame c’era. E tutta quella fatica! Ché, d’altra parte, se non avessi fatto il contrabbando, come potevo andare a giocare? Era fatica, era. Come un mulo. Pedalavo come i corridori, con le gambe e con i fianchi. Ogni fianco per aiutare la sua gamba. ‘Na flessione a destra e ‘na flessione a sinistra. Una a destra e una a sinistra, dall’alba a sole alto. Sudavo come ‘na bumbula nel mese di luglio. In montagna la mattina fa freddo pure in agosto; e il freddo mi gelava la fronte e le mani mi cadevano. Eppure sudavo. Il basco non lo sopportavo e neppure i guanti. E il cappotto e la giacca li avevo sul portabagagli, per il ritorno.
“Ogni tanto bevevo un sorso di vino dalla borraccia che mio padre si era portata per ricordo da Gorizia. Lo sai il vino di don Giannino Misuraca? Una goccia ti resuscita. Che carburante! Bevevo a digiuno e il vino si trasformava in forza motrice.
“Sul portabagagli mi portavo quattro sacchetti vuoti, quelli dello zucchero, che non si strappano mai. Forse non lo sai? Me li regalò tuo padre. Ognuno valeva almeno tre lire. Per trovare la mercanzia a buon prezzo non dovevi fermarti nei paesi. Se giravo per le case, il contadino cedeva prima.
“Avrei potuto portare qualche mercanzia per fare il baratto, così facevano tutti, ma i contadini volevano vedere i soldi. Se avevi i soldi non pensavano che volevi fare due guadagni. E così uno ti vendeva i fagioli suoi, e poi ti mandava anche dal fratello, dal cognato, dal suocero per le patate.
“Lasciavo la bicicletta da uno e poi giravo per i viottoli. Ma che ti pare, che è come il paese? In montagna, una casa vicina è a mezz’ora di cammino, una casa lontana, devi camminare mezza giornata. Giravo per quattro/cinque ore, fino a quando non avevo quaranta chili di roba.
151
Più no, sennò in curva cadevo. Parecchie volte sono caduto. Però in discesa mi mettevo i guanti ché, se cadevo, mi salvavano il palmo della mano.
“La discesa era bella, senza fatica, solo il freddo, che ti bruciava la fronte. Però la notte non potevo viaggiare. Senza faro cadevo. Troppi sassi. Mi toccava dormire digiuno sotto i ponti, e poi scendevo con il sole del mattino in faccia. Quando dormivo in montagna, gli aerei li sentivo un quarto d’ora prima, e tante volte ho visto il bombardamento. E poi ringraziavo la Madonna se le bombe le buttavano su un altro paese.
“C’era una donna che mi dava gratis un po’ di roba. Però voleva... tu mi capisci. Il pelo mi luceva... Fimmini schietti e maritati. Anche a me mi piaceva. Ero pieno e andavo volentieri. Era una donna bella e calda, però poi ero stanco. Ma se restavo da lei tutta la notte, il giorno dopo non guadagnavo niente. Adesso sono pentito. Chissà chi se la gode adesso? Forse il marito, se è tornato, o forse un altro.
“Chissà quante volte te l’hanno raccontato? Una sera, era il 18 dicembre, che avevo fatto diciott’anni a luglio, mi becca quel delinquente di forestale e mi vuole sequestrare quasi un tomolo di ceci. Ma io scappo. E quando mi credevo sicuro, mi arrestano i carabinieri al passo di Croceferrata.”
Aurelio uscì dal carcere, insieme agli altri detenuti, quando gli angloamericani erano già in Sicilia, perché il carcere non riusciva ad assicurare le razioni alimentari. Il resto della pena gli fu trasformato in libertà vigilata e praticamente condonato. Egli, che raccontava parecchie cose a proposito di quel periodo, non fece mai cenno del fatto che in carcere era stato battezzato nella ‘ndrangheta. A questo punto, tuttavia, usciamo dal certo ed entriamo in quello dei si dice. Avendolo
152
adesso come compagno, facevo attenzione a quel che si raccontava di lui in giro. Che fosse battezzato lo dicevano parecchie persone, ma un fatto del genere è sempre segreto. Lo si deduce dalle situazioni. Ora, nel caso di Aurelio non c’era un solo fatto che lo attestasse. È’ da supporre che, da ragazzo sveglio, in carcere avesse chiesto lui stesso di associarsi, ciò forse per evitarsi sopraffazioni e maltrattamenti fisici e morali, o forse soltanto per assicurare alla sua famiglia qualche aiuto e la protezione, ma che, una volta fuori, avesse lasciato andare.
*
Il MoGiS policarpiese visse più di un decennio, in sostanza fin quando l’esodo non spostò altrove le generazioni attive. Ma io ne conobbi de visu soltanto il primo anno di vita e di attività. Qualcosa del resto la seppi dalle lettere che i compagni mi spedivano in carcere e dai loro racconti, nei decenni successivi. Sebbene io abbia saputo parecchio, non potrei però scrivere una storia politica di quell’esperienza, in quanto il contenuto delle lettere e i successivi racconti dei compagni si soffermavano piùsull’aneddotica che sulla politica. Ebbi modo di assistere e in qualche modo di partecipare soltanto a uno di quei fatti epici: “il bacio di Adelaide”, il quale, nella favolistica sezionale, aveva lo stesso peso di “quandu i carbineri sa cacaru”, di “quandu Lucifaru sa fuju”, di “quandu arrestaru Alfredu chi dormia supra a scrivania da Camera du Lavoro”, vicende - ripeto - alle quali io non ebbi modo di partecipare.
Sebbene educato alla scuola dell’antifascismo, Telemaco Aricò aveva conservato una non sopita passione per le parate. Allorché raggiunse una posizione dirigente, gli cominciò a frullare in testa l’idea che che la sezione avesse bisogno di una bandiera nuova, dovendosi collocare quella venuta dal pre-fascismo, ormai a brandelli, in una teca
153
con la naftalina. Le due cose - il collocamento a riposo della bandiera classe 1909 e il battesimo di quella classe 1944 dovevano essere celebrati con una grande manifestazione. Ciò convenuto, Telemaco passò ai fatti. Raccolse danari, acquistò uno splendido pezzo di seta rossa, trovò chi vi ricamasse sopra la falce, il martello e il sole nascente; come asta si adottò quella di un lussuoso gagliardetto fascista, sgraffignata con abile raggiro a un impenitente nostalgico. L’anziano Tobiolo ne forgiò il fregio in puro e indistruttibile ottone. Telemaco fissò la data, affittò la sala del cinema e quando ritenne tutto pronto, chiese aiuto per addobbare il locale e piazzare l’altoparlante.
E a qualcuno che gli chiedeva - a puro titolo sfottitorio - se si dovesse invitare anche il vescovo con l’aspersorio, per la benedizione, Telemaco spiegava con molta serietà, che no; perché la cerimonia prevedeva una benedizione laica, consistente nella presentazione del drappo ancora raccolto da parte del novantenne compagno Sanci, che aveva assistito all’inaugurazione dei primi anni del secolo, nelle mani della compagna Adelaide, sulla cui scelta nessuno poteva sollevare obiezioni, quand’anche preferisse le bionde. Al suono dell’Internazionale, Adelaide avrebbe annodato la bandiera all’asta, dopo averla baciata.
Qualcuno insinuò che il bacio di Adelaide sarebbe bastato; su tutto il resto si poteva tranquillamente lasciar perdere.
Ma Gianni, volendo moraleggiare, replicò: “Oh cazzo, ma non sapiti u fati attru ca u parlati ‘i fimmani.”
Da ragazzi, Gianni e Peppe erano sempre assieme. Abitavano con le rispettive famiglie in due minuscoli magazzini, uno accanto all’altro, in una vineja di pescatori. Erano entrambi orfani. Entrambi primogeniti di famiglie che “mangiavano pane”. Adesso che gli stabilimenti erano chiusi, il primo faceva l’imbianchino, il secondo il falegname.
154
Se trovavano lavoro, la sera portavano a casa cinquecento lire.
Se avevano le 500 lire, erano allegri e sfottenti, se non le avevano, erano cupi e acidi.
Siamo al fatidico sabato. Secondo don Andrea, il proprietario del locale, la sala poteva venire addobbata soltanto dopo la fine della proiezione serale, per essere pronta la mattina di domenica. Il commissario di P.S., il prefetto, i carabinieri e quant’altri l’avrebbero preso sott’occhio, se avesse proiettato il film in una sala piena di drappi rossi. “Dovete capirmi... gestisco un pubblico locale... Permessi, concessioni... Le autorità...” Telemaco capì.
Mi associai a lui. Cenammo assieme e andammo a vederci il film. Non appena la sala fu vuota, Telemacò schierò le sue legioni. Sudato come la cuoca nera del film appena proiettato, non era mai contento. “Sposta quel drappo. Fissa bene quella bordura. Ma non vedi che sta già cadendo?...”
“Lí, voglio un drappo che copra il telone.”
Peppe: “Ci vorrebbe una scala. Le funi delle quinte se le son fottute per legare il basto all’asina.” Cosa in effetti non inverosimile, considerata la povertà imperante.
Arriva Gianni sotto un’enorme scala, che tiene in bilico sulla testa, con le braccia sollevate. Rivolto a Peppe: “Tu teni ca jeu ‘nchianu”. In verità, un intero manipolo di social-aiutanti in soprannumero si mise a reggere.
Gianni salì come uno scoiattolo. Arrivato in cima, non riusciva egualmente a raggiungere la trave a cui legare il drappo. “Arzatimi”. Sollevammo. Ma a quella sconsideratezza la scala prese a oscillare paurosamente, con Gianni in cima.
“Ahia, ahia, ‘a madosca pputtana...”. Per qualche secondo Gianni,
155
avvolto nel drappo rosso, roteò alto sulla scena. Poi, quando l’oscillazione lo avvicinò al sipario, tentò di aggrapparvisi. E in effetti vi si aggrappò. Ma, sotto il suo peso, venne giù tutto quello che l’aristocrazia del luogo aveva speso in velluti e parati, al tempo di Giolitti. Con Gianni avvolto dentro.
Ci spaventammo. Lo credemmo ferito. Ma lui si sollevò su un fianco e disse: “Ahi, ahi, ahiai, ohoo...... Aveva ragione Testa ‘i Giolla... era meglio il bacio di Adelaide”.
*Don Mico Muzzì, un negoziante di calzature, ex ferroviere, ben noto in paese per il suo irremovibile antifascismo, divenne il nostro mentore. Con la serale frequentazione della sezione cominciò una vera e propria milizia politica. Tra la sezione giovanile e quella “adulti” – come la chiamavamo - c’era un collegamento stretto. La sezione adulti – scoprii – era moralmente spaccata. C’era un nocciolo duro formato da una quindicina di compagni più anziani, che avevano cominciato la loro esperienza politica tra il 1910 e la dittatura fascista. Erano tutti operai e artigiani; c’era un solo agricoltore, un piccolo proprietario a nome Cavaleri. C’erano anche tre ferrovieri che, dopo essere stati espulsi dall’impiego, lo riottenevano proprio in quei giorni, insieme a consistenti risarcimenti.
‘U Siccia (il nomignolo sfuggiva spesso di bocca ai compagni, che poi chiedevano scusa a Vitulia) e il suo gruppo costituivano una componente esotica, vista con scarsa simpatia dai primi. C’era poi un fatto nuovo. S’iscrivevano al partito decine e decine di persone nate o cresciute sotto il fascismo, specialmente reduci che rivedevano il paese dopo anni di lontananza. Si trattava in parte di operai e di artigiani, in parte di maestri, di studenti e di laureati.156
Qualcuno dei vecchi lamentava che la sezione stesse trasformandosi nel partito dei professori, ma don Mico spiegava che in trasformazione non era il partito, ma il lavoro subordinato. Con i panni del pubblico impiegato andava formandosi un nuovo settore del lavoro subalterno, una condizione molto vicina al proletariato. Era compito del partito fare dei proletari dell’impiego una componente del movimento di classe. Ma altri opponevano che i nuovi venuti, alla prima occasione, sarebbero divenuti la claque del sindaco Surrenti.
La sfiducia dei compagni verso Totò era un atteggiamento ereditato dall’età prefascista, allorché tra la sezione socialista e zio Ferdinando, deputato giolittiano e autentico signore politico del paese, si era arrivati ai ferri corti. Citando negativamente il defunto Onorevole, contro cui avevano fieramente lottato nella loro giovinezza, i vecchi prendevano coscienza della presenza di Vitulia, verso la quale, diversamente che per il nonno e per il padre, si aveva molta stima, e dicevano - “Scusate, Compagna…” Vitulia non batteva ciglio e pareva che l’avversione dei socialisti per la sua famiglia fosse acqua che scorreva sugli abiti senza bagnarli.
*
Bisogna pur dirlo francamente: la democrazia segnò un netto decadimento morale in chi esercitava il potere politico. Nel mio paesino, l’uomo che meglio raffigurò la transizione dall’onestà alla disonestà fu Totò. Nominato sindaco, acquistò un’arroganza e un sussiego che facevano a pugni con la precedente mellifluità. Il suo potere era notevole e le sue decisioni difficilmente sindacabili. Gli altolocati amici del defunto padre, tornati al comando, gli offrivano una vasta copertura in paese e a livello provinciale. A tenerlo in alto nella considerazione politica c’era poi il prestigio che gli veniva dall’essere genero del
157
l’onorevole Aversano, in quel momento sottosegretario agli Esteri e personalità di primo piano fra i socialisti. Di fronte a tale innalzamento, le antipatie dovettero essere taciute e molta ipocrisia dovette essere usata per conquistare le sue buone grazie, in vista di un favore.
Offendendo la purezza morale dei vecchi socialisti, ‘u Siccia, aveva preso a commerciare i suoi ammanigliamenti. La crisi esplose nel febbraio 1945 e fu la causa di pesanti conseguenze. Riguardava l’ammasso dell’olio, che era tuttora in vigore, ma sotto le nuove autorità. Si trattava di un incarico quasi politico, che veniva remunerato. Era quindi ambito da molti, e molti erano i focolai di guerre intestine intorno al posto. Nel cambiamento politico, l’incarico era andato a don Ernesto Carlino, noto antifascista, ma inviso alla popolazione per la sua avidità. Lo si riteneva una persona disonesta, capace di tradire sia gli interessi dei produttori sia quelli dei consumatori; insomma uno che badava solamente ad arricchirsi con imbrogli d’ogni genere.
S’erano così formate due fazioni che tagliavano trasversalmente il paese e anche il partito. Fra le altre cose si diceva che Carlino e Surrenti spartivano sottobanco; un’accusa assolutamente plausibile, in quanto i soldi, che da un anno in qua Totò spendeva e spandeva, da qualche parte dovevano pur venire.
Da tempo Vitulia mi aveva confessato d’essere convinta della di-sonestà del padre. Le più recenti dicerie l’incupirono e l’accasciarono. Probabilmente aveva prove che non indicò, né io volli chiedere. Perse il suo smalto, la connaturata franchezza e quella levità che facevano di lei un essere speciale. Non osava più guardare in faccia la gente: proprio lei che innamorava con il suo sguardo dolce, franco, in qualche modo ingenuo. Quando eravamo soli, si aggrappava a me come una bambina smarrita fra gente ostile, e piangeva.158
Io non sapevo proprio più che dire. Contro Totò non mi pronunziavo, in quanto era pur sempre suo padre. Ma il coraggio di difenderlo, non mi veniva. Solo le consigliavo di uscire di casa il meno possibile e soprattutto di non venire in sezione, dove infuriava una vera battaglia.
Accolse il consiglio. Che altro poteva fare? Tornammo a frequentare la spiaggia, deserta d’inverno. Ci accolse l’amichevole frinire dei grilli. Un prato di fiori violetti e di tenere erbette, anticipo gentile della primavera, ci accarezzava le gambe. Gli slanci di Vitulia si fecero più appassionati e insolitamente arditi, con la conseguenza che la mia testa non sempre stava a posto.
Contro Totò ci furono critiche aperte e severe anche in sezione. Spinto da quella diffusa irritazione, il prudente Muzzì dovette prendere posizione. Convocata l’assemblea degli iscritti, presentò un ordine del giorno in cui si diceva che, per il buon nome del partito, il compagno Surrenti doveva lasciare la carica di sindaco. Lo si invitava, inoltre, a sospendere ogni attività politica fin quando non fosse stata fatta piena luce sulla questione Carlino. Ma l’assemblea andò oltre. Spesso, nelle assemblee, le posizioni radicali e le parole infiammate hanno il sopravvento sul buon senso (e qualche volta anche sulla ragione). ‘U Siccia fu deferito ai probiviri con la richiesta di espulsione per indegnità politica.
“Si poteva aspettare d’avere in mano qualche prova”, fu il commento di Muzzì e dei più avveduti, i quali erano certi che la reazione du Siccia sarebbe presto arrivata, anche se nessuno sapeva quando e come. La situazione si faceva di giorno in giorno più tesa. Lo facessero per tatto o lo facessero per mancanza di fiducia, mi resi conto che i compagni apparivano imbarazzati ed elusivi se trattavano il tema Totò
159
in mia presenza. Così, anch’io diradai la frequentazione.
‘U Siccia pareva tranquillo. Si limitava a ribattere che chi lo incolpava doveva tirar fuori le prove, altrimenti a essere punito con l’espulsione non sarebbe stato lui, ma chi aveva infangato il suo buon nome. Si trattava di una difesa intonata al carattere della persona e con il suo mestiere d’avvocato. La cosa andava per le lunghe. Forse Muzzì avrebbe voluto salvare capre e cavoli con un compromesso. Ma il cielo, che stava tornando limpido, avvampò nuovamente. Nel corso di un’assemblea, alcuni compagni – si disse poi materialmente corrotti da Totò - aprirono il fuoco contro Muzzì e contro quelli che lo sostenevano, affermando che, in quanto gradualisti, erano fuori dalla linea del partito, la quale si basava sull’alleanza politica e rivoluzionaria tra operai e contadini.
L’assemblea, abilmente preparata da Totò, presente anche il segretario di federazione arrivato appositamente da Reggio, defenestrò l’esecutivo e i probiviri in carica. Il segretario provinciale nominò un comitato straordinario detto “di fedeltà”, con il compito di rifare da capo la sezione adulti. Esso si comportò in modo fazioso. Cancellò chi aveva manifestato opposizione a Totò. Nei fatti fondò una nuova sezione, nella quale stavano i partigiani di Totò; nel complesso gente raccogliticcia, arrivisti che con il socialismo non avevano nulla a che vedere.
Muzzì immaginò di poter esercitare delle pressioni in federazione e prese a frequentare Reggio. Spiegava la situazione, ma i più interpretavano male il senso delle sue parole. In verità, solo poche sezioni avevano alle loro origine una tradizione simile a quella di San Policarpio, che veniva dal lontano prefascismo e contava su una base popolare politicamente schierata. La maggior parte delle altre erano, invece,
160
posticce; delle semplici targhe prive di sostanza, che avevano lo scopo di imbellettare la posizione di un aspirante notabile.
A Reggio il partito era zeppo di tali finzioni e di personalità marce che, una volta vinta la battaglia dell’antifascismo, pretendevano rivalse economiche e il dominio insindacabile della società locale. Ora, questa gente si sentiva istintivamente vicina ‘o Siccia e considerava Muzzì un compagno scomodo. Cominciarono a dire che troppe invidie per il posto stavano nascendo tra i vecchi antifascisti; che bisognava darsi una regolata. “Oggi tocca a Surrenti, vedrai che domani toccherà a noi.”
A Muzzì, che cercava di farsi ragione, di solito rispondevano: “Proprio tra te e Surrenti!… Siete due persone grandi e vi comportate come se foste dei bambini!”
A queste notizie, i vecchi compagni del paese raccapricciavano. - “Un giorno o l’altro marciamo su Reggio”, affermava il compagno Passalia che, essendo alto e forte come una torre, i fascisti non avevano mai ardito toccarlo. “Marceremo su Reggio il giorno del primo congresso provinciale. Ci debbono permettere di parlare. La mia tessera risale al 1912. Ma qui ci sono compagni che hanno una tessera anche più vecchia…”
“Non ti illudere, Mico”, diceva mastro Pasquale Sgrò, che il governo americano aveva restituito all’Italia come indesiderabile al tempo del processo contro Sacco e Vanzetti. “Senza aver vinto, siamo al potere. Non lo vedi? E adesso che siamo al potere, anche noi socialisti ci comportiamo come tutti i potenti…Schiacciamo gli avversari, senza tenere conto della ragione e del torto”.
Proprio in quei giorni l’insegnante d’Italiano, uno studente universitario (il titolare era scomparso fra le sabbie libiche), portò, dopo
161
averlo corretto, il compito in classe. Entrò facendo le lodi di Vitulia, alla quale aveva messo niente di meno che 10, un voto mai visto nella storia della mia classe nello scritto d’italiano.
Poi lesse il tema e lo commentò. Vitulia aveva parlato della miseria e dell’umiliazione che i lavoratori soffrivano in Calabria, molto più pesante che a Roma e in altri posti d’Italia a lei noti. Aveva aggiunto che, con l’aiuto che gli americani pareva volessero darci, la sconfitta militare poteva trasformarsi in una grande vittoria per la democrazia e per il miglioramento della società. Bisognava, però, che nascesse una classe di uomini nuovi. Poi, trascrivendo forse inconsapevolmente un precetto di don Mico, aveva concluso che se il nuovo stato avesse avviato al lavoro coloro che non l’avevano, la produzione sarebbe cresciuta e con essa la ricchezza generale.
Debbo confessare che provai invidia. Un tema così avrei voluto scriverlo io. Corrispondeva alle mie idee, ma io non avevo l’intelligenza di Vitulia, né la sua informazione politica, né la sua attitudine a esprimere con semplicità i pensieri e le sensazioni; né la sua già matura sensibilità.
*
Il giorno del congresso provinciale arrivò prima di quanto ci aspettassimo. A saperlo per prima fu proprio Vitulia. Lo seppe in famiglia, e non tenne la notizia per sé. – “I vecchi della sezione non potranno partecipare. Dillo tu a don Mico.”
A questo punto i vecchi antifascisti s’infiammarono, loro avevano fatto il carcere e loro erano stati puniti nel lavoro e nel giusto diritto di portare un pane a casa. ‘U Siccia era solo un tollerato, in quanto, finita la guerra, era tornato con una tessera socialista in tasca; una tessera che nessuno in paese si sarebbe mai sognato di dare al figlio di un notabile
162
interventista.
“Ma che federazione e federazione!…Questi mangiapane a tradimento!…Questi arrivisti! Al tempo di Turati la federazione era qui, a San Policarpio…Matteotti fece le nostre lodi in parlamento…” Decisero d’andare a Reggio in massa, ma qualcuno rilevò l’incongruenza della decisione. – “Non ci faranno entrare. La cosa esacerberà ulteriormente gli animi.” Gnazio, uno del MoGiS, osservò che, sebbene non invitata, la giovanile non era scomunicata. “Noi chiediamo l’invito che ci spetta. Non possono fare a meno di darcelo, e uno di noi interverrà al congresso per dire come stanno le cose.”
Il senso pratico convinse tutti. Andammo in federazione e avemmo l’invito. Il primo passo era fatto. Adesso il punto interrogativo diventava come sfruttare l’occasione. Muzzì era un uomo all’antica, onesto con se stesso e con gli altri. Lui stesso e la sezione avrebbero ricevuto un aiuto decisivo dalla presa di posizione dei giovani, disse. Ma dovevamo essere consapevoli dei rischi a cui esponevamo noi e le nostre famiglie. Ci saremmo scontrati con gente potente e vendicativa. L’esecutivo della giovanile fu concorde: - “Tu sei il più istruito, tocca a te.”
“ Tenete conto che sono il cugino…”
“Allora non hai capito niente…Se non ci vai tu, ci andrà Vitulia… Non gliela perdona al padre…Ha capito che l’ha sempre ingannata…Che ha ingannato tutta la famiglia, oltre che i socialisti…”
Similmente allo spettro di Amleto, Vitulia entrò nelle mie rappresentazioni mentali come l’avevo effettivamente vista e sentita la sera precedente, quando piangendo mi aveva detto: - “E’ mio padre, io non posso… Andrai tu, e così capirà che anch’io respingo questo andazzo vergognoso…E poi sarebbe indegno di noi mandare una specie di
163
sicario…”
Vitulia aveva mille ragioni, la vita vera tradiva il suo sogno. E tuttavia non ci voleva la zingara per capire che io e lei stavamo imbarcandoci in un affare di famiglia più pesante dell’affare politico. A sessant’anni di distanza, stava per ripetersi un duro scontro fra parenti. Giocato il dado, né io né lei avremmo potuto più tornare sui nostri passi. Ebbi la forza d’animo di non tirarmi indietro. Diceva mio padre: “Un vero uomo paga sempre il suo debito al mondo.” Preparai il discorso. I compagni ne approvarono il testo, ahimè retorico e prolisso. Rimaneva il problema del permesso familiare a recarmi tre giorni al congresso. Non trovando il coraggio di giustificare la richiesta con l’impegno congressuale – una cosa non conforme alla mia età - lo saltai. Il mio amico Telemaco ebbe il delicatissimo compito di informare mia madre a partenza avvenuta. Viaggiai in un carro merci, in compagnia di Muzzì, e dormii ospite di un ex ferroviere, suo compagno di licenziamento.
Il congresso si aprì con l’interminabile discorso di un avvocato socialista su riformismo e massimalismo. Parlarono altri, chi a favore del riformismo, chi a favore di quell’altra cosa che non si capiva bene se fosse la rivoluzione armata o soltanto un riformismo guarnito di un aggressivo vocabolario. Nel bel mezzo di tale dotto dibattito, del quale afferravo ben poco, un esponente della presidenza lesse la mozione che avevo presentato all’apertura dei lavori, e poi disse: “Ha la parola il compagno Alfano della sezione giovanile di San Policarpio”. In verità non mi aspettavo che avvenisse così presto. Arrivai tremante alla tribuna. Grondavo sudore persino dalle unghie. Non ebbi il coraggio di tirar fuori il discorso che avevo bello e scritto in tasca. A quel tempo non si usava. “E adesso cosa dico?” L’unica cosa chiara che mi venne
164
in testa fu l’orazione di Lisia contro i mercanti di grano. Pronunciai le accuse contro ‘u Siccia con tanto vigore che, dentro di me, mi chiedevo se non fossi impazzito. Ma in ballo non erano più le sue colpe, bensì il consenso dell’uditorio.
Mentre parlavo come un automa, ebbi la chiara percezione che quel discorso poteva essere inteso come una bega locale. Allora ebbi l’improntitudine di tirare una coccola – come diceva proprio Totò - sulla moralità socialista e le virtù democratiche. Era quello il linguaggio che piaceva agli astanti. L’orazione fu infatti accolta da applausi scroscianti.
L’onorevole Feudale, un vecchio e autorevole deputato, si alzò pesantemente dallo scanno presidenziale e volle abbracciarmi. La cosa avrebbe dovuto lusingarmi e invece, raffreddatasi la tensione, cominciai a sentire vergogna per aver colpito con ferocia uno che, per quanto si mostrasse arrogante, in fondo altro non era che un povero diavolo; uno che - intrallazzi o non intrallazzi - doveva portare a casa il necessario per un’intera famiglia. In quel momento sentii che anche Vitulia era ingiusta con lui. In effetti mangiava alla sua tavola e vestiva gli abiti che lui – ‘u Siccia – le procurava lecitamente o illecitamente. Studiava sui libri che lui pagava e aveva di lui la stessa calibrata ragionevolezza.
Comunque, in quanto figlia, lei poteva persino essere severa, ma io avevo sbagliato decisamente l’entrata. Con il padre della ragazza che amavo e che mi amava, avrei dovuto essere molto più cauto. “Sei un pagliaccio”, dicevo a me stesso. Se mia madre mi avesse visto e sentito - pensai - mi avrebbe suonato un ceffone. Mio padre avrebbe detto: “Un uomo non fa cose del genere”. Il presidente, con un volto mesto, come se i guai del mondo fossero tutti suoi, mise ai voti una proposta
165
della presidenza per la costituzione di una commissione d’inchiesta.
*
Una quindicina di giorni dopo ci fu un incontro informale tra il gruppo di Totò e quello di Muzzì. Gli espulsi vennero reintegrati e Muzzì fu rieletto segretario. Era la condizione, o il prezzo che Totò pagava perché potesse continuare a fare il sindaco. Si disse che Totò era stato fortemente redarguito dai dirigenti venuti a San Policarpio, ma di ciò non si ebbero elementi certi.
Non appartenente alle supposizioni, bensì alle certezze fu, invece, un incontro tra Totò e il sottoscritto. Vitulia e io tornavamo da una passeggiata sulla spiaggia, quando egli ci apparve dinanzi, come se ci avesse aspettati al varco. Da principio fu bonario, ma quando, sulla porta del palazzo, fui sul punto di salutare per andarmene, mi disse d’entrare con una certa durezza. E una volta entrati, spedì sgarbatamente Vitulia su, in casa, mentre a me fece cenno di seguirlo nel suo studio professionale, che dava sul cortile.
Senza neppure invitarmi a sedere, estratto da un cassetto della scrivania un foglio con degli appunti, mi sparò in faccia l’elenco dettagliato delle accuse che gli avevo rivolte al congresso. – “Sono certo che non ti fa onore frequentare la figlia di un simile mascalzone…
“Dicono che sei un ragazzo intelligente e maturo. Allora ti dovrebbe essere chiaro che - anche se mascalzone non ero e non sono - tu e i tuoi amici mi avete bollato per tale. E avete bollato i miei figli, Vitulia compresa…
“Solo tuo nonno ti ha superato in leggerezza…Se mio padre non fosse stato l’uomo che era, sarebbe stato una delle tante vittime della sua insipienza…
“La vittima è stata il nonno…”, tentai di dire. 166
“Ho sbagliato argomento…Lasciamo stare le defunte generazioni…Forse tu…Tutti siamo stati giovani, tutti siamo stati innamorati. Adesso, il problema dell’onore non lo avverti, ma lo avvertirà tuo padre, e lo avvertirà tua madre…Prima o poi s’imporranno…La figlia di un disonesto!…Ma il problema dell’onore lo avverto anch’io, e non posso permettere che sia mia figlia a pagare per il tuo infantilismo…
“Tra Vitulia e te è fiorita una passione di ragazzi, che il mondo chiuso della guerra ha fatto crescere, ma che è destinata a finire non appena questo caos finirà. Intanto ha assunto l’aspetto esteriore di una cosa più grande dei vostri anni…
“ E poi, non ignori che tra le nostre famiglie c’è un’inimicizia antica, che mio padre e tuo nonno non si sono scambiati una sola parola in cinquant’anni, che io e tuo padre siamo stati a un passo dalle sciabole in mano…
“No, io non posso perdere mia figlia. Perciò ti prego di dimenticarla…di dimenticare me e tutta la mia famiglia…”
Aprii le labbra per ribattere, ma non lo feci. Infatti ribattere avrebbe significato compromettere Vitulia.
“Quella è la porta”.
Non sapendo che dire, o non volendo dire ciò che avrei potuto, l’infilai e uscii.
Mi diressi nuovamente verso la spiaggia, da cui ero venuto. Avevo bisogno del mare e delle stelle per capire cosa m’era accaduto.
*
Il pettegolezzo girò. La notizia che Totò mi aveva buttato fuori di casa arrivò alle orecchie di Sestia e, quindi, di mia madre. Da mia madre a mio padre il tragitto fu breve. In appresso arrivò alla nonna e a Celeste. Ma nessuno fiatò. Mia madre mi scrutava perplessa e rattrista
167
ta, papà, invece, mi guardava con occhi di sfida, come per dire: “Adesso sapremo se sei un uomo o no”. La nonna pareva dicesse dentro di sé: “Dio non voleva”, mentre Celeste (sicuramente) ripassava mentalmente la favola, per raccontarla alle sue amiche. Chiunque mi conoscesse diceva: “Pazienza…Non c’è rosa senza spine…” Giomo affrontò il tema in forma sintetica, superiore esito della ragion pura: “Voi, adesso, non dovete fare niente. Se lei vi vuole, saprà come fare”.
Cosa potesse fare non sapevo immaginarlo, perché scomparve anche da scuola.
Non passò una settimana che arrivò la prima bordata d’u Siccia. La prefettura di Reggio, con una breve lettera, revocò a papà la gestione del deposito Amgot. Per papà fu un duro colpo. Quel lavoro, oltre a permetterci di mangiar bene, portava in casa circa ventimila lire al mese, tra affitti e stipendio paterno. Quasi un terno a lotto in un momento in cui una buona metà della popolazione era tagliata fuori da un reddito. Subito dopo arrivò una seconda bordata, sicuramente meno dura, e tuttavia dolorosa. La Camera di Commercio disdettò l’affitto delle cisterne che risaliva a una requisizione ordinata prima della guerra. Siccome percepiva soltanto ottocento lire al mese, papà aveva scritto chiedendo un adeguamento del prezzo. Fingendo di aver frainteso il significato della lettera, il locatario aderiva alla fantomatica disdetta “in essa contenuta” e lasciava liberi i locali.
Mi sentivo tradito e impotente. Non sapevo se amare o odiare. La cattiveria dei Surrenti era un fatto o un’opinione? E se c’era, si trasmetteva da una generazione all’altra? Io conoscevo Totò. E Totò era una carogna. Ma questo mi autorizzava a pensare che lo fossero anche suo padre e sua figlia? Vitulia odiava il padre. Ma ciò era coraggio o viltà? - “Se mio padre fosse un corrotto, io lo difenderei o l’accuserei? Starei
168
con lui, anche a costo di passare per un corrotto”, mi rispondevo. Ma poi aggiungevo: “Tu sei un immaturo, un piccolo borghese. Al mondo c’è anche gente come Robespierre…”
Mi tornò in mente il famoso manoscritto del nonno. Chi erano veramente i Surrenti? La prescrizione avita era che avrei dovuto conoscerlo solo da grande. Ma io ero già grande. Fra qualche mese avrei finito i diciannove anni. Fra due anni sarei stato maggiorenne.
Lo scritto era chiuso in cassaforte. Bastava scendere le scale, aprire la cassaforte e leggere. Niente di straordinario. La mamma, la nonna e Celeste erano a chiacchierare in cucina con Sestia. Papà era uscito. Come al solito aveva energicamente spazzolato la giacca e i pantaloni, e lucidato le scarpe. Aveva riposto sul comò le chiavi della porticina blindata che permetteva d’entrare in negozio dal cortile di casa, e quelle della cassaforte. Aveva preso la pistola dal secrétaire dove la nascondeva. Aveva messo il caricatore nell’arma e poi il proiettile in canna. Applicata la sicura, l’aveva infilata nella tasca sinistra del gilè, appositamente tagliata più larga e profonda di quella destra. Aveva preso anche una torcia elettrica, e posto le sigarette e l’accendino nel taschino interno della giacca, in modo che il loro ingombro mistificasse l’ingombro della pistola. Controllata l’ora, aveva esclamato a voce alta: “Sara, io esco”. La mamma era andata sul pianerottolo. Si erano salutati e lui aveva sveltamente sceso le scale. Sarebbe tornato verso le 22,30.
Presi le chiavi, scesi in negozio, entrai nell’ufficio, accesi la luce e aprii la cassaforte. Niente di strano. Lo avevo fatto decine di volte su comando. Invece non avevo mai rovistato tra i documenti che papà custodiva nello scrigno interno, in quattro borse. Scelsi quella giusta, contenente le carte della famiglia avita. Trovai la busta con il mano
169
scritto - un centinaio di pagine - e lo portai con me, in camera mia. Passai l’intera notte a leggerlo.
Il nonno aveva una bella calligrafia; cosa assolutamente normale ai suoi tempi, allorché la calligrafia era materia scolastica. E tuttavia un manoscritto, sia pure vergato in bella calligrafia, non si legge scorrevolmente come la pagina stampata. La prima parte riguardava i rapporti con le ditte marsigliesi, principalmente quella con i fratelli di sua madre. La seconda il mercato dell’olio a Napoli e a San Policarpio, nonché le relazioni con i produttori, e come mantenerle buone. Poi il grano, le banche, la navigazione a vela, i nostri giardini di Capursi e la produzione dei limoni, la massoneria. Insomma una molteplicità di argomenti e temi che avrebbero potuto interessare me, suo erede e continuatore, non certamente i miei lettori. Conseguentemente li tralascio, per soffermarmi sul capitolo relativo allo zio Ferdinando, che è parte centrale del racconto.
Siccome il manoscritto è qui sul mio tavolo, volendo essere un storico fedele, trascrivo il passo.
Da cinquant’anni sul mio nome cade l’ingiusto addebito di non aver saputo amministrare quello che mio padre ci lasciò quando morì. Alla sua morte, fra fratelli e cugini, tutti furono in accordo che l’amministratore della Società fossi io. Dopo tutto ero anche il maggiore, immediatamente dopo Paolino Conforti, che però aveva voluto seguire la carriera militare.
Le cose continuarono ad andar bene per i successivi anni; poi cominciarono le disavventure. Si tratta di eventi che nessuno avrebbe potuto dominare, principalmente il voltafaccia della Banca, che ci aveva sempre dato larghe aperture di credito per la campagna olearia.170
Quando la Banca venne meno, ci ritrovammo senza alcuna difesa alle spalle. Se volevamo sopravvivere, bisognava trovare credito, ma sulla piazza di Napoli era divenuto sempre più difficile avere danaro. Pareva che i soldi fossero tutti spariti. Andai a Marsiglia, a chiedere l’intervento dei parenti materni, ma in Francia era venuta meno ogni fiducia per l’Italia. Mi fermai allora a Genova, e da lì andai a Torino e a Milano, nella speranza di finanziatori. Infatti il governo di tutto si era ormai stabilito nell’Alta Italia.
Erano città che conoscevo soltanto di passaggio. I nostri affari erano tutti con Marsiglia, con Liverpool, con Trieste e con la Grecia. Lì, come m’aspettavo, la situazione era molto confusa. Era difettosa la tradizione commerciale e mancava la fiducia con cui a Napoli facevamo i nostri commerci. Si aveva l’impressione che i negozi finanziari s’intrattenessero fra banditi, comunque erano tutti per la speculazione. Finalmente a Firenze trovai un banchiere, il Conte Pandolfi, che fu disposto al mutuo, ma pretese la fidejussione del nostro amico in tutto, Antoine Leboyer, per finanziarci di tre milioni, e pure a un tasso d’interesse veramente salato.
Anche l’anno successivo fui costretto ad appoggiarmi su Pandolfi, il quale però rincarò la mano con gl’ interessi.Al quel punto decisi due cose: fondare una banca nostra e trovare un appoggio politico. Ormai l’imbroglio politico era tutto. Chi faceva il nostro mestiere, non poteva sottrarsi. Le cose che fa il governo riguardano persino il più piccolo e povero atto della nostra vita quotidiana. Possono allargare o rimpicciolire il pane quotidiano.
La banca che facemmo fu opera di Andrea Camera, un vero esperto. La fece nascere in pochi mesi e senza molta fatica. In sostanza cedemmo i crediti della Ditta, che superavano ormai i due milio
171
ni, alla Banca di suo padre. Ottenemmo poi l’aiuto del Principe di Terranova, che ci dette fiducia per un milione, animando così altri grandi proprietari. In tal modo ci assicurammo il capitale necessario per la campagna olearia.
Sull’altro punto, la politica, la sfortuna volle che io conoscessi Ferdinando Surrenti sin dalla mia prima permanenza a Napoli. Lo incontrai nel 1873, ancora studente. Aveva visto l’insegna della Società ed era entrato in ufficio dicendo che era di San Policarpio e che la sua famiglia ci vendeva l’olio. Facemmo amicizia e andammo qualche volta assieme a teatro. Spesso l’invitavo a venire a cena da noi, in Sede, avendo a quel tempo un’ottima cuoca.
Non gli mancava niente. Era un giovane bello, istruito, ricco e serio. Si laureò e io lo rividi in Calabria qualche anno dopo; faceva già l’avvocato e con gran successo, sia il penale sia il civile. Era imparentato con i cugini Conforti, avendo Gerardo sposato una sua cugina.
A quel tempo avemmo una contestazione con un pastificio di Torre. Gli chiesi consiglio, ed egli mi consigliò di agire con decisione e subito. Siccome la questione era a Napoli, mi suggerì quale avvocato il nome di un suo ex professore, al quale avrebbe subito scritto e mandato la procura. Ora, tal tipo di procura poteva sottoscriverla soltanto mio padre ancora vivente (siamo nel 1877), che era a Capursi. Ferdinando, disinvoltamente, s’imbarcò sulla prima goletta in partenza, che lo sbarcò a Capursi, ospite dei miei genitori. Qui conobbe la mia sfortunata sorella Minicuccia e l’anno dopo si sposarono.
Si presentò alle elezioni del 1886, con la Sinistra, ma non uscì per quaranta voti. All’elezione successiva, mio fratello Generoso, io e nostro cugino Gerardo facemmo visita a tutti gli elettori del
172
Circondario, in maggioranza proprietari di oliveti, per pregarli. Spendemmo anche parecchi soldi di tasca nostra, così che Ferdinando fu eletto a maggioranza netta.
Speravamo parecchio da lui, ma costui ci tradì sfacciatamente, peggio di Giuda.
Questa è la verità. La racconto al cospetto di Dio Creatore e Artefice dell’Universo, che presto andrò a raggiungere. Io non ho mandato in rovina nessuno.
Non è giusto confrontarmi con mio padre. I suoi tempi furono diversi dai miei, per il grande incitamento che ci veniva dalla ricchezza di Napoli e dal commercio con la Francia e con l’Impero d’Austria. La Ditta era vissuta e aveva prosperato con il commercio francese, tanto al tempo degli Orleans, tanto al tempo dell’Imperatore Napoleone, quanto dopo, con la Repubblica. Io, invece, mi trovai a combattere con la rottura dell’alleanza francese. Il protezionismo doganale, voluto dai banchieri di Milano, rovinò Napoli e tutto il Napoletano, che vendevano olio e vino alla Francia. L’esportazione molto si ridusse, il commercio andò in crisi, tanto più che l‘Alta Italia non comprava granché da noi, a causa della sua grande povertà.
Per la Ditta il problema era l’olio lampante, che eravamo obbligati a comprare, se volevamo il fino.
Pensando che la nuova politica dell’Italia ci avrebbe dato un compenso nell’Impero, andai prima a Trieste, dove eravamo ben conosciuti per l’olio fino. Poi, con lettere di presentazione degli amici triestini, mi recai a Vienna e nell’Impero di Germania alla speranza di nuovi affari. Ma le industrie tedesche erano avviate sull’olio turco e greco. Inoltre l’industria del sapone consumava più sego che olio.
Con la nuova politica del governo, i proprietari furono rovinati. I
173
prezzi cadevano mese dopo mese. Chi aveva preso un anticipo di Lire 5000, prima ci pagava con Quintali 40 di olio, mentre con il nuovo prezzo doveva portare Quintali 50 o 60. Ottemperare ai contratti divenne veramente difficile. La produzione bastava appena a pagare le tasse. Il nostro credito crebbe in misura sbalorditiva. Molti ci debbono ancora dei soldi, che, al corso attuale sarebbero più di dieci milioni. Anche gli esportatori furono portati alla rovina. Nel giro di soli due anni, le Ditte che operavano in Calabria, in Puglia, nel Cilento, in Sicilia furono tutte chiuse, a causa dell’immobilizzo dei crediti. Il venir meno della Regia Banca toglieva loro pure la speranza. Ma noi resistemmo. Fummo gli unici a resistere qualche anno, merito della nostra Banca.
Mentre il Napoletano cadeva nella polvere, come corvi calavano i mercanti liguri. Capivano che con l’olio napoletano potevano molto allargare i loro affari. Diversamente che a noi, a loro i soldi non facevano difetto, perché il governo li trattava con larga manica. In Alta Italia c’erano molte banche e alcune imbrogliavano anche, stampando due o tre volte la stessa serie di biglietti, con frode allo Stato e al pubblico.
Impiegando quella moneta falsa, i genovesi tolsero alle antiche Ditte le loro piazze. Tentarono di sbarcare anche a San Policarpio, ma sul momento furono costretti a rimettere le vele al vento. I produttori erano informati che i loro soldi non erano buoni. Il Principe di Terranova li pregava di non tradirci.
Non potendola vincere con le buone, arrivò a Reggio un certo Cavalier Marugo, agente dell’Oliaria Ligure-Lombarda. Il Prefetto convocò mio cognato Ferdinando, solo Dio sa quale arma usò, sta di fatto che fu proprio Ferdinando a condurre l’operazione contro la
174
nostra Banca.
Devi sapere che in Calabria la moneta della Banca Nazionale non era ben accettata a causa degli scandali che già s’erano avuti. Circolavano soltanto i biglietti della Regia Banca.
Per obbedire al Prefetto, mio Cognato assoldò un certo professor Modestino, persona di pochi scrupoli e lo mandò in Banca, da noi, a cambiare un biglietto di mille lire della Banca Nazionale. Quando Camera gli rifiutò il cambio, irruppe il maresciallo con i carabinieri e arrestò Camera e il Cassiere. Era un abuso, ma la legge stava in mano a loro.
Passammo grossi guai, ma capimmo l’antifona, però, e decidemmo di vendere la nostra quota della Banca Agricola di Sconto. A resistere ci avremmo rimesso tutto.
L’anno dopo, il Cavalier Marugo corruppe anche Miniello, che era il ragioniere del deposito di San Policarpio. I genovesi dettero soldi anche a chi non ne aveva bisogno, rimettendoci molto. Ma loro non ci rimettevano niente di proprio, perché i soldi erano falsi.
Fratelli e cugini ci riunimmo a decidere per l’olio. Furono giorni di amari discorsi e anche di litigi, ma non c’era altro da fare che ritirarsi, se non volevamo essere distrutti.
Rinunziammo all’attività olearia e poco dopo, nel 1892, la Società si sciolse. La Banca fu acquistata dal Cavalier Marugo. Ma gli andò male. Infatti le banche genovesi furono scoperte a falsificare i biglietti. Il governo volle evitare il loro fallimento, e ciò fece con danaro dello Stato. Cambiò loro il nome e le fece andare avanti. Fallì invece l’Agricola di Sconto, che s’era riempita di soldi genovesi. Il povero Camera e il Cassiere, don Nino Focile, per evitarsi la galera e il di-sonore, si uccisero, lasciando due famiglie sul lastrico.175
Fu una lettura controproducente. Tranne la vicenda delle monete false, sapevo già tutto per averlo orecchiato dai discorsi di questo e di quello. Peraltro la cosa non era assolutamente credibile. Mi ritrovai dall’altra parte della barricata. Lo stato che avalla i falsari! Ma dove mai s’era vista una cosa del genere? Neppure un libro che ne parlasse!
Proprio ‘no sorece morto! Mi tornò in mente il nonno seduto allo scrittoio con i suoi gran fogli di carta non rigata e la penna Waterman che perdeva inchiostro, macchiandogli le dita. “Papà è un poeta”, diceva mia madre riferendosi al suocero. “Il nonno era un poeta”, pensai anch’io. Andai in salotto a cercare un album in cui erano conservate molte sue foto. Ne presi una che ci ritraeva assieme, sette o otto anni prima, mentre scendevamo le scale della Cattedrale, a Capursi.
“Che cazzo mi contate, nonno? Che pasticcio avete combinato, Voi, papà, zio Generoso? Vi nascondete dietro il dito, questa è la verità! Voi non siete i vinti di Giovanni Verga, come sostiene il professore Russo! Voi eravate pieni di soldi! Ve la siete fifata, questa è la verità! Non vi piaceva Genova? Allora vi armavate, e marciavate contro! L’olio, l’Impero d’Austria e l’Impero di Germania, Trieste? Ciance! Non avete voluto combattere! Se foste stati uomini, avreste combattuto la vostra battaglia, come stanno facendo adesso i partigiani del Nord. Uno sbaglia, fa il fascismo, ma poi si rende conto d’aver sbagliato e caccia i fascisti. Così si fa, non come voi.
“La Ditta è finita, fai il medico, fai l’ingegnere!… Sì, miei cari, Faccio l’ingegnere, faccio il medico, non faccio il commerciante! Io amo Vitulia e Vitulia mi ama. E me ne fotto di voi, di zio Ferdinando e dell’anima sua, du Siccia e du Siccicella….Io voglio Vitulia…”
*176
I contadini entrarono in fermento qualche mese dopo la caduta del fascismo, sotto la spinta dei vecchi militanti della sinistra, specialmente dei quadri rurali del Partito Comunista. Le notizie di sommovimenti e di occupazioni di terre erano frequenti. La situazione era divenuta poco incoraggiante per i gnuri. Il fondamento dell’agitazione contadina era ancora quello di Caio Gracco, la divisione delle terre. Certamente, la maggior parte dei contadini capiva che, se non c’era lo stato italiano, c’erano però gli americani. Perciò si frenavano. Ma qua e là il muro della paura veniva abbattuto.
Nella sezione socialista di San Policarpio il problema non era considerato attuale. I vecchi del partito erano fermi all’idea che, senza lo sviluppo dell’industria, era impossibile pervenire a una piccola proprietà coltivatrice. “Sono in troppi e la terra è poca. Solo lo sviluppo dell’industria può risolvere il problema. Una parte deve passare all’industria… Si tratta di un movimento naturale, che il fascismo ha frenato… Lo vedete dai fornaciai…Prima erano contadini, ora sono operai… Come in America. Avete mai visto che dall’America torni un contadino?… Partono contadini e tornano operai.”
La rivoluzione di Amendolea scoppiò sul finire del marzo 1945, in corrispondenza con le notizie che arrivavano dal Nord circa l’azione rivoluzionaria dei partigiani comunisti. I contadini s’impadronirono del paese, sottoposero i gnuri a dure pene e fondarono una repubblica rossa. Don Mico e gli altri compagni di San Policarpio giudicavano il fatto un gesto folle.
Avendo ben altro per la testa, Amendolea m’interessava poco. Frequentavo la sezione solo per distrarmi. Soffrivo per l’assenza di Vitulia, e non sapevo cosa pensare. Un amico mi sussurrò che la cameriera dei Surrenti aveva detto al panettiere che Vitulia era partita per
177
Roma, per rifugiarsi dal nonno Aversano. Ciò mi indusse a pensare al peggio. A Roma era libera di scrivere, di mandare un telegramma. Eppure non lo faceva. In realtà niente di ciò era avvenuto. Una sera Pietrino Futia fece capolino alla porta della sezione e con un segno mi invitò a raggiungerlo. -“Vitulia ti aspetta a casa della maestra di pianoforte”.
Quando bussai, Vitulia venne fuori e mi guidò verso la spiaggia. Mi disse che non sarebbe più tornata a casa. Intendeva fuggire. “Stai seguendo gli avvenimenti di Amendolea?”. La domanda mi prese in contropiede. Mi aspettavo ben altro. Balbettai che consideravo la rivoluzione una pura follia.
“Ti sbagli. E’ l’occasione per portare allo scoperto l’ipocrisia che ammorba l’azione del partito. Così come vanno le cose non facciamo un solo passo avanti.”
“Di Amendolea stavamo parlando… In sezione prevale lo scetticismo, in pratica sono tutti contrari.”
“Non mi sono spiegata. Bisogna schierarsi senza perplessità. Partecipare alla rivoluzione. Chi ha avuto la forza di sollevare la testa merita di essere seguito.”
Capii che Vitulia stava vivendo un momento di esaltazione, una condizione vicina alla follia. Cercai di ripararmi dalla tegola che stava per cadermi in testa. “Ma sono solo duecento persone. Nessun altro luogo si è mosso…Sono circondati dai carabinieri. Ho visto con i miei occhi che hanno carri armati e autoblindo.”
“Ha ragione Racco, la rivoluzione o vince adesso o non vince più….E’ un evento grande ... troppo grande ... Bisogna partire …Comunque sia, non voglio vivere staccata da te … Per stare assieme non è necessario sposarsi. Siamo un uomo e una donna già capaci d’amarci…Mio
178
padre l’avremo sempre contro… No, non ci perdonerà mai, non darà mai il suo consenso…L’hai troppo offeso, gli hai guastato chissà quali piani…”
“Per la verità – pensai - io sono stato soltanto un ciuco tirato per la cavezza.” Ma non mossi obiezioni. L’idea di stare assieme mi sbrigliò la fantasia e mi fece perdere il lume della ragione.
Decidemmo di partire la sera, verso le nove. Avevo paura. Se anche l’avessimo scampata, avrei fatto la figura del cretino. Già difendere Vitulia da una violenza sarebbe stata un’impresa. Il rischio era grosso. Accompagnai Vitulia nella casupola ‘i Peppi du Giocondo, un vecchio pescatore abbandonato dai figli trasferitisi a Genova, a cui di tanto in tanto portavo qualche aiuto, e corsi a casa. Di soppiatto presi la pistola di papà e la sua torcia elettrica, rubai trentamila lire dal portafogli della mamma. Mi venne anche in mente di provvedermi di biancheria pulita, ma avendo notato che Vitulia non ne aveva, non volli strafare. Presi invece la mia bicicletta e quella di mia sorella.
Alle nove imboccammo il Dromo, l’antica carrabile bizantina che ancora scorre alle spalle delle marine joniche. La strada era in pessime condizioni e non percorribile il bicicletta. Le abbandonammo al loro destino e proseguimmo a piedi. Incontrammo un carro con i buoi e per trecento lire il massaro ci dette un passaggio fino alla sua stalla. Poi, ancora tre ore di cammino e arrivammo ai piedi della collina di Amendolea. Era già giorno. Dovevamo evitare le pattuglie dei carabinieri. Ne scorgemmo una appostata sul ciglio d’una fiumarella. Siccome vedemmo i militari prima che loro vedessero noi, avemmo modo di nasconderci. Quando s’allontanarono, attraversammo il torrente - in gran parte asciutto come tutti gli altri che incontrammo - dove gli isolotti erano più ricchi di cespugli e prendemmo a salire
179
la collina.
I miliziani di Racco ci bloccarono subito. Dicemmo i nostri nomi, sostenemmo d’essere anche noi dei rivoluzionari, ma non ci dettero credito. Ci guidarono fino a un pianoro, in vista del paese. Lì ci bendarono gli occhi con delle salviette di spesso cotone, quelle che si usavano per portare la spesa. Camminammo ancora un po’, tirati per le braccia. Quando ci fecero fermare, restammo bendati in attesa del capo. Aspettammo più di un’ora. Alla fine ci tolsero la benda. Ci trovammo davanti a una persona di circa cinquant’anni, che aveva l’aspetto di un signorotto di paese, di un contadino imborghesito e acculturato. Ci ascoltò con molta attenzione e senza sollevare obiezioni. Dopo di che disse con paterno garbo: “Non possiamo accettare il primo venuto. Qui si combatte, si rischia la vita. Voi, nessuno vi conosce. In teoria…dico senza offesa…potreste essere delle spie. D’altra parte siamo già in molti al confronto con le armi disponibili. L’unica cosa utile che potevate fare era di sollevare i contadini di San Policarpio… Mi dispiace ma dobbiamo arrestarvi.”
Fummo condotti al castello, in cima al paese; un luogo che avevo visto un paio di volte dall’esterno. Attraversammo un portale senza infisso, poi l’alta galleria che portava al cortile, quindi il cortile. Entrammo in un lungo corridoio, che appariva persino basso in rapporto alle misure del luogo, ma che basso non era certamente. Superammo ancora una decina di portali. “Dove cazzo ci vogliono rinchiudere? Speriamo che non ci buttino dalle mura!” Salimmo, scendemmo. Non si finiva mai. Arrivammo a un locale munito di porta. “Ci chiuderanno lì dentro” pensai. Fu così. Era una vecchia sala senza pavimento e senza intonaci. Un grande apertura dava sulla valle. Il balcone doveva essere caduto qualche secolo prima. Oltre c’era il precipizio.
180
Ovviamente la porta venne rinchiusa dall’esterno con un catenaccio. I due militi rossi salutarono con garbo prima d’andarsene. “Pazienza, compagni…Vedrete che la cosa s’aggiusta.” Per sfuggire alla polvere, e alla puzza che saliva dal terriccio mosso dai nostri piedi, ci accoccolammo davanti al balcone. Di tanto in tanto si udiva un colpo di fucile, per il resto regnava un silenzio campagnolo. La battaglia era finita o doveva cominciare? E quale sarebbe stata la nostra sorte? Vitulia, era come se non avesse paura. Dissertava di grande politica, ma io non riuscivo a prestarle attenzione. Mi attraeva di più il ronzio dei calabroni e il volo delle vespe, che s’avventavano in picchiata sui cespugli cresciuti fra le crepe delle mura. Forse fra qualche ora mi sarebbe toccato morire. Il mondo era bello. Dall’alto del castello, le brevi valli, che in primavera andavano riempendosi di verde e di altri colori, pareva potessero essere toccate allungando appena una mano. Di là a non molto, fra le margherite sarebbero cresciuti prepotenti i papaveri. Il rossastro della sulla avrebbe inondato i declivi. I bianchi triangoli delle vele si sarebbero moltiplicati sul mare…I consi sarebbero andati lontano, oltre il turchino…Morire!…Mio padre…mia madre… la nonna… gli occhi mesti di zio Gioacchino…Vitulia…il mondo…
A mezzogiorno ci portarono del pane, delle olive e una cuccuma d’acqua. Arrivò il crepuscolo, poi scese la notte. Già dormivamo per terra abbracciati, allorché sentimmo aprire la porta. Apparve una persona con una lanterna in mano. Dietro di lui un campagnolo alto e secco. “Venite con me, domattina arrivano i carabinieri”. In modo deciso, quasi imperioso, ripeté: “Venite con me”.
Uscimmo dall’abitato. Lentamente scendemmo la collina – un bosco di ulivi contorti. Finalmente apparve la luna. Giunti a un casolare, l’uomo ci fece fermare. Si allontanò da solo per qualche minuto. Tornò con
181
una mitraglietta tedesca, leggera e maneggevole. “P’amuri d’u Signuri, nommu ‘nci sparati d’i carbineri… Sulu p’a signurina… S’i viditi arrivari, jettatila prima”. Camminammo ancora una ventina di minuti. “Di qua si scende ‘a hjiumara… Il pericolo è quando attraversate. Dopo, non fate il Dromo, adesso ci sono i carabinieri…Attraversate i campi. E ricordatevi che a San Policarpio soltanto la vostra famiglia sa che siete venuti qui.” Ciò detto scomparve per un viottolo la cui esistenza non avevo notato.
In quell’intervento era fin troppo evidente la mano di Giomo. Anni dopo mi fu confermato. Papà, notata la scomparsa della pistola e della pila, e appurato che ero a girare in bicicletta con Vitulia, aveva mangiato la foglia. Dopo di che era ricorso all’unica persona capace di dargli una mano in un frangente del genere.
I carabinieri che cingevano l’assedio avevano piazzato dei fari sulle autoblindo per intercettare gli eventuali fuggitivi. Mentre scendevamo verso il fiume, si accese un faro, un fascio di luce violentò il buio e ci inquadrò. Commisi l’errore di sparare. Il faro fu colpito in pieno. Avvampò per qualche secondo una mitragliera, ma subito s’inceppò. Altri fasci di luce, per fortuna più lontani, si diressero dalla nostra parte. Scappammo senza capire dove, inseguiti dallo strepitio di motori e dal frastagliare di mezzi cingolati. La paura ci mise il vento nelle gambe.
Raggiungemmo l’alveo asciutto di un torrentello. Ci agguattammo fra i cespugli e aspettammo lì che il nostro destino si compisse. Passò del tempo, arrivò il giorno. Intorno a noi regnava un pauroso silenzio. Poi salì il sole, e il silenzio divenne meno pauroso. Ci allontanammo con circospezione. Prendemmo a salire verso i monti. Procedemmo per parecchie ore poco lontano dal margine di un fiume, senza incon
182
trare anima viva. A un certo punto, però, il percorso si fece impervio. Abbandonammo quella direzione di marcia a favore di un più dolce sentiero collinare. Andavamo avanti inseguendo una meta: le alture boschive. Ma quando ci pareva di aver raggiunto il traguardo, rappresentato dalla cima di un colle, restavamo delusi. Sotto di noi si stendeva un’altra valle, e lontana un chilometro si vedeva un’ulteriore trincea collinare da conquistare.
Verso le dodici ci sedemmo all’ombra di una quercia. Passò un vecchietto seguito da quattro pecore e da un cane. “Siete i figli del barone?”
“Sì”.
“E il barone come sta?”
“E’ a Napoli.”
“Mu salutati…Anima santa…Sempre bene mi fici. Dicintici ‘u Filippu i Betta…”
Stanchi morti, affamati e assetati, restammo lì. Solo ci spostammo dall’ombra della quercia, dove la frescura era troppa, all’ombra di un pero. Sentendo che gli occhi mi si chiudevano, nascosi la mitraglietta in un cespuglio, mi avvinghiai al corpo di Vitulia e lasciai che il sonno mi vincesse. Riprendemmo il cammino verso le quattro. Adesso, però, eravamo in cerca dei nostri simili, in modo d’aver da bere e da mangiare. Ci dirigemmo verso il pennacchio di fumo più prossimo. Vedemmo un ricovero fatto di pietre sovrapposte e lì presso un anziano pastore con una trentina di pecore e tre cani. Gli detti cinquecento lire e avemmo in cambio acqua, latte, pane, formaggio, castagne infornate e noci a volontà, più due coperte militari.
Prima del crepuscolo il vecchio chiuse le pecore nella staccionata e andò via, lasciando l’abituro tutto per noi, e anche le fascine per ali
183
mentare il fuoco, nonché la compagnia delle pecore e dei cani.
“Starà andando a denunciarci”, osservò Vitulia.
“I carabinieri sono la cosa che mi spaventa di meno”, ribattei, mentre giuravo a me stesso che avrei difeso Vitulia fino alla morte.
Il pastore ci ricomparve davanti il mattino appresso, quando il sole era già alto nel cielo e i vapori addensati nei fondivalle dileguavano. Stavamo affrontando la scalata di un’altra collina. “So chi siete voi due… Sì, lo so, non avete paura… Vi dico la strada…Salite fino a quei faggi lì…Li vedete?…Quando siete lì, andate avanti cento metri nella direzione opposta al sole. C’è una timpa. Da lì sopra, guardate sotto. Sotto si vede un sentiero largo per i carri. Mezzora di cammino. Ma voi non andate al sentiero. Vi fermate vicino e aspettate. Viene uno a prendervi.”
“Di nuovo Giomo”, pensai. “Siamo salvi”, ma non profferii verbo.
Così avvenne. Ci incamminammo dietro un uomo sui quaranta, muto come un pesce. Questi seguiva un tracciato incomprensibile. Pareva che vagasse a caso. Invece raggiungemmo un viottolo più largo degli altri, in cui era intuibile una professionale opera dell’uomo. Incontrammo una fonte. L’acqua si versava in una piccola gebbia adatta a lavare i panni. Vitulia chiese che ci fermassimo perché voleva lavarsi. “Ancora dieci minuti e potrete lavarvi al riparo.” Infatti raggiungemmo una casetta in muratura di recente costruzione, con porta, finestre, vetri alle finestre, pergola, sedile di pietra, vasi con cespugli odorosi. La chiave era nascosta fra le tegole della pinnata. L’uomo la trovò con sicurezza, aprì e accese il fuoco nel caminetto, poi prese due giarrette e andò a fare un rifornimento d’acqua.
Più tardi arrivò un ragazzino con due panieri. Nel primo c’erano pane, salciccia da arrostire e vino, nel secondo biancheria pulita.
184
Mentre aspettavamo che Vitulia si lavasse in libertà, l’uomo mi guidò in cima alla collina. La zona dell’ulivo finiva lì. Di fronte a noi si alzava una montagna boscosa. “Io torno da dove venni. Domani, certo non partite. Siete stanchi. Qui potete stare tutto il tempo che volete, basta che non vi fate vedere in giro. Quando decidete, mettete una polverina sul fuoco. Ve la mando con il ragazzo…Una pizzicata per volta, per un’ora di seguito…Fa un fumo giallo. Io lo vedo e capisco. Quando partite, vi dirigete sempre verso quella frana là…
“Vi do il lapis e la carta, così ve lo scrivete…Prima passate tra la frana e la collina di fronte…La vedete?… Arrivati al fiume, camminate controcorrente. Però lontano dalla fiumara, sennò vi vedono. Così evitate i boschi della Serra. Quando il fiume gira in salita, voi invece andate dritto, e vedete subito, sulla collina di fronte, una casa con le tegole rosse. Voi andate lì. Lì mangiate e dormite. Non entrate nel paese vicino, invece scendete a valle e incontrate un altro fiume. Vi fermate lì… Qualcuno verrà a guidarvi verso un’altra casa. La mattina dopo, tre ore di cammino e sarete alla stazione del Pizzo. Prima di entrare in paese, una donna vi vede e vi dà due valigie con l’olio. Così passate per contrabbandieri. Gli sbirri non ci sono. Vengono solo di tanto in tanto. A Napoli e a Roma stanno morendo di fame, e loro lo sanno. L’olio lo pagate quando tornate. Vi saluto, la signorina me la salutate voi.”
Quella notte, al tepore del fuoco, i sangui, che non dovevano congiungersi, si congiunsero. Rimandammo la partenza di giorno in giorno. Il cartoccio con la polvere gialla era ben in vista sulla credenza, ma il tempo passava e la voglia di aprirlo non ci veniva. Sono stati i giorni più belli della mia vita. Forse lo furono anche per Vitulia. Ripresi a chiamarla Lia, un diminutivo che prima non le piaceva. Due
185
corpi e un’anima sola. Non avevamo più paura della galera, o forse il compenso anticipato che ci prendevamo poteva farcela apparire un prezzo non elevato. Lo stesso ragazzino incontrato all’arrivo ci portava qualunque cosa chiedessimo, pure il giornale. Pagavamo con i soldi che avevo, ma se avessimo chiesto credito, l’avremmo certamente ottenuto.Eravamo freschi e nuovi all’amore. Stare assieme era un rinascere tutti giorni. Al mattino, prima che i vapori addensatisi durante la notte evaporassero, uscivamo all’aperto con una coperta sulle spalle, a vagare fra le querce e i castagni, che rimettevano foglie di un tenero verde. Sui costoni esposti a mezzogiorno era un tripudio di ginestre. Ma bastava spostare lo sguardo perché i colori cambiassero. In basso, due, trecento metri sotto di noi, le siepi di fichidindia disegnavano geometrie fantasiose tra i campi messi a grano, le vigne, i maggesi. Forse saremmo rimasti lì all’infinito, ma fu proprio quel vagare per i sentieri boschivi che ci perse. Sempre più spesso scorgevo delle sagome di ragazzini mal nascosti dalle siepi, intenti a spiare.
Una notte ci svegliò uno sconosciuto. Veniva ad avvisarci che stavano arrivando i carabinieri. Corremmo nella direzione che l’uomo ci aveva indicato prima di scomparire, ma – lo seppi molto tempo dopo – a causa del buio, sorpassammo senza notarlo il sentiero da imboccare. I carabinieri accesero i fari della jeep solo quando fummo davanti a loro. Ci misero le manette senza fare una sola domanda. Fummo portati in caserma a Serra San Bruno, e subito separati. Io chiuso in cella di sicurezza, Vitulia altrove. Non seppi dove. La rividi soltanto undici anni dopo, e soltanto per qualche ora. Per i fatti di Amendolea non fu denunziata né, tantomeno, processata. Né, al processo, qualcuno fece parola della sua presenza.
186
Incriminato con gli altri rivoltosi per insurrezione armata, fui condannato a quattordici anni, sei mesi e sedici giorni di galera. Uscii dopo undici anni, sei mesi e diciotto giorni, in virtù di un condono. In carcere ripresi gli studi e conseguii la licenza liceale. L’anno dopo ottenni il trasferimento a Genova e il permesso di frequentare le lezioni universitarie sotto custodia pagata. A ventisette anni presi la laurea in ingegneria navale; un passaporto per espatriare, sull’esempio di zio Paolino Conforti.
I genovesi con me non furono ostili come lo erano stati con la vecchia Ditta. Da ragazzino spesso avevo sentito il nonno declamare dei versi che li maledicevano. Pensavo che la composizione fosse opera sua, che tanto li temeva, ma, arrivato poi in liceo, appresi che quella invettiva era opera di un poeta ben più illustre. Però io non fui oggetto di alcuna ”magagna”. Anzi quasi tutti - le guardie e gli altri carcerati - furono sempre benevoli con me. Forse perché, tutte le volte che veniva a trovarmi, papà non faceva che distribuire bigliettoni “non falsi” a destra e a manca. Certamente disinteressata fu la paterna amicizia del professor Valerio Correggio, docente di grandi macchine navali, il quale mi prospettò, una volta scontata la pena, la possibilità di un lavoro nei cantieri genovesi. Forse le famose magagne, i genovesi, le mettevano in essere in materia d’affari. Ma io non potrei affermarlo.
Il 14 dicembre 1956, il mio difensore, professor Mario Gianturco, appositamente arrivato da Napoli, mi accompagnò “per l’uscita” insieme al direttore del carcere. Avevo trent’anni. Fuori, ad aspettarmi, c’erano tutti, tranne la nonna, ormai novantacinquenne: la mamma, papà, Celeste con suo marito, zia Giuditta, zio Filiberto, Enea e moglie, Lucilla e marito, zia Anita con Mario e Mena, due dei suoi cinque figli. Accanto a papà vidi Vitulia e il ragazzo, che lei teneva per mano.187
Fu l’ultima ad avvicinarsi. Ci salutammo con il rituale accostamento delle opposte guance, in uso tra parenti. Dentro di me scoccò lo stesso brivido di quindici anni prima.
Poco prima dell’ora di pranzo potemmo rimanere soli: lei, io e Paul. Per l‘anagrafe Paul Surrenti. La sua enorme bruttezza mi addolorò e mi spaventò. Era una copia du Siccia, più brutta dell’originale. Mi venne da ridere al pensiero che potesse portare jella come il nonno. Ma subito inorridii di me stesso.
“Adesso vivo a Bruxelles. Ho paura di venire in Italia…”, dichiarò, quasi a innalzare una barricata tra presente e passato.
“Sì, lo so. Leggo le corrispondenze che mandi all’Avanti. Ti ho visto con Nenni alla televisione…”
“Il nonno mi ha salvata. I carabinieri mi portarono a Vibo. Dopo un pò arrivò l’onorevole Arlotta. Non avevo fatto niente. Non avevo sparato, avevo partecipato al moto solo con il pensiero. I carabinieri si convinsero, e l’onorevole mi condusse a casa sua. La mattina dopo venne il nonno. Chiamò papà, ma questi non volle vedermi. Vennero soltanto la mamma e mio fratello Nandino. Partii per Roma con il nonno. Mi spiegò che una mia incriminazione non ti avrebbe aiutato, mentre avrebbe molto danneggiato non solo lui ma anche papà. Il nonno mi accompagnò a Le Havre, dove mi imbarcai per New York. Da New York andai a Washington, come consulente dell’ambasciata d’Italia per i problemi dell’emigrazione. Però, dopo la morte del nonno il contratto non mi venne rinnovato.
“Certo lo sai già. La mia famiglia mi ha voltato le spalle.. Dopo la morte del nonno sono stati Sara e Genso ad aiutarmi… Buoni e generosi al di là del richiesto e del necessario… per il bambino…”
“Non lo sapevo. E’ la prima volta che lo sento.”188
Mi prese la mano e mi fissò intensamente. “Paolo, io ti ho amato appassionatamente, e tu lo sai. Nostro figlio…un figlio che non ho rifiutato, che ho voluto per te… per noi, nonostante i contrari suggerimenti…
“Ti sono stata fedele, fedele nell’anima e nel corpo per anni, poi ho incontrato un altro. Un uomo assolutamente diverso, Karl Liuvrat…un pianista…Certo lo hai ascoltato l’altra sera in televisione; uno che ti fa vedere l’armonia del cielo stellato anche quando il tuo animo è buio.”
In quella circostanza, se fosse stato presente Giomo, avrebbe esclamato: “Vi sta prendendo per il culo”. Mi caddero le braccia. Proprio letteralmente. Un fendente di amarezza mi spaccò il cuore: “O sorece morto a rinto ‘o pertuso…”
“Bene… Vitulia… forse… dico…Sei libera…Ognuno è padrone…”
“Genso e Sara vogliono che tu chieda il riconoscimento della paternità. L’avvocato Gianturco ha voluto una mia dichiarazione a riguardo.”
“E secondo te, io, quel mese che, come tu dici, avrò il bambino, andrò in giro con lui per San Policarpio? Quando passeremo sotto casa tua, quando per caso incontreremo Norina o Totò faremo finta di niente? Questo bambino, oggi si chiama Paul Surrenti. Fra sei mesi si chiamerà Paul Alfano. Ma quando leggerà sul cantone di casa “Piazza Ferdinando Surrenti”, ti pare che non si ricorderà che Surrenti era anche il suo cognome? Cosa dovrei dire o fare io?”
“Non sapevo che hanno dato il nome del nonno al Caricatoio. E’ un notizia...”
“A me non va giù, Vitulia. Non è una questione di famiglia…E’ la
189
storia… Chi ha creato San Policarpio quasi dal nulla? ”
“Gli Alfano sicuramente…Ma vuoi mettere la storia di San Policarpio con la storia d’Italia? Un uomo di stato! …il governo del paese!… ”
Tornai a San Policarpio dopo una breve vacanza sulla Costiera. Ma in albergo. Dopo la guerra, il palazzo avito era stato requisito dal comune per gli sfollati. Anche a San Policarpio i magazzini del vecchio fondaco erano affittati a un plotone di piccoli negozianti e di artigiani. Ancora qualche vecchio usava l’espressione “al caricatoio”. Ma proprio pochi. Di regola, tutti dicevano Piazza Surrenti.
In paese non sapevo cosa fare. La vecchia ruga era sparita e i suoi coristi erano dispersi per il vasto mondo. Mio padre, adesso, vendeva concimi. Era l’agente generale per la Sicilia e la Calabria della Nitr-Az spa di Ravenna e se non era in giro a visitare la clientela, stava a Catania. Lo accompagnava sempre una segretaria-autista a bordo di una lussuosa Aurelia. “Mi sono ridotto a vivere di percentuali. Quanto più saliamo nel reddito, tanto più scendiamo socialmente.”
“Papà, perché non riapri il negozio?”
“E quando muoio a chi lo lascio? A te, a tuo figlio, ai figli di Celeste? …Tu hai un mestiere, e non ti conviene lasciarlo. Io ho un mestiere nuovo, e non mi conviene lasciarlo…Quale negozio, figlio? E’ una questione di potere, quanto comandi. Papà lo chiamavano padrone, a me mi chiamavano principale. A te ti chiamano ingegnere, ma lo stesso andrai sotto padrone. A me mi chiamano dottor Alfano, e sto sotto padrone. Il nostro comando è finito…A comandare sono altri, e dobbiamo riconoscere che ci sta andando anche bene…Ho persino un dipendente. E Vincenzino Caracciolo mi vuol far nominare nientedimeno che commendatore dell’ordine non mi ricordo più di quale
190
santo…Cinquantamila lire e ho la medaglietta.”
La mamma, sola e mesta, lamentava continuamente che Celeste non volesse affidarle i suoi bambini. Alle nove del mattino inforcava gli occhiali e ricamava per l’intera giornata. Era come se dovesse campare con quella fatica. Sestia, rimasta zitella, le stava accanto. La nonna non c’era più. Celeste, bisognava fare mille e settecento chilometri per vederla.
Quando andavo alla Vasia, Giomo tirava fuori, dio solo sa da dove, un vecchio modello ’91 e facevamo a gara a chi era più bravo a centrare una pala di ficod’india. Avevo conservato l’abitudine contratta in carcere di alzarmi presto. Il primo pensiero era ai pescatori. Mi affacciavo al terrazzo con la speranza di vederli all’opera nell’armoniosa fatica di tirare la sciabica, ma ormai i consi erano spariti per far posto ai motopescherecci, che però andavano a ormeggiare lontano dal caricatoio, alla cala della Rocchetta. Ora i pescatori guadagnavano abbastanza per il pane e il companatico, nessuno di loro faceva il facchino. Della vecchia ciurma erano in vita soltanto ‘u Zippina, ormai accecato dal tracoma, e ‘u Gustinu, sempre povero e solo. Qualche volta, al pomeriggio, mi sedevo con loro sul sedile posto all’ombra del fondaco. Rinvangano il loro errare sui vapori. Il Bosforo, Alessandria, il Pireo, Buenos Aires, regina della felicità, Liverpool, signora del mondo, chigli cazzuni di mericani, le tempeste nel Golfo del Leone, la rotta infida del Mare di Biscaglia, le montagne di carbone spalate, le patate da sbucciare a sacchi, le botti di vino e d’olio scaricate a Marsiglia.
Ammazzavo il tempo per vincere l’umiliazione che Vitulia mi aveva inflitto, il vuoto della sua pelle sotto il palmo della mano. Undici anni di vani sogni. La notte dormivo male. Stavo meglio in carcere. Quando uscivo di casa, mi sorprendeva il non vedere più intorno al fondaco il
191
formicolio di carri, asini, muli, camion, massari con la vertola appoggiata sulla spalla sinistra, venuti a caricare le mille mercanzie che il negozio offriva. E poi, a leggere il nome di zio Ferdinando sul cantone di casa, mi giravano le palle. Ma dovevo su-bire in silenzio. Guai a dir male dei Surrenti in piazza. Tutti grandi personaggi.
Totò continuava a essere il sindaco del paese, e certamente prima o poi sarebbe stato eletto deputato. Le poche volte che ci incontrammo, facemmo finta di non conoscerci. Egualmente con i fratelli di Vitulia. Di Norina seppi che non usciva più di casa. Zia Minicuccia era morta da tempo.
Nella primavera del 1957 mi imbarcai per l’America con il viatico di una lettera di papà. A Boston ottenni un buon lavoro. Paul mi raggiunse nel 1963 per chiedermi di aiutare sua madre. L’anno prima Karl aveva avuto un ictus ed era rimasto paralizzato. Erano sopraggiunte notevoli difficoltà economiche. Vitulia non riusciva a rientrare nei quadri del giornalismo, che aveva lasciato per seguire il marito nei suoi spostamenti. Paul decise di rimanere con me e assunse il mio cognome anche in America, dove era nato con un cognome diverso. Dopo di che andò a studiare agraria in California. Quando prese la laurea, volle che ce ne tornassimo in Italia per trasformare ‘a Vasia in un’azienda moderna. Io trovai lavoro a Messina, nel cantiere Diaz, che costruiva navi-traghetto.
Dovetti sistemare la posizione economica di Paul, in modo che potesse provvedere ai bisogni della madre. Barattai con mia sorella il palazzo e il giardino di Capursi, che erano un legato del nonno a mio favore, con la sua quota sull’eredità di nostra madre e nostro padre a San Policarpio. Cioè il convento, ‘a Vasia e ‘u Fego. Non fu un buon affare. Con lo sviluppo del settore turistico, palazzo e giardini
192
valevano ormai moltissimo. E fu anche un tradimento del nonno che, per lasciarlo a me, aveva scavalcato mio padre e zia Anita. Ma feci contenta Celeste e suo marito, un irpino bello e gentile, con studio dentistico a Berna. Naturale che le sue vacanze preferisse farle sul Tirreno, non lontano dal borgo natio. Guadagnando molto, era altresì naturale che gli piacesse possedere un palazzo signorile. D’altra parte, se Celeste avesse voluto trascorrere un giorno, un anno, la vita a San Policarpio, al secondo piano del vecchio convento, che mi ero riservato, c’era posto ancora per venti persone. Moralmente quella casa era anche sua.
Giomo capì che con Paul sarebbe stato difficile andare d’amore e d’accordo. Come liquidazione chiese ‘u Fegu ed io trovai giusta la richiesta. Tranne che per i profitti annuali, era stato il vero padrone della Vasia. Anzi quella terra era la sua opera d’arte. Con un atto notarile complesso feci irrevocabile donazione della Vasia a Paul, così avrebbe aiutato la madre senza ricorre a me, e devolsi a Giomo, a titolo di pagamento della buonuscita a cui aveva diritto, la proprietà du Fegu, che mia madre aveva ereditato da suo padre. Americanamente parlando, Paul si è rivelato un agricoltore brillante e un abile uomo d’affari. Per prima cosa fece tabula rasa dei diecimila aranci piantati da Giomo. Con il che incassò un contributo governativo. Al loro posto creò una piantagione di gelsomini, incassando un secondo contributo governativo. Poi, quando il prezzo della concreta di gelsomino cadde, fece tabula rasa dei gelsomini e impiantò un prato irriguo, con relative mucche e relativi maiali, incassando un terzo contributo. Poi cambiò ancora, passando alle fragole. Adesso produce fichidindia.
Mentre attuava le sue rivoluzioni agrarie, ha preso in moglie Mara
193
Diaz, la figlia del mio principale. Un gran matrimonio, dal quale sono venuti due nipotini, Lia (Vitulia) e Lino (Paolino); figli allattati coi soldi, che amo con molta cautela, come amo con molta cautela il padre loro.
Per via della sua intraprendenza, Paul si è guadagnata la stima dei policarpiesi, e non è improbabile che succeda come sindaco a suo zio Nandino, allorché questi si deciderà a lasciare l’incarico.
*
‘O votta votta. Le generazioni si susseguono. Crisciru i sambuchi e ammucciaru i sipali. La badante polacca guida il passo claudicante di Karl fino al bordo del caricatoio. L’on. Vitulia Surrenti, settancinquenne come me, li segue con passo misurato e un golfino appeso al braccio. E’ una vecchietta elegante. Lì giunti, i tre si siedono su una delle panchine che il comune ha fatto istallare da poco, e guardano il mare. Mi siedo anch’io sulla poltrona di vimini che risale a mia madre, e anch’io guardo il mare dal terrazzo: il lontano orizzonte, il mare dei consi, l’irraggiungibile turchino. Lentamente gli occhi si chiudono dietro i pensieri. Fole, chimere dalle ali rosate scorrono sotto la fronte. Sogno d’essere il capitano di una galea. Sul pennone di mezzana sventola il pesante stendardo della Repubblica. La nave lascia il porto d’Amalfi e veleggia verso le lontane coste di Normandia. Spiagge infinite, l’immenso verde del mare. Guerrieri dalle nere casacche e dai forbiti elmi scintillanti al sole, su agili imbarcazioni remano sopravvento. Sulla prua della più veloce, Vitulia agita uno stendardo che muta colore a ogni soffio di vento. E’ ancora diciottenne, ma non è più bianca. E neppure nera. E’ creola come le donnine che incantavano ‘u Testazza. Con indosso una corta tunica da schiava, lo stendardo in mano, balza sulla murata della nave e li si erige, morbida e invitante. Ha impresso in volto il sorriso mesto e accogliente che ha la statua di Gesù risorto,
194
la mattina di Pasqua. Dai boccaporti spuntano frotte di topi. Hanno mille facce.?Portano fiori artificiali, fabbricati con gli sfilacci del cordame.
Mentre sto a guardare senza capire, sul mio corpo spuntano i peli immondi del sorcio. Il terrore m’invade. Voglio buttarmi in mare, ma l’alta figura di zio Paolino mi stoppa con un braccio. “Aspetta, metti il salvagente!”
Mi affaccio alla murata e guardo giù.
“Ma, Zio Paolino, non è acqua. E’ olio. Affogheremo!”
“No, ti sbagli. E’ Nutella.?E’ grassa, pesante. La nave è perduta. Non c’è più niente da fare, ma noi ci salveremo. La Nutella ci terrà a galla e ci nutrirà, e noi, piano piano, raggiungeremo la sponda.”
|
Per comunicare con Nicola Zitara potete inviare un messaggio breve anche senza dover indicare il vostro indirizzo di posta elettronica:
Se volete inviare una email a Nicola Zitara:
Email per Nicola Zitara - Yahoo
Se, invece, volete inviare una email a Nicola Zitara usando il nostro indirizzo:
Buona navigazione e tornate a trovarci. |
Ai sensi della legge n.62
del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e
del web@master.