

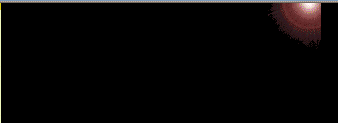
|
Ci aveva parlato di questo aritcolo Antonia Capria vedova Zitara, noi lo abbiamo cercato sul web e lo abbiamo trovato presso il Centro studi Piero Gobetti che ce ne ha inviato copia cartacea. Non abbiamo mai commentato gli articoli di Zitara e non cominceremo certo ora, quindi lo mettiamo a disposizione di amici e naviganti. Nel formato ODT - PDF troverete dei caratteri in rosso, sono una nostra ricostruzione in quanto tre pagine erano leggermente tagliate sulla destra. Nel caso abbiate delle correzioni da proporre scriveteci pure, le prenderemo in considerazione. |
1. Il Meridione non è più questione italiana
3. Il sottosviluppo non è «naturale»
5. Sviluppo e sottosviluppo, una frattura nella classe
1) — Osserva causticamente Zito, recensendo sull'Avanti «L'unità d'Italia: nascita di una colonia» che non si può certo dire che il meridionalismo rischi di morire di noia. Dopo la rivolta di Reggio, i libri, gli articoli, i saggi sul Meridione non si contano più. Solo nel giro di qualche mese, durante la scorsa primavera, sono stati pubblicati ben quattro libri dedicati al problema: Carlo Alianello La conquista del Sud (Rusconi), E. M. Capecelatro e A. Carlo, Contro la «questione meridionale» (Samonà e Savelli), L. Ferrari Bravo e A. Serafini, Stato e sottosviluppo (Feltrinelli), Fabrizio D'Agostini, Reggio Calabria, I moti del luglio 1970 febbraio 1971 (Feltrinelli). C'è anche da segnalare un importante articolo di Carlo Donolo apparso nel luglio scorso su «Quaderni piacentini» Sviluppo ineguale e disgregazione sociale. Note per l'analisi delle classi nel meridione.
Se ai libri e agli articoli aggiungiamo l'interesse vivo, «carnale» di certi settori dell'intellighenzia italiana per il Meridione, che ha centuplicato le visite e i contatti, potremo dare un sostegno all'impressione che il problema meridionale, oltre a continuare ad aprire prospettive di carriere politiche ed accademiche, è per quei settori una specie di bisaccia della Befana, dalla quale alla fine qualcosa uscirà.
In effetti, a questo punto — al di là di ogni curiosità intellettuale o intellettualistica che sia — il meridionalismo nella sua configurazione tradizionale, limitata, «italiana» ormai tramontato. Le contraddizioni maturate, che tali focolai esplosivi hanno acceso negli ultimi tre anni, han fatto del Meridione un punto di coagulo delle forze che, all'interno stesso dell'Europa imperialista, lavorano coni l'imperialismo. Il Meridione non è più una questione italiana — dell'Italia come stato e sistema politico che amministra e organizza contemporaneamente sviluppo e sottosviluppo, che realizza cioè al suo interno un processo di sfruttamento imperialistico — ma un problema che si iscrive nel quadro della istanza di ristrutturazione su base meridionale dei rapporti economici tra metropoli e colonia. Da c nasce l'esigenza di dare uno sbocco, di organizzare politicamente, le contraddizioni di classe prodotte dalla soggezione imperialistica.
Che il Meridione non sia più, se mai lo è stato, questione meridionale, lo si è visto nel corso dell'autunno caldo quando la «rabbia» dell'emigrato ha travolto per un momento la strategia sindacale ed ha trasformato una lotta contrattuale in uno scontro di classe, creando un collegamento tra strati bassi della classe operaia e settori della borghesia intellettuale, coinvolti in una complessa crisi (difficoltà per i figli del proletariato nell'ascesa alla condizione borghese, disagio dei figli della borghesia ad accettare rapporti di lavoro cripto-salariali, sproporzione tra offerta domanda nei settori improduttivi, presa di coscienza del alienazione di sé a favore di un modello imposto e disse nato di vita, conseguente contestazione dei valori borghese.
Da quell'episodio, sono molti ad aver tratto la falsa relazione che, diversamente da tutti gli altri paesi imperialistici, in Italia Settentrionale la classe operaia sia una forza anticapitalistica e rivoluzionaria, dando gas alla tesi che lo scontro sociale si decida nei luoghi di piena occupazione a più elevata integrazione. Solo nei decenni a venire, allorché il mondo sottosviluppato renderà, sempre più preparati i canali dell'espropriazione coloniale e la condizione di pieno impiego sarà messa in crisi nella metropoli imperialista solo allora sapremo se la classe operaia combatterà con l'imperialismo o contro l'imperialismo.
Sarebbe tuttavia pericoloso immaginare i paesi imperialistici come sistemi socialmente compatti. Nel loro grembo le contraddizioni di classe esistono, ma danno vita a un quadro fortemente dinamico, nel senso che il sistema è stato finora capace di riassorbire quelle più gravi, mentre ne provocava naturalmente di altre. La strategia operaia, nei pochi casi in cui non è completamente aggiogata al potere, si vede di conseguenza costretta ad un inseguimento affannoso e vano; almeno fino a quando l'ideologia predominante guarderà solo con la coda dell'occhio al proletariato esterno e negligerà l'istanza di un sincero (anche se costoso) internazionalismo proletario.
Per quanto concerne poi la «rabbia» dell'immigrato, appare chiaro che essa si sgonfierà nella misura in cui tutto andrà liscio e questi si integrerà definitivamente nel quadro operaio; se invece andrà male, è altrettanto chiaro che la «rabbia» tornerà al Sud, in un Meridione profondamente trasformato, dove a nessuno sarà più agevole far passare degli obbiettivi di lotta asfittici, del tipo «lotta per le terre incolte e mal coltivate».E' stato detto che un nuovo autunno caldo non ci sarà. Si può aggiungere che non ce ne saranno per molti anni a venire. E ciò è facile da comprendere. Se la classe operaia vuole più benessere, bisogna che lasci lavorare il sistema imperialistico, imponendo solo degli aggiustamenti di tanto in tanto. Se poi vuole abbattere l'imperialismo, allora è necessario che si prepari a fare molte rinunzie. Intanto il sistema — cioè governo, capitalismo industriale, ceti parassitari del Meridione, partiti tradizionali e sindacati — ha ripreso in mano la situazione. Continua e continuerà pertanto la spogliazione del Meridione. La crisi del sistema meridionale, nella misura in cui diventa più drammatica, stimola una nuova e più tesa elaborazione politica. Difatti, degli scritti di cui mi occuperò solo alcuni non presentano una scoperta intenzione politica che ne superi l'aspetto propriamente analitico ed informativo. Nell'ambito politico, poi, quelli che vengono da sinistra immaginano la possibilità di un recupero del proletariato meridionale da parte degli apparati nazionali — parlamentari o extra — mentre la Conquista del Sud sottintende un discorso molto meno ingenuo di quanto sembrerebbe a prima vista. Infatti, l'unica possibilità di salvezza per la borghesia economica meridionale in complesso (quella revanscista della rendita e della speculazione, e quella sconcertata e scompaginata delle imprese) non è più l'ancora dello Stato unitario, con i suoi apparati repressivi. Il conflitto tra questo tipo di borghesia, e quella oligopolistica e modernizzata della Valle padana, può essere rimandato ma non evitato. Solo la perspicace intelligenza di tale problematica può giustificare il libro di Alianello, che non è una asettica ricerca storiografica, ma una apologia intenzionale del governo borbonico.
2) — Un Meridione ben governato, civile — rispetto almeno all'invasore piemontese —, capace di condurre una politica nazionale e per di più contro forze esterne di peso schiacciante (Inghilterra, Austria): ecco il disegno dell'opera. Il suggerimento è sottile, semmai l'errore di fondo che Alianello commette è di credere che il destinatario del libro abbia un peso, sia pure non espresso, ma esprimibile, nei rapporti sociali vigenti. Sconfitta appena qualche decennio dopo l'unificazione, la borghesia fondiaria meridionale è oggi niente più che una mantenuta, nel senso che lo stato unitario restituisce ad essa una piccola parte del surplus espropriato nel Meridione. La borghesia imprenditoriale è dal canto suo rachitica e maltrattata: il Settentrione nel suo assieme, quale blocco storico degli interessi industriali e operai, non vuole concorrenti. Ma il massimo di volontà politica che la borghesia' impoverita del Meridione sia capace di esprimere l'abbiamo già visto: è un'invocazione antioperaia a Valerio Barghese, nell'illusoria speranza di una compressione dei salari capaci di riespandere rendite e profitti — puntello temporaneo contro una fine meno repentina.
La borghesia economica meridionale (la classificazione è necessaria perché il Meridione è governato da una borghesia improduttiva) non ha ancora capito — ed è ormai tardi per capirlo — che anche le forze economiche dominanti sono in perenne conflitto tra loro, e che il suo declino quasi secolare si è concluso in un tracollo, nel corso degli anni cinquanta, a causa del risucchio di manodopera operato dai settori più produttivi del capitalismo europeo, e non invece per merito dell'autonoma ascesa delle masse lavoratrici meridionali. L'Europa, anzi l'occidente, ha raggiunto un grado elevato di integrazione, che procede e trascende le aggregazioni comunitarie create negli ultimi decenni. In questo quadro, nessuna forza politica, per quanto reazionaria possa essere, riuscirebbe a condizionare seriamente la forza contrattuale delle masse e l'aumento dei salari in un periodo di pieno impiego. Ciò vale per la metropoli imperialista, ma anche per i satelliti più vicini che la riforniscono di manodopera. Alianello saprà certamente — ma dubito lo sappiano certi ambienti neonostalgici — che neppure alla feroce repressione franchista riesce agevole governare la curva dei salari operai. Per il grado di integrazione cui si è giunti, Dusseldorf o Zurigo influenzano il mercato del lavoro di Barcellona o di Reggio Calabria molto più di quanto non possa fare qualunque politica salariale dei governi nazionali.
L'appassionata apologia che Alianello fa di Ferdinando II e di Francesco I tende a dimostrare quanto è pacifico sul piano storiografico, e cioè che quello borbonico non fu un governo peggiore di altri. Perché allora esso crollò sotto la spinta di un manipolo di avventurosi? Alianello pretende di individuarne le cause nel «tradimento» dell'intellighenzia meridionale, ivi compresi i politici opportunisti e le gerarchie militari. Pressappoco la favola della guerra mussoliniana perduta a causa del tradimento degli ammiragli e dei marescialli dell'impero; ma come questa, anche quella di Alianello non regge.
«Il miracolo» risorgimentale, che tale fu anche se negativo per il Meridione — e insistiamo sul negativo, malgrado quello che pensano gli storici cattedratici, tanto più «italiani» quanto più comodi in cattedra (quando poi costoro abbiano scritto di storia in autonomia di giudizio e con autentica attitudine scientifica, resta da stabilire) — scaturì dalla somma di due richieste sociali intimamente connesse: liberalismo politico e liberismo economico. I Borboni andavano contro le forze matrici della storia quando negavano il primo e contrastavano l'altro. Battuta l'Austria, in Italia non vi era più posto per l'assolutismo, sia pure illuminato. Ne fa riprova la circostanza che le monarchie emiliane e quella toscana si liquefecero ben più repentinamente del regno borbonico. D'altra parte, nel Meridione più che altrove in Italia, borghesia agraria (o nuova aristocrazia agraria) e borghesia intellettuale erano molto legate: in parole povere, o la stessa persona era professionista e proprietario, o le due posizioni si sviluppavano nell'ambito di una stessa famiglia. L'una e l'altra, sommate e integrate, erano ormai la forza sociale dominante e meritavano di prendere il potere (da cui Ferdinando si ostinò a tenerle lontane, anche se utilizzò personale borghese per mansioni governative e amministrative) e di esigere indirizzi di politica economica più conformi ai loro interessi (che Ferdinando negava).
Nessuno meglio di Cavour seppe interpretare ed esprimere le istanze della borghesia italiana in ascesa. Chi legga i suoi scritti e i suoi discorsi può capire fino in fondo quale sirena allettante fosse per quella classe la prospettiva di impiantare o incrementare un'agricoltura d'esportazione per il mercato inglese e alcuni altri dell'Europa continentale, nei quali lo sviluppo industriale andava elevando il tono dei consumi e quindi le richieste di materie prime e prodotti agricoli per il consumo di massa (Discorso diverso è poi quello secondo cui i fondamenti del liberalismo cavouriano erano illusori, anzi autoingannatori, come in genere è ogni forma di liberalismo per i paesi poveri).
3) — Perché poi sottovalutare un altro tema? Si era nell'età dell'affermazione delle nazionalità oppresse, cioè di lotta contro quello che con termine attuale chiameremmo colonialismo interno interno dell'Europa. I popoli soggetti (le loro borghesie in ascesa) sentivano il bisogno di conoscersi, di liberarsi, di affermarsi verso gli altri. Anche se oggi i termini del problema sono capovolti, allora «unità» voleva dire liberazione, conquista del potere per la classe culturalmente egemone; e larghi settori della borghesia napoletana sentivano tale esigenza allo stesso modo degli emiliani, dei piemontesi, dei polacchi o degli ungheresi.
Solo in seguito l'agricoltura d'esportazione e l'ideologia di cui era portatrice, il liberismo doganale, si rivelò una povera gallina indifesa per la libera volpe industriale. Questo tema di fondo della problematica risorgimentale è colto, ma nel suo valore negativo, da Capecelatro e Carlo in Contro la questione meridionale. Cioè gli autori mettono in luce quanto di lungimirante, e allo stesso tempo razionale, vi fosse nel forte protezionismo industriale del regno delle Due Sicilie. E' un pò come scrivere la storia con il senno di poi. Il capostipite di tale formula storiografica per quanto concerne i temi economici della problematica unitaria, è Gino Luzzato, il quale ha trovato — e non a caso — epigoni anche fra gli storici di sinistra (si veda ad esempio Il problema dello sviluppo industriale nell'età della Destra di Giuseppe Are).
Il fenomeno storico ha una sua razionalità insuperabile (proprio nel senso vichiano). Lo storico non può far di più che scoprire gli agenti e i nessi del fenomeno e valutarne gli esiti. Se questo è esatto, dobbiamo onestamente riconoscere che il protezionismo borbonico fu un'istanza disperata di isolamento politico, estremamente nociva al paese meridionale; a quella parte cioè dell'espressione geografica Italia, la quale possedeva le carte buone per giocare una partita vincente sul terreno degli scambi internazionali. Infatti, ad unità avvenuta, furono le esportazioni agricole meridionali che consentirono di pareggiare la bilancia dei pagamenti italiana, disastrata dall'importazione di capitale straniero, impiegato nella edificazione delle infrastrutture e delle strutture industriali ed agro-capitalistiche del Settentrione.
Ma il liberismo, si dirà, bloccò la marcia di energie già in movimento; il liberismo portò allo scambio disuguale. Non è esatto. Tra il 1830 ed il 1880 la massa più considerevole del movimento rinnovatore era in agricoltura. Solo un' agricoltura per il mercato poteva porre, come pose, i presupposti umani e materiali per la nascita dell'industria moderna. Solo verso la fine del cinquantennio in questione, lo scambio disuguale si profila all'orizzonte ai danni delle produzioni tipiche del Meridione, e nascerà comunque più che nel circuito internazionale (dove le monoculture si trovano sempre favorite al loro sorgere per via del monopolio tecnico che le regole), nell'ambito del regime protezionistico, e precisamente nei rapporti Nord-Sud.
Muovo questi appunti ad un lavoro di storia politica di cui sono, per altro, entusiasta, e che comunque non si ferma qui. Infatti i giovani autori del volume ci hanno dato certo un abbozzo che va approfondito, ma assolutamente nuovo e non chiesastico di storia socio-economica del Meridione. L'esigenza dell'approfondimento è imprescindibile, in quanto la cultura italiana, chiusa e burbanzosa, o ha accettato acriticamente l'evento unitario in quanto erede della corrente di pensiero che tanto aveva contribuito a realizzarlo; o, pur ponendosi in posizione critica, non ha capito che per battere la borghesia non basta impadronirsi del suo Stato, ma bisogna demolirlo; o peggio intravede in questo Stato il terreno per la possibile esplicazione di una più favorevole convivenza tra sviluppo imperialistico e potere operaio.
Secondo Gramsci, e specialmente i cattedratici che si rifanno al suo pensiero, l'unificazione italiana trova il Meridione fermo ad uno stadio semifeudale dei rapporti di produzione, mentre nel Settentrione la rivoluzione capitalistica era già compiuta (sbagliando quei pontificati professori che, occupandosi sulla stampa da 300 lire l'etto, del libro di Capecelatro e Carlo, accomunano Sereni e Gramsci.
Molto umilmente consiglierei loro di leggere o rileggere meglio Il capitalismo nelle campagne). Da qui la questione meridionale: la confluenza in un unico organismo politico e la giustapposizione di due aree con diverso grado di sviluppo economico.
Gli autori negano la fondatezza di tale assunto, ed anzi affermano che per alcuni aspetti il Meridione era più avanti del resto del paese nella direzione dello sviluppo capitalistico. E' quest'ultimo un nodo non ancora sciolto, non tanto per ciò che attiene alla ricerca storica, quanto per un suo esatto inquadramento in termini di teoria economica. Su ciò torneremo fra breve, poiché vorremmo subito far notare come da quella traccia (vera o falsa che sia) gli autori ricavino una esatta ricostruzione storica dello sviluppo capitalistico italiano.
Nella loro analisi il problema dell'arretratezza scompare, e con esso il concetto di questione meridionale quale prodotto «naturale» di tale arretratezza. Il rapporto Nord-Sud che l'unificazione realizza non è quello «tra due realtà estranee o anche genericamente collegate, ma presume uno spazio economico unitario in cui lo sviluppo è il rovescio del sottosviluppo che gli è funzionale: in altri termini una parte si sviluppa perché l'altra si sottosviluppa e viceversa». Le particolari condizioni politiche, che presiedettero alla formazione dello Stato unitario, assicurano alla borghesia del Nord il dominio del meccanismo statale e l'uso incontrollato delle leve del potere in funzione di una programmatica espropriazione di risorse al Sud e del loro pompaggio a sostegno dello sviluppo nel Settentrione.
La tesi, storicamente esatta, non è nuova. Essa fu elaborata dal Nitti già nel finire del secolo scorso e fu, per un buon decennio, il cavallo di battaglia di un largo settore del meridionalismo liberale (e liberalista). Gli autori hanno però l'indubbio merito di rincondurla sotto l'ambito del materialismo storico. Ciò non vuol dire che il problema — come si è già notato — fosse rimasto estraneo al pensiero marxista. Ma questo l'aveva incanalato su una via senza sbocchi. A Gramsci era tutt'altro che sfuggita la condizione coloniale del Meridione, ma egli proprio per sottrarsi alle tematiche dei meridionalisti radicali (l'istanza è esplicita nel suo incompiuto scritto del 1926) e per tentare una ricucitura su base unitaria tra operai e contadini (tra sviluppo e sottosviluppo, diremmo noi), aveva stabilito una identità, teoricamente non valida tra arretratezza e colonialismo.
Ma il regno napoletano era in effetti una società dove dominavano, o erano quantomeno prevalenti rapporti capitalistici di produzione?
Gli autori partono, per sostenere la tesi affermativa, proprio dal contesto più difficile: la Sicilia del latifondo signorile. La Sicilia, cui ancora l'occidente industriale guarda come a una regione ferma allo stadio dei rapporti precapitalistici e a una cultura arcaica, aveva secondo Capecelatro e Carlo organizzato fin dalla seconda metà del Settecento, nella produzione granaria, rapporti propriamente capitalistici. E non tanto perché l'esportazione del grano inseriva in qualche modo l'isola nell'ambito dei canali del commercio mondiale (la circolazione mercantile non è un connotato che da solo può definire il carattere capitalistico di un' economia), quanto perché l'aumento dei prezzi ed altri fattori attinenti al costume avevano convinto i signori feudadali a concedere in affitto i feudi a borgesi e campieri arricchiti; i famosi gabellotti.
Sarebbe questa una figura di capitalista a tutte lettere, non dissimile dal fittavolo lombardo, primo perché la sua posizione è qualificata «dal principio del profitto e della valorizzazione del capitale; secondo perché il suo inserimento nei processi produttivi mette in moto il classico meccanismo capitalistico di trasformazione del produttore in merce-lavoro. Del carattere capitalistico dell'agricoltura siciliana, gli autori offrono una riprova in termini teorici. Nel periodo preso in esame (un mezzo secolo circa) l'economia granaria siciliana reagì ai movimenti dei prezzi sul mercato mondiale estendendo la produzione in corrispondenza dei rialzi del prezzo, e viceversa. Tale reattività è una cartina di tornasole, in quanto nel sistema feudale, il signore vende bensì sul mercato mondiale il sovrappiù delle rendite in natura, ma in tale sistema l'oscillazione dei prezzi mondiali provoca reazioni esattamente contrarie a quelle osservate nella Sicilia dell'epoca, e in genere nel sistema capitalistico. Più precisamente, il feudatario tende a rifarsi delle perdite derivanti da un ribasso del prezzo o stimolando l'aumento quantitativo della produzione o elevando il canone in natura, e quindi la quota espropriata e vendibile della produzione contadina-servile. Ciò appunto perché nel sistema feudale, per il signore, il costo di produzione — secondo la teoria di Kula — è uguale a zero.
Anche per Emilio Sereni «il gabellotto è già un capitalista che intende realizzare un profitto sul capitale che egli ha anticipato per l'affitto del feudo, per le scorte, ed è (Il capitalismo nelle campagne, Einaudi 1968, pag. 158) da ricordare che Sereni scrisse questa sua opera fondamentale quando non conosceva I Quaderni gramsciani; cosa che avvalora l'opinione avanti esposta del carattere gramsciano de Il capitalismo delle campagne). Ovviamente non sono della stessa opinione i cattedratici gramsciani e quei meridionalisti non socialisti, ma egualmente compresi del loro ruolo cattedratico.
Il riferimento alla sistematica di Witold Kula mi pare pertinente in quanto suggerisce un parametro atto a discriminare con sufficiente oggettività tra modo feudale e modo capitalistico di produzione; parametro tanto più utile in quanto lo sfilacciamento dell'economia feudale e il graduale insorgere del sistema capitalistico si diluisconno in spazi temporali e geografici molto estesi.
Sia pure con minore efficacia, gli autori mettono a fuoco anche il problema simmetrico della trasformazione del produttore in merce-lavoro, fornendo prove convincenti al processo. D'altra parte la convivenza tra rapporti chiaramente capitalistici e contratti di conduzione ereditati dalla età precedente non inquina la possibilità di una definizione perché non è infrequente che il capitalismo utilizzi validamente rapporti del periodo precapitalistico.
Tutto ciò, si può però osservare, non chiarisce quanto estesa fosse la fascia dell'autoconsumo e dell'economia naturale nella società siciliana e meridionale del periodo risorgimentale. L'eccezione tuttavia non intacca la validità della tesi fondamentale (Sud non arretrato rispetto al resto del paese), in quanto tali elementi sono presenti in misura non certamente minore negli altri Stati regionali, compresa l'evoluta Lombardia, tanto evoluta che esiste un'intera schiera di pubblicisti economici che si batte a favore del libero scambio e per il mercato unico nazionale.
Prove più «palpabili» sono poi offerte nel tratteggiare il quadro capitalistico dei meridione continentale: percentuale di occupati nell'industria (su questo indice la letteratura storiografica nordista, tanto liberale che marxista, ha fatto acrobazie per dimostrarne l'infondatezza) , produttività del lavoro più elevata che in altre regioni, elevato tasso di capitalizzazione, notevole sviluppo della grande industria (anche questo un dato molto fastidioso per la storiografia ufficiale, talché si sostiene che non di industria si trattava ma di industrie sovvenzionate dallo Stato. E qui la distinzione è per la verità molto sottile, in quanto l'industria sorta al Nord dopo l'ottanta fu anch'essa sia pure in modo diverso sovvenzionata. Tutto si riduce allora a una questione di simpatia). Lo stesso protezionismo borbonico è, secondo gli autori, il segno di una presenza capitalistica più consapevole ed evoluta.
4) — In sostanza mi pare che gli autori portino elementi sufficienti per mettere in crisi la tesi di un Sud atavicamente arretrato, che fu di Croce, di Gramsci e dei meridionalisti dei nostri giorni, adeguatamente blasonati e non meno adeguatamente foraggiati da un qualche ente governatitivo; tesi che assolve l'Unità e le responsabilità storiche dei gruppi che egemonizzano l'economia e la vita stessa del paese a partire da quel momento. Ma mi pare anche che, in questo primo approccio dell'argomento, ci sia come un eccesso di zelo. Non vorrei uscire dal seminato e fare una chiosa allo stesso Marx che, quando si tratta di dare una definizione stringata del capitalismo, punta tutto sulla natura dei rapporti di produzione. Debbo però francamente dire che questo elemento rigidamente sociologico in certa misura contraddice la più complessa ma organica concezione del materialismo storico; nel senso che non parlerei di capitalismo, come poi Marx stesso fa, se non quando si perviene alla produzione di merci di massa (industrialismo), che è anche il momento più alto di separazione tra lavoro e prodotto, e alla conseguente, profonda insuperabile crisi della economia naturale, da quel nuovo processo produttivo provocata su scala locale, nazionale e mondiale. Pertanto sarei portato a dire che mi sembrerebbe storicamente più esatto puntare a sfatare il mito di un Nord avanzato (per non parlare di regioni come il Lazio e la Romagna), piuttosto che sottovalutare le componenti di arretratezza prevalenti nel sistema meridionale. Non mi pare cioè che il problema possa essere rovesciato. Nel Sud sono presenti elementi capitalistici non meno che in altre regioni d'Italia. Non si spiegherebbe altrimenti — come giustamente osservano gli autori — lo slancio registratosi nelle colture d'esportazione subito dopo l'istaurazione del liberalismo doganale. Ma sono egualmente presenti come altrove fortissime eredità dell'economia di villaggio. A tener conto degli elementi storicamente qualificativi dell'economia di mercato, l'Italia preunitaria e immediatamente post-unitaria conosce solo due vaste aree dove è penetrato a fondo il modo di produzione per il mercato: la pianura lombarda e la fascia Napoli-Salerno, oltre a minori episodi in Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana. E' poi ovvio che, anche per quel periodo, è molto importante tener conto del grado di diffusione, più che dell'intensità verticale, dei fenomeni capitalistici.
Nel lavoro di Capecelatro e Carlo, il quadro dello sviluppo nell'hinterland napoletano è quello meglio messo a fuoco. Del Demarco ho presente solo un rapido saggio sulle condizioni economiche dell'Italia preunitaria, ma non le opere maggiori, dalle quali gli autori traggono spunto per tessere la trama della loro tesi, ma da quel che ho potuto arguire leggendo il secondo e terzo capitolo di Contro la questione meridionale, questi ha dato al Meridione — ed era tempo — quello che, quarantanni fa Greenfield ha regalato alla Lombardia. Le sue ricerche hanno permesso a Capecelatro e Carlo di scrivere un vigoroso saggio di storia politica. Non condivido pertanto la loro idea che sia ora di finirla con la ricerca anche minuta. Infatti sono molti i pregiudizi da sfatare, ma sono molte anche le ombre da rischiarare. Gli autori fanno luce su analisi e giudizi dell'epoca finora trascurati — le opere del Balsamo, del Petino, dello Scrofani, del rinomato e poco riletto Bianchini — ma a questo punto bisogna chiarire anche da che parte sta, e quali interessi serve, gente come Santangelo, De Cesare, Scialoja, Nisco, Ferrara, per non parlare di Pisacane e di Benedetto Musolino. Credo sia giusto pesare le forze sociali che si mossero sulla scena di una storia, le cui trascrizioni o sono troppo bianche o troppo nere per essere accettate come vere. Superato questo passo, ed entrando nel periodo della storia nazionale, gli elementi che determinarono la colonizzazione del Sud sono individuati con esattezza: l'egemonia dei gruppi finanziari tosco-lombardo-piemontesi al governo del paese, l'«azione trentennale dello Stato» contro il Meridione. Gli autori hanno rifiutato di prendere in considerazione la funzione espropriatrice delle merci capitalistiche. La dominazione politica, il drenaggio del capitale finanziario e il protezionismo antiagrario non sarebbero bastati da soli a squinternare la società meridionale e a piegarla all'impotenza se allo stadio della circolazione allargata delle merci capitalistiche si fosse arrivati prima e non — come avvenne — dopo l'unificazione, per di più in posizione di sbocco e non di produttore.
La contraddizione metropoli-periferia, così vivamente avvertita dalla attuale condizione meridionale, spiega a sufficienza i nuovi orientamenti internazionalisti del marxismo italiano. Il facile successo da quest'ultimo registrato negli ambienti accademici, dove ha largamente soppiantato le posizioni tenute dall'idealismo, ne ha impoverito i fermenti vivificatori, tanto da inchiodarlo a una visione sorpassata ed angusta delle contraddizioni capitalistiche.
5) — Si avrà una querelle des anciens et des modernes? Non è quello che conta. Le nuove problematiche vengono su con le nuove classi che si elevano a soggetti di storia e ripensano il proprio passato. Il lavoro di Capecelatro e Carlo è nella proiezione politica e culturale di tale istanza, pertanto estremamente sorprendenti, distorte e posticce appaiono le loro conclusioni politiche. Ma prima di passare a tale discorso è estremamente interessante esaminare per sommissimi capi l'analisi che gli autori fanno della più recente realtà meridionale. Siccome, poi, il lavoro di Ferrari Bravo e Serafini, e in qualche punto quello di D'Agostini riguardano tale argomento, vorremmo confrontare queste analisi con quelle di Quaderni Calabresi. E ciò non perché tra analisi e conclusioni ci sia sempre un nesso, anzi spesso le conclusioni sono assolutamente arbitrarie, ma in quanto ognuna di tali analisi porta un contributo serio alla conoscenza della realtà meridionale.
Per Capecelatro e Carlo, con la fine della seconda guerra mondiale, il sottosviluppo meridionale passa da una fase «violenta» a una fase «dinamica»: cioè le forze politiche tentano un controllo del sottosviluppo per evitare di mettere in pericolo l'equilibrio del sistema.
A parte l'aggettivazione (violento contro dinamico: non sarebbe stato meglio dire incontrollato e controllato, tanto più che l'urto più recente non è stato meno violento?) si può essere senz'altro d'accordo. Per Ferrari Bravo e Serafini si ha uno «slittamento» del sottosviluppo da «rapporto esterno e rapporto interno». Agente di tale slittamento è l'azione dello stato che realizza un «governo» del sottosviluppo attraverso l'intervento straordinario e la politica di piano. Attraverso tali strumenti prende corpo il progetto del capitale rivolto ad usare l'arretratezza come funzione dello sviluppo; e precisamente il fattore arretrato — lavoro meridionale — al servizio dello sviluppo settentrionale (e perché non centroeuropeo?).
Il richiamo occupazionale rappresentato dai lavori pubblici effettuati dalla Cassa alimenta il distacco delle forzelavoro della campagna e prepara la loro utilizzazione al Nord. In sostanza la Cassa funziona da ponte, da mediatore tra il lavoro agricolo e la sua trasformazione in manovalanza. Attraverso tale politica viene battuta la lotta contadina nel Meridione.
Dal canto suo. Quaderni Calabresi ha posto in rilievo questi momenti: 1) lo sviluppo industriale centroeuropeo del dopoguerra provoca un nuovo movimento di popolazione dalle aree periferiche a quelle in fase di espansione capitalistica; 2) la fuga della manodopera agricola determina la crisi definitiva della rendita fondiaria; 3) la più massiccia penetrazione di merci capitalistiche acuisce la crisi economica del Meridione; 4) nel dopoguerra, i fattori colonizzanti diventano più marcati nella misura in cui l'egemonia politica interna passa dalla rendita alle classi improduttive più strettamente legate all'Italia (impiegati e professionisti); 5) proletariato esterno allo sviluppo e proletariato operaio hanno interessi non convergenti e spesso opposti; 6) la sinistra italiana svolge un ruolo dirottante ed elusorio delle reali istanze del proletariato meridionale; 7) nel Meridione, la possibilità di uno scontro di classe esclude gli strumenti sindacali ed elettorali, dovendo assumere istanze più incisive di tipo nazionale popolare.
Nell'ultimo capitolo del libro di Capecelatro e Carlo si incontra la dimostrazione della illusorietà di ogni programma riformistico a proposito dello sviluppo industriale del Meridione. Siamo di fronte ad uno sforzo vigoroso, offerto in termini di teoria economica. Neppure Ferrari Bravo e Serafini pare si facciano un'illusione del genere, anche se attribuiscono all'intervento pubblico un ruolo che non corrisponde alla realtà. Senza riserve se la fa invece D'Agostini, il quale spera in una correzione di rotta nel PCI e nella CGIL che dia spazio all'istanza meridionale.
Non fugge a Capecelatro e Carlo che i conflitti interni ai processi di produzione capitalistica non esauriscono la gamma della contraddizioni tipiche dell'età nostra. C'è infatti da registrare lo scontro mondiale tra società imperialistiche e società espropriate, il quale non può essere a sua volta confuso con la contraddizione città-campagna all'interno della stessa economia. Ora, pur avendo costruito tutto il loro lavoto su tale presupposto, ad un certo punto gli autori prendono il volo, confondendo Napoli con Milano, Taranto con Genova, fino ad affermare che il Meridione non si ferma a Gaeta ma arriva alle porte di Milano. Perché allora non dire alle porte di New York, di Toronto, di Melbourne e di Colonia, così l'imperialismo scompare come l'asso nel gioco delle tre carte?
In verità essi fanno karakiri sull'altare di quella immaginaria unità della classe alla quale la nuova sinistra, come la nuova sinistra di altri tempi (Gramsci docet) spreca inutili turiboli d'incenso. Pur essendo entrambi napoletani, non vedono che Napoli, come d'altronde Taranto, Brindisi, Gela sono più colonia di quanto possano esserlo Stefanaconi o Gibellina. Sulla base di quale definizione teorica, meno di quattrocentomila operai, che poi sono dei privilegiati nel loro ambiente, possano essere presentati come un Nord nel Sud, come una reale spaccatura nella società meridionale? Per non sognare, chiediamoci quante sono queste famiglie nordiste dove a lavorare nell'industria sia un secondo componente della famiglia; quanti figli di questi «operai» fanno il garzone al bar,» e quanti altri prosciugano le magrissime risorse familiari per diventare medici o maestri, unica via per uscire dal ghetto della precarietà dei redditi.
Non basta rinverdire la teoria economica nell'analisi delle strutture e del capitalismo, è anche necessario avere il coraggio di vedere quali rapporti di classe sottostanno a tale struttura. Sviluppo e sottosviluppo, imperialismo e colonie, metropoli e satelliti, comunque vogliamo chiamare il rapporto strutturale, esso non avrebbe significato in termini di teoria economica se non definisse anche un tipico rapporto di classe, se non creasse una frattura profonda e pericolosa tra proletariato interno e proletariato esterno.
Non credo poi che sia da sottovalutare il ruolo della piccola e media industria nella identificazione delle aree metropolitane. Se gli oligopoli compiono direttamente, attraverso le loro filiali, l'opera di espropriazione coloniale, la piccola e media industria metropolitana, che molto più della grande industria contribuisce a creare quel tessuto diffuso di attività da cui nasce il pieno impiego, la compie attraverso le sue merci competitive, ed è poi questo tessuto diffuso di piccole e medie attività che marca la distinzione tra sviluppo e sottosviluppo, in quanto moltissimi paesi sottosviluppati potrebbero oggi impiantare centri siderurgici altrettanto colossali che i paesi sviluppati, ma poi non avrebbero dove collocare e come impiegare la produzione.
Nel caso nostro, la dipendenza economica del Meridione non si lega soltanto all'assenza dei giganti della metalmeccanica, ma anche e soprattutto a quei settori che gli autori considerano tuttora concorrenziali, ma che concorrenziali sono solo nel circuito metropolitano. Non basta aver consapevolezza del fenomeno, bisogna anche spiegarcelo. La verità è che la subordinazione economico-politica del Meridione è ancora più violenta di quanto non fosse un secolo fa perché, oltre alla competizione tra settori capitalistici, l'antica spaccatura nell'ambito degli interessi proletari si è con il tempo accentuata. Il problema delle «mani adatte» e quello finanziario, rispolverati per giustificare la mancata industrializzazione del Meridione, son fin troppo chiaramente la copertura di un disegno antimeridionale. Incentivare nel Meridione la nascita di una piccola e media industria non rappresenta un problema insormontabile né dal punto di vista tecnico, né da quello finanziario. Ma se un progetto del genere andasse in porto, a chi venderebbe poi una parte rilevante della propria produzione la piccola e media industria settentrionale? E le tensioni sociali che una crisi di sovrapproduzione creerebbe al Nord, non sarebbero più grosse di qualunque Avola o Reggio Calabria?
Accanto alla logica del capitale, ci sono le forze del lavoro ad impedire qualunque operazione che possa rassomigliare a una ridistribuzione delle fonti di occupazione e di reddito nel quadro italiano. E' altresì illusorio immaginare che una volontà socialista, un potere proletario, insediatosi a Roma possa sormontare un simile ostacolo. La nostra ipotesi è che il proletariato meridionale non può contare che su se stesso. Non sottovalutiamo certamente il problema delle alleanze, ma il proletariato meridionale trova i suoi alleati naturali nell'ambito del sottosviluppo. L'alleanza con la classe operaia si colloca per adesso nella prospettiva storica di una ricostruzione politica che investa non le istituzioni proletarie tradizionali, come pensa la sinistra extra, ma la base operaia, nei suoi valori, nel contenuto della idea stessa della lotta di classe. Fra l'altro tale difficile ricomposizione passa oggi attraverso una revisione dell'agnosticismo nei confronti dello sviluppo incontrollato delle forze materiali della produzione e del collegamento automatico tra ricchezza sociale prodotta in una determinata area e ricchezza distribuita nella stessa. L'internazionalismo proletario ha oggi anche il segno di una nuova definizione dei rapporti nei quadro della ineguaglianza fra le economie.
L'ipotesi di un Sud compenetrato nello sviluppo è anche di Ferrari Bravo e Serafini: «Il Mezzogiorno come area complessivamente omogenea nella sua arretratezza (salvo ridottissime zone senza rilievo generale) non esiste veramente più». Certamente l'esodo e il crollo della rendita hanno rotto il vecchio circuito interno meridionale (contadini-rendita), e allargato il diametro dei canali per l'estrazione del surplus. C'è stato anche uno spostamento del polo magnetico dei flussi migratori (e quindi espropriatori) dal nuovo mondo al centro della «vecchia» Europa. Ma per questo «l'omogeneità» della situazione meridionale è saltata? Se tale omogeneità andiamo a cercarla nella esistenza di una struttura positiva, sia pure arretrata, come la vecchia società a base fondiaria, non possiamo che registrarne la scomparsa. Ma se l'omogeneità può concretizzarsi in una struttura negativa, quale è l'esistente disgregazione, allora ci si accorge che l'evoluzione (involutiva) non ha inciso il rapporto preesistente tra metropoli (sviluppata) e colonia (sottosviluppata). Tale evoluzione non è fenomeno meridionale ma è avvenuto all'unisono con i mutamenti prodotti nel quadro mondiale del sottosviluppo ad opera dei movimenti nei sistemi metropolitani. D'altra parte gli autori registrano «il permanere di tale (la vecchia) situazione di dipendenza», avvertendo il sopraggiungere di «alcuni elementi qualitativamente nuovi, tali da spostare l'intera trama della questione meridionale».
Questi elementi nuovi vengono definiti comprensivamente con il termine «sviluppo», intendendo per sviluppo «il governo della società» da parte del capitalismo. Ciò è per certi aspetti vero, nel senso che il capitalismo, sviluppandosi, allarga il cerchio e approfondisce il pozzo del suo potere. Tale è il carattere di tutta la storia del capitalismo. Nell'ambito di tale processo — crescendo la sua intensità — mutano ovviamente i meccanismi atti a perpetuare il processo.
Per inciso c'è da osservare che l'identificazione di sviluppo con sviluppo capitalistico pone un problema politico. Se è in fatti vero — come gli autori acutamente osservano — che furono proprio le forze di sinistra a riproporre la questione meridionale in termini di sviluppo capitalistico, non è però vero che oggi sia questa la proposta di tutta la sinistra. La sinistra meridionale — e mi pare anche quella latina-americana — quando usa il termine sviluppo, sottindende il termine liberazione: rispetto anche a quelle suscettività economiche di cui il dominio capitalistico impedisce la valorizzazione. Ritengo pertanto male impostata la critica a Baran.
Siamo però ancora ai concetti periferici dell'analisi di Ferrari Bravo e Serafini. Il tema di fondo, cui già si è fatto cenno, è rappresentato da una interpretazione in chiave sottosviluppante dell'azione d'intervento straordinario e della pianificazione.
L'indagine ruota intorno a questo punto focale: il Meridione arretrato fornisce illimitatamente la manodopera a basso prezzo richiesta nella nuova fase di sviluppo capitalistico in Italia (schema di Lewis). Lo Stato, quale istituzione politico-giuridica, non si colloca in posizione neutra rispetto all'esodo ma ne dirige e controlla i movimenti attraverso strumenti di volta in volta predisposti. Nella più recente fase dello sviluppo si rende infatti indispensabile l'intervento diretto e l'amministrazione dell'arretratezza come risorsa dello sviluppo. Si può succintamente osservare — oltre a quanto già detto sul tema dell'integrazione — che l'estrazione di forza — lavoro è certamente — ieri come oggi — l'aspetto più consistente, ed anche il più vistoso dell'espropriazione capitalistica del Meridione, ma che, accanto a questo, alti ne esistono di grande rilievo, alcuni vecchi, altri nuovi, altri proiettati nel futuro:
Lo scambio diseguale, la colonia di consumo, il pompaggio dei risparmi, l'occupazione del territorio. Anche rispetto a tutto ciò, lo Stato è — ed è stato — spesso strumento dei programmi del capitale. D'altra parte l'intervento dello Stato va inquadrato realisticamente come meccanismo che aiuta un movimento, le cui spinte strutturali bisogna ricercare in altra sede, e precisamente nella tendenza alla concentrazione geografica dello sviluppo capitalistico, nello sviluppo diseguale delle economie, quale prodotto dell'imperialismo, e nella creazione dell'esercito industriale di riserva ad opera della penetrazione delle merci capitalistiche. In realtà lo schema di Lewis deve ritenersi una utilizzazione in termini statici del fenomeno storico, e perciò dialettico, della rigenerazione — della merce — lavoro, nel grembo del conflitto permanente tra forme più avanzate (in direzione capitalistica) e meno avanzate di produzione.
Questa considerazione ci conduce a rifiutare, oltre che in
sede di
aderenza storica, anche in sede di teoria econo
mica la tesi dell'integrazione accolta (tuttavia con una certa
reticenza) dagli autori, che farebbe del Meridione uno degli «angoli
attardati» di un sistema compiuto e definito. Questo sistema non può
essere altro che il capitalismo maturo. Ora, uno dei caratteri salienti
del sistema accennato è la piena occupazione, e di conseguenza la
degradazione del conflitto di classe a forme di tensione governata in
termini riformistici. Ciò non corrisponde alla condizione del
proletariato meridionale; non solo, ma tutti gli sforzi fatti per
gestire nel Meridione il conflitto di classe secondo il modello
riformistico sono risultati improduttivi di effetti.
Sbagliano gli autori a pensare che il capitalismo «attraverso il governo del sottosviluppo» sia riuscito a controllare le contraddizioni che il suo sviluppo genera e e battere il movimento di classe. Le contraddizioni si sono riprodotte a un livello diverso e il movimento di classe lavora a superare le remore e gli ostacoli derivanti dalla sopravvivenze delle preesistenti istituzioni politiche. Ci sembra d'altra parte unilaterale ascrivere i meriti di vent'anni di stagnazione politica all'azione dell'intervento, dimenticando i demeriti di chi alimentò il movimento contadino per poi dirottarlo su richieste limitate e verso pratiche elettoralistiche.
Fatti questi appunti a margine, è doveroso anche notare (accanto a certe difficoltà che si incontrano nella lettura del saggio di Ferrari Bravo) che Stato e sottosviluppo è un'indagine accuratissima e ricca di spunti sui nessi tra la politica di piano, nella sue varie fasi, e sul rapporto sviluppo-sottosviluppo.
Reggio Calabria di Fabrizio D'Agostini interessa in questa sede non per il suo oggetto primario, che ò la rivolta, ma per alcune notazioni nuove, o prese di coscienza che dir si voglia, da parte dell'intellettuale militante nella sinistra tradizionale a proposito della politica da questa condotta nel Meridione.
Nel lavoro di D'Agostini c'è l'esplicito riconoscimento della sovrapposizione forzata di formule estranee alla realtà di classe nel Meridione, e della incapacità di avere consapevolezza della frattura tra classe lavoratrice meridionale e organismi politici. Ce insomma molta della tematica dei Quaderni. Mancano logicamente le nostre conclusioni e c'è, al contrario, la posizione attivistica e moralistica di alcuni intellettuali settentrionali vicini a «giovane critica» e a «Il manifesto», la quale non è riuscita a depurarsi del vizio italiano per cui il Sud, anche il Sud proletario, è un oggetto da amministrare da parte di coloro che hanno virtute e conoscenza. Al prode garibaldino, ai reali carabinieri, all'intrepido bersagliere, al buon Turati, all'accorto Togliatti si sostituiranno degli affabili predicatori e dei missionari in camicia rossa?
Ho letto con estremo interesse — e mi permetterei di consigliarne la lettura a chiunque operi politicamente nel Meridione — il lucido articolo di Carlo Donolo, al quale va il merito di una chiara sistemazione di molte delle tematiche elaborate dal marxismo meridionale nel corso dei cinque anni trascorsi.
Esporre il contenuto dell'articolo comporterebbe, a causa della sua densità, molto più spazio di quanto l'opportunità suggerisca in questa sede. Cercherò pertanto di fissare solo alcuni punti di consenso — essendo essi molti, appunto perché lo scritto recepisce (per via indiretta credo) molti dei tempi di cui ci siamo interessati — e i punti di dissenso.
Intanto è aperto e senza riserve il riconoscimento del rapporto dipendente che pesa sul Meridione. Nascono da questo, per il proletariato meridionale, una diversa condizione e una diversità della «controparte sociale», rispetto alla classe lavoratrice settentrionale. L'acquisizione tende tuttavia a diluirsi in una articolazione e catalogazione sociologica — per altro non esotica e posticcia — della classe lavoratrice, nella quale la divaricazione di interessi e di comportamenti, tra quelle forze che abbiamo chiamato proletariato interno e proletariato esterno, viene attenuata. Tale atteggiamento spiega come l'autore giustifichi l'assenza di potere politico e la mancanza di coerenza nell'azione del proletariato esterno con oggettive difficoltà di aggregazione. L'argomentazione si presta ad essere capovolta: sono gli indirizzi storicamente consolidati dei partiti della classe, la strategia coesistenzialista del proletariato interno ad impedire l'aggregazione del proletariato esterno meridionale, la quale ovviamente potrebbe avvenire solo al di fuori del sindacato e del riformismo parlamentare.
Molto interessante e appropriata mi pare poi l'utilizzazione di alcune categorie marxiane e di nuove categorie, come forza-lavoro femminile scoraggiata e inoccupazione giovanile, per la definizione dell'articolazione di classe nel Meridione. Non mi pare invece accettabile la definizione di Donolo a proposito di proletarizzazione. Per noi il fenomeno proletarizzazione va individuato in un momento precedente ed indipendente dalla creazione del legame salariale. Senza volere impostare una disputa metodologica, credo che l'unico modo politicamente utile di individuare il sorgere della condizione proletaria sia quello che lo fa coincidere con l'espulsione del lavoratore da una precedente forma di produzione; anche se condivido — ed ho già espresso altrove tale giudizio — la restrizione operata da Donolo circa la posizione dell'intellettuale meridionale socialmente declassato.
Di grande utilità politica è anche l'enucleazione della categoria «massa marginale» nell'ambito del quadro proletario. In effetti l'entità numerica di tale settore è molto estesa nell'agricoltura meridionale, specie al di sopra di certe classi d'età. Dico d'utilità politica, perché ove si operi nell'ambito degli schemi politici propri alla tradizione operaia settentrionale, questa massa resterebbe tagliata fuori da qualsivoglia valorizzazione nello scontro di classe. Non così invece se dalla logica operaista si sale a quella popolare e proletaria nella sua eccezione «periferica». Quella massa infatti se non ha niente da dire contro il potere e lo sfruttamento della Fiat, avrebbe invece un suo ruolo non secondaria quando la si opponesse al parassitiamo del potere e dell'assistenza nel Meridione.
Il problema ci porta direttamente al tema centrale delle elaborazioni di Donolo, che individua nella polarizzazione demografica nei centri urbani meridionali la nuova ubicazione delle maggiori contraddizioni maturate nel Sud. E' necessario a questo proposito osservare che la richiesta di identità storica e politica, riconosciuta dallo stesso Donolo, nasce evidentemente da una specificità meridionale dello scontro di classe. Il proletariato meridionale ha un nemico immediato e visibile da combattere. Se questa controparte viene identificata con chiarezza, il problema si concretizza, come già si è osservato, nella esigenza che il proletariato meridionale non sia ridotto a comportarsi come la coda spezzata dal corpo della «classe operaia centrale», ma si elevi a protagonista della propria liberazione dal sistema capitalistico.
La controparte visibile è quel «nuovo strato di professionisti», di impiegati, di gestori del potere statale e dei suoi apparti, di politici di tutte le estrazioni, la cui presenza garantisce la stabilità del sistema italiano e attraverso cui passa l'espropriazione che il «centro» opera ai danni della «periferia».
Il Meridione, nell'esprimere una richiesta di sviluppo esprime una richiesta di socialismo, poiché non esiste al tra via per tagliare il rapporto «dipendente». La nostre richiesta di uscire dalla «deprivazione relativa» sta nella coscienza che non è possibile, né soprattutto conveniente a Meridione percorrere con cento anni di ritardo la via occidentale al benessere, fondamentalmente squilibrata, forte mente alienante, in se stessa disumana. Il socialismo meridionale, nella misura in cui è rimasto. «ottuso ruralismo» ha una sua profonda richiesta di umanesimo e di internazionalismo da difendere.
In effetti il «separatismo» di cui mi incolpa Zito nelle scritto già ricordato è per la verità molto di più: è una separazione netta fra due vie al socialismo, forse del tutto due modi di intendere il socialismo, probabilmente non inconciliabili alla distanza, ma che per adesso si muovono su piani diversi.
Nicola Zitara

Ai
sensi della legge n.62
del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.